si ok ma mi devi dare un po di tempo
attenti un'oretta per favore
TUCIDIDE PRIMO LIBRO LA GUERRA DEL PELOPONNESO
Buon pomeriggio a tutti 
Sono nuova di qui, e avrei bisogno di una versione di greco di tucidide, La guerra del Peloponneso!
Mi servirebbe la traduzione del primo libro:
qualcuno potrebbe darmela??
Vi ringrazio anticipatamente
E coglo l'occasione per augurare a tutti voi un buono studio!
Sono nuova di qui, e avrei bisogno di una versione di greco di tucidide, La guerra del Peloponneso!
Mi servirebbe la traduzione del primo libro:
qualcuno potrebbe darmela??
Vi ringrazio anticipatamente
E coglo l'occasione per augurare a tutti voi un buono studio!
- nuovo iscritto

Risposte:
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
- Site Admin
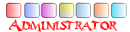
Perfetto, grazie mille Giada
Posso aspettare un'ora tranquillamente
Posso aspettare un'ora tranquillamente
- nuovo iscritto

traduzione del Libro Primo DELLA guerra del peloponneso di Tucidide
1. Tucidide d'Atene descrisse la guerra tra Peloponnesi e Ateniesi, come combatterono fra loro. Mise subito mano alla stesura dell'opera, dallo scoppio della guerra, che prevedeva sarebbe stata grave, anzi la più degna di memoria tra le precedenti. Lo deduceva dal fatto che i due popoli vi si apprestavano all'epoca della loro massima potenza e con una preparazione completa osservava inoltre il resto delle genti greche schierarsi con gli uni o con gli altri, chi immediatamente, chi invece meditando di farlo. Fu senza dubbio questo l'evento che sconvolse più a fondo la Grecia e alcuni paesi barbari: si potrebbe dire addirittura che i suoi effetti si estesero alla maggior parte degli uomini. Infatti, sugli avvenimenti che precedettero il conflitto e su quelli ancor più remoti era impossibile raccogliere notizie sicure e chiare, per il troppo distacco di tempo; ma sulla base dei documenti, cui l'indagine più approfondita mi consente di prestar fede, ritengo che non se ne siano verificati di considerevoli, né sotto il profilo militare, né per altri rispetti.
2. E risulta infatti evidente che la terra chiamata ai nostri giorni Grecia non era in tempi antichi abitata stabilmente, ma in principio vi si succedevano migrazioni e le singole genti, premute da popoli di volta in volta più numerosi, abbandonavano con facilità le loro sedi. Non vi era commercio; né esistevano relazioni reciproche sicure per terra o attraverso il mare. Ciascuno lavorava il proprio podere quant'era necessario a ricavarne il vitto: senz'accumulo di capitale e senza coltivare piantagioni, nel dubbio che una volta o l'altra qualche nuovo venuto li depredasse con improvvisa aggressione, poiché, tra l'altro, non si fortificavano con mura. Inoltre, convinti di poter ottenere dovunque il cibo di volta in volta sufficiente per un giorno, mutavano residenza senza difficoltà. Perciò non possedevano la potenza costituita dalle città grandi e dagli altri dispositivi militari. In particolare erano i territori migliori di questo paese a subire l'avvicendarsi continuo degli abitanti: la regione che ora ha nome Tessaglia, la Beozia e gran parte del Peloponneso, tranne l'Arcadia; del resto, quelle terre che erano più fertili. Infatti, l'accrescersi in alcune genti della loro potenza, in virtù del suolo eccellente, era motivo al loro interno di discordie che ne causavano naturalmente la rovina. Al tempo stesso, erano esposti agli attacchi anche più insidiosi delle popolazioni straniere. L'Attica, ad esempio, per la povertà del suolo fu abitata per lunghissimo tempo sempre dal medesimo popolo. Ed ecco la prova più determinante a sostegno del mio ragionamento, che proprio per le migrazioni le altre genti greche non sono pervenute a un pari progresso: dai diversi luoghi della Grecia, esuli per un conflitto o per una sedizione intestina, gli uomini più ragguardevoli ricorrevano agli Ateniesi, certi di godervi un saldo rifugio. Fatti membri della città, fino dagli antichi tempi contribuirono a renderla via via maggiore per numero d'uomini: cosicché in seguito, non bastando più il territorio dell'Attica, Atene mandò fino nella Ionia le sue colonie.
3. A parer mio, dimostra la debolezza degli antichi stati anche la considerazione seguente, certissima: prima dei fatti di Troia, è evidente che la Grecia non ha saputo mai riunire le proprie forze e dirigerle a un'impresa comune. Mi pare anzi che neppure tutta possedesse ancora il nome attuale e che nell'epoca precedente ad Elleno, figlio di Deucalione, tale appellativo non esistesse nemmeno. Furono invece singole genti, sembra, e soprattutto i Pelasgi a fornire di volta in volta il proprio nome a tratti sempre più ampi del paese. Quando crebbe nella regione di Ftia la potenza d'Elleno e dei suoi, accadeva di frequente che gli altri stati li chiamassero, bisognosi d'aiuto. Fu allora che in ognuno di questi paesi, per effetto di tali relazioni, a mio vedere, si diffuse progressivamente il nome di Elleni; ma non poté affermarsi né a lungo né sul complesso delle stirpi greche. Lo testimonia manifestamente Omero: infatti, vissuto molto più tardi della guerra di Troia, non accomunò mai, in nessun punto della sua opera, tutti gli Elleni sotto questo nome, né lo conferì ad altri, eccettuati quelli che provennero dalla Ftiotide al seguito di Achille e che invero erano gli Elleni originari. Nei suoi versi nomina i Danai gli Argivi e gli Achei. In effetti non ha mai neppure espresso il nome di barbari in quanto, a mio , neanche i Greci erano ancora contraddistinti, in antitesi, con un unico appellativo. Dunque, quelli ché singolarmente, una città dopo l'altra, nei limiti di quanti si comprendevano tra loro, e più tardi nel loro complesso ebbero nome di Greci, non si collegarono mai prima della guerra troiana per organizzare uno sforzo comune, per l'inconsistenza politica e l'assoluta mancanza di reciproci rapporti. Ma anche per questa famosa spedizione si riunirono quando avevano già acquistato maggiore dimestichezza con il mare.
, neanche i Greci erano ancora contraddistinti, in antitesi, con un unico appellativo. Dunque, quelli ché singolarmente, una città dopo l'altra, nei limiti di quanti si comprendevano tra loro, e più tardi nel loro complesso ebbero nome di Greci, non si collegarono mai prima della guerra troiana per organizzare uno sforzo comune, per l'inconsistenza politica e l'assoluta mancanza di reciproci rapporti. Ma anche per questa famosa spedizione si riunirono quando avevano già acquistato maggiore dimestichezza con il mare.
4. Minosse fu il più antico, tra quanti conosciamo per tradizione orale, a procurarsi una flotta e a dominare la parte più estesa del mare detto attualmente greco. Resse le isole Cicladi e ne colonizzò per primo il maggior numero, dopo averne espulsi i Cari e avervi preposto come governatori i suoi figli. Naturalmente cercava, per quanto era in suo potere di spazzar via dalle rotte marittime la pirateria per agevolare l'afflusso dei suoi tributi.
5. Infatti i Greci antichi e i barbari, che sul continente vivevano in località costiere, o abitavano le isole, dopo che presero con più stabilità e frequenza a trafficare tra loro per nave tendevano all'esercizio della pirateria. Li capeggiavano le personalità più in vista, per lucro privato e per reperire il cibo necessario agli individui più deboli del loro popolo. Assalivano centri sforniti di mura difensive, costituiti di villaggi sparsi e li mettevano a sacco: le loro risorse vitali provenivano essenzialmente da questa attività, che mentre non aveva ancora in sé nulla di indecoroso, costituiva piuttosto il mezzo per procurarsi una discreta rinomanza. Ne fanno fede alcune popolazioni del continente, che ancora ai nostri tempi si onorano di praticare con successo questa professione e i poeti antichi, che mettono invariabilmente in bocca ai loro eroi, in qualsiasi approdo sbarchino, la domanda: "siete pirati?"; e gli interrogati non suscitano affatto l'impressione di disprezzare un'attività simile, né pare che la giudichino indegna quelli che esigono una risposta. Anche sulla terraferma praticavano un brigantaggio reciproco. E ancora oggi, in molte terre di Grecia, la vita si svolge con queste antiquate consuetudini: nel paese dei Locri Ozoli, ad esempio, degli Etoli e degli Acarnani e nei territori circostanti. In particolare dall'antico uso della pirateria s'è inveterato in questi abitatori del continente il costume d'indossare sempre le armi.
6. Poiché era abitudine un tempo in Grecia che tutti circolassero armati: le abitazioni non fortificate, i reciproci rapporti irti di rischi avevano imposto l'abitudine di passare la vita in armi, al modo dei barbari. Queste terre greche, dove ancora oggi si vive con il sistema antico, sono indizio di costumanze simili in vigore un tempo e generalmente estese. Primi gli Ateniesi deposero l'uso di camminare armati: con modi di vita sciolti dal rigido tenore antico, divennero meno austeri, più delicati. Per questa preziosa raffinatezza, non è molto da che i rappresentanti più anziani delle classi facoltose hanno smesso d'indossare lunghi chitoni in lino e d'intrecciare alla sommità del capo con cicale d'oro il nodo dei capelli. Pertanto anche tra gli Ioni i più vecchi per la loro parentela con gli Ateniesi, mantennero a lungo questa moda. Furono i primi gli Spartani ad adottare un sistema di vestire misurato e semplice, moderno: anche per quanto concerne gli altri aspetti della vita i più abbienti generalmente si mantennero allo stesso livello del popolo. Gli Spartani furono anche i primi a spogliarsi e, mostrandosi nudi in pubblico, a spalmarsi con abbondanza d'olio in occasione degli esercizi ginnici. In antico invece, anche alle Olimpiadi, gli atleti gareggiavano con una cintura sui fianchi, e non è gran tempo che quest'uso si è estinto. Ancora oggi vige presso alcune genti barbare, specie in Asia, la pratica di istituire gare di pugilato e di lotta in cui gli atleti si affrontano muniti di cintura. Si potrebbe provare che anticamente in Grecia si adottava, sotto molti e svariati aspetti, un regime di vita analogo a quello dei barbari del nostro tempo.
7. I centri in cui gli abitanti, ormai molto sicuri nelle comunicazioni marittime, si insediarono più di recente, dotati di più consistenti risorse economiche, venivano fondati per lo più lungo i litorali e fortificati con mura. Si cercava inoltre di occupare gli istmi per praticare agevolmente i propri traffici e contrapporsi di potenza ai rispettivi confinanti. Le città antiche, per contro, timorose della pirateria, fiorita per lungo tempo, si edificavano piuttosto lontano dal mare, sia quelle isolane, che le continentali. (Poiché i pirati compivano incursioni reciproche, rivolgendole anche contro quelli che pur non praticando il mare erano rivieraschi). Ancor oggi questi centri si trovano all'interno.
8. Particolarmente dediti alla pirateria erano gli isolani, vale a dire Cari e Fenici. Costoro possedevano la maggior parte delle isole. Eccone la prova: quando Delo fu sottoposta dagli Ateniesi, nel corso di questa guerra, alla purificazione rituale e furono asportate le tombe di quanti erano deceduti sull'isola, apparve chiaro che per più della metà si trattava di Cari. Si riconobbero dalla fattura delle armi sepolte con i cadaveri e dal sistema di inumazione, in vigore ancor oggi. Affermatasi la forza navale di Minosse, i rapporti per mare si infittirono: i pirati delle isole ne furono espulsi, mentre egli veniva colonizzandone la maggior parte. Gli abitatori delle regioni litoranee, già più decisi ad accrescere i loro capitali, sempre più consolidavano le proprie sedi: alcuni poi, accortisi di diventar via via più facoltosi, si cingevano di mura. Per desiderio di lucro i più deboli si assoggettavano al servizio dei più forti, mentre i più potenti, ricchi a profusione, si annettevano le città minori. Progredivano già da qualche tempo in tale regola di vita quando, più tardi, i Greci si accinsero alla campagna di Troia.
9. A mio vedere, Agamennone riuscì a raccogliere il corpo di spedizione perché eccelleva in potenza tra i contemporanei, non certo sollecitando i pretendenti di Elena con il giuramento che li vincolava a Tindaro. Quelli che hanno accolto, tramandate oralmente dai loro antichi, le notizie più certe sulle vicende del Peloponneso, affermano che Pelope dapprima ottenne una notevole potenza politica, mettendo a frutto le enormi somme di denaro che recò con sé trasferendosi dall'Asia in un paese abitato da uomini indigenti, e riuscì inoltre a imporre, sebbene forestiero il proprio nome su quella terra. In seguito, i suoi discendenti si sarebbero impossessati di una potenza anche più rilevante, quando Euristeo perì in Attica, per mano degli Eraclidi. Euristeo, per il tempo che fosse durata la sua spedizione, aveva affidato ad Atreo, che gli era zio materno e quindi parente, Micene e il regno Atreo si trovava ad esser profugo, temendo il padre a causa dell'assassinio di Crisippo). Sostengono che siccome Euristeo non fece mai più ritorno, Atreo ottenne la successione al regno su volere degli stessi Micenei, in ansia per un'eventuale rappresaglia degli Eraclidi, e poiché s'era creato fama di uomo capace, conquistando le simpatie di quel popolo e degli altri già soggetti ad Euristeo. Così i Pelopidi riuscirono più potenti dei Perseidi. Sono convinto che Agamennone, ricevuto in eredità il regno e più potente sul mare di tutti gli altri, abbia effettuato la spedizione raccogliendone i componenti piuttosto con il severo rispetto che sapeva imporre che in virtù d'una affettuosa benevolenza. È indubitabile infatti che egli partì per Troia con un numero di navi superiore agli altri, e che ne fornì agli Arcadi: lo ha dimostrato Omero, se la sua testimonianza ha valore. Inoltre, narrando la "trasmissione dello scettro" ha lasciato detto che Agamennone su isole molte signoreggiava e su Argo tutta. Senza dubbio, vivendo sul continente, non avrebbe potuto tenere soggette le isole, oltre a quelle prossime alla costa, che non sarebbero molte, se non avesse disposto di una flotta discretamente forte. Anche da questa spedizione si deve dedurre l'entità di quelle che la precedettero.
10. La circostanza che Micene fosse un piccolo nucleo urbano, o se qualche altro centro dei tempi antichi destasse attualmente l'impressione d'essere stato insignificante, non costituirebbe una prova decisiva per chi nutrisse dubbi sull'importanza della spedizione, quale l'hanno magnificata i poeti e la tradizione ancora la celebra. Poiché se la città degli Spartani restasse deserta e rimanessero i templi e le fondamenta degli edifici, penso che dopo molto tempo sorgerebbe nei posteri un'incredulità forte che la potenza spartana fosse adeguata alla sua fama; (eppure occupano i due quinti del Peloponneso, detengono l'egemonia su di esso e su numerosi alleati esterni: tuttavia raccogliendosi la città intorno ad un unico nucleo privo di templi e costruzioni sontuose, con la sua caratteristica struttura in villaggi sparsi, secondo l'antico costume greco, parrebbe una mediocre potenza). Se gli Ateniesi invece subissero la stessa sorte, la loro importanza, a dedurla dai resti visibili della città, si supporrebbe, credo, doppia di quella reale. Non conviene dunque dubitare, né attribuire maggiore rilievo all'esame degli aspetti esteriori delle città che della loro effettiva potenza; ci si deve convincere che quella spedizione fu la più importante tra quante la precedettero, ma inferiore alle attuali, se pure da questo lato dobbiamo prestar fede all'ispirazione poetica di Omero, che da poeta appunto, com'è naturale, l'ha esaltata e abbellita; tuttavia, anche così, è evidente che fu inferiore. Infatti, di milleduecento navi, il poeta ha descritto quelle dei Beoti come fornite di centoventi uomini d'equipaggio ciascuna, quelle al comando di Filottete di cinquanta, volendo indicare, a mio , le maggiori e le minori: e infatti relativamente alla portata delle altre non fece parola nel catalogo delle navi. Che poi i rematori fossero tutti anche combattenti l'ha significato chiaro, citando le navi di Filottete; poiché gli uomini ai remi li ha fatti tutti arcieri. Non è verosimile che fossero imbarcati molti passeggeri non addetti alla manovra, tranne i principi e i personaggi più autorevoli soprattutto considerando che li attendeva una traversata lunga e con macchine da guerra: inoltre, i navigli non erano coperti da ponti, ma armati alla corsara, secondo l'uso antico. Se si calcola dunque la media tra le navi minori e le più capaci, risulta chiaro che non presero il mare in molti, considerato che erano inviati da tutti i paesi di Grecia.
, le maggiori e le minori: e infatti relativamente alla portata delle altre non fece parola nel catalogo delle navi. Che poi i rematori fossero tutti anche combattenti l'ha significato chiaro, citando le navi di Filottete; poiché gli uomini ai remi li ha fatti tutti arcieri. Non è verosimile che fossero imbarcati molti passeggeri non addetti alla manovra, tranne i principi e i personaggi più autorevoli soprattutto considerando che li attendeva una traversata lunga e con macchine da guerra: inoltre, i navigli non erano coperti da ponti, ma armati alla corsara, secondo l'uso antico. Se si calcola dunque la media tra le navi minori e le più capaci, risulta chiaro che non presero il mare in molti, considerato che erano inviati da tutti i paesi di Grecia.
11. Era causa di ciò non tanto il ristretto numero d'uomini, quanto la scarsità di denaro. In effetti, il problema dei rifornimenti li indusse a mobilitare un contingente di spedizione ridotto: nei limiti di quanti calcolavano che avrebbero ricavato laggiù con l'attività di guerra i mezzi per vivere. Arrivati nella regione di Troia, riuscirono vincitori in un primo scontro (è sicuro, in quanto non avrebbero potuto, in caso diverso, rafforzare con il vallo il loro attendamento): pure è noto che neppur là, nella piana di Troia, abbiano utilizzato al completo i loro effettivi. Urgeva la necessità di vettovaglie, quindi si dettero all'agricoltura nel Chersoneso, e a praticar la pirateria. Onde, per il frazionamento delle forze nemiche, i Troiani resistettero ancor più validamente per quei dieci celebri anni, disponendo sempre di truppe numericamente pari a quelle greche che, di volta in volta, rimanevano ad affrontarli sul campo. Di contro, se i Greci fossero giunti già forniti di riserve alimentari adeguate, quindi in blocco, senza disperdersi chi facendo il predone, chi l'agricoltore, avessero protratto senza interruzione il loro sforzo bellico superiori com'erano negli scontri in campo, avrebbero conquistato la città agevolmente: essi che, senza mai fronteggiarlo compatti, erano sempre in grado di contrastare il nemico con la parte di truppe ch'era di volta in volta presente e che, serrando Troia di continuo assedio, l'avrebbero presa in tempo più breve e con minori fatiche. Al contrario, per esiguità di risorse economiche, non solo risultavano irrilevanti le imprese anteriori, ma queste stesse gesta, le più celebri tra quelle condotte prima, appaiono in realtà impari alla fama che ne nacque e alla memoria che fra noi sopravvive ancora, per il canto dei poeti.
12. E infatti, anche dopo l'impresa troiana, la Grecia andava soggetta a continui movimenti migratori e di colonizzazione, sicché mancante di una pacifica stabilità, non progredì in potenza. Infatti, il ritorno dei principi da Troia avvenuto così tardivo, introdusse molti mutamenti, mentre nelle città soprattutto fiammeggiavano sedizioni e rivolte, con la conseguenza che i profughi ne uscivano fondando nuovi centri di abitazione. In tal modo, gli attuali Beoti, nel sessantesimo anno dalla conquista di Troia, scalzati da Arne per opera dei Tessali si stanziarono nella moderna Beozia, denominata in antico "Paese di Cadmo" (in questa terra, in tempi lontani, viveva già un loro nucleo, e di là avevano mandato un loro reparto a combattere sotto le mura di Troia): analogamente i Dori, nell'ottantesimo anno, occuparono il Peloponneso, guidati dagli Eraclidi. Faticosamente e dopo gran tempo in Grecia si stabilì una situazione di pace sicura, senza interne scosse migratorie: si cominciarono a mandar gruppi di coloni. Gli Ateniesi colonizzarono la Ionia e il maggior numero di isole; quelli del Peloponneso le parti più estese della Sicilia e dell'Italia, insieme ad alcune località della restante Grecia. Queste fondazioni si effettuarono tutte dopo le vicende di Troia.
13. Aumentando in progressione la potenza dei Greci che si impegnavano con sforzo ancor più sollecito di prima ad accumulare le loro rendite, presero piede in numerosi stati, in relazione alla crescita della loro ricchezza, le tirannidi (anteriormente invece vigevano monarchie ereditarie, limitate da certe prerogative): i Greci inoltre armavano flotte ed esercitavano più decisamente la marineria. Corre fama che siano stati i Corinzi a introdurre migliorie tecniche nella fabbricazione delle navi, avvicinandole di molto al livello moderno, e che le prime triremi, in Grecia, uscissero appunto dai cantieri di Corinto. Pare anzi accertato che Aminocle di Corinto, un costruttore navale, abbia fabbricato quattro navi per quelli di Samo. Saranno circa trecento anni alla fine di questa guerra, da che Aminocle giunse a Samo. Il più antico scontro sul mare di cui siamo al corrente è quello tra Corinzi e Corciresi: a computare fino alla medesima data, saranno all'incirca duecentosettanta anni. Dunque i Corinzi con la loro città situata proprio sull'istmo, costituirono sempre, fin da epoche remote, uno scalo commerciale: poiché i Greci antichi all'interno del Peloponneso e quelli esterni trafficavano tra loro per terra più che per mare, percorrendo di necessità il loro istmo; così i Corinzi erano diventati una potenza economica, come mostrano anche gli antichi poeti: attribuirono infatti alla località l'epiteto di "doviziosa". In seguito, quando i Greci incrementarono i negozi marittimi, quelli di Corinto, allestite parecchie navi, si volsero a sterminare i pirati e potendo offrire per mare e per terra un punto di smistamento al traffico commerciale, fecero poderosa l'economia del loro stato con l'afflusso di rendite. Anche gli Ioni dispongono in seguito di una flotta consistente, all'epoca di Ciro, primo sovrano dei Persiani, e del figlio Cambise; in lotta con Ciro dominarono per qualche tempo il tratto di mare che è loro antistante. Pure Policrate, tiranno di Samo al tempo di Cambise, forte di una buona flotta, non solo ridusse in suo potere le altre isole, ma consacrò anche Reneia, dopo la sua conquista, ad Apollo di Delo. I Focesi poi, durante la fondazione della loro colonia Marsiglia, misero in rotta in uno scontro navale i Cartaginesi.
14. Le flotte più poderose erano dunque queste. Risulta però che, per quanto di molte generazioni più recenti rispetto alla guerra di Troia, utilizzassero anch'esse poche triremi e avessero in organico, come quelle arcaiche, essenzialmente scafi a cinquanta remi e navigli lunghi. Poco avanti le guerre persiane e la morte di Dario, che regnò in Persia dopo Cambise, i tiranni di Sicilia, ebbero a disposizione un numero considerevole di triremi, come i Corciresi; e infatti queste furono le ultime flotte degne di ricordo in Grecia, prima dell'assalto di Serse. Gli abitanti di Egina infatti e gli Ateniesi, con altri pochi, erano in possesso di scarse flottiglie, in massima parte composte di navi a cinquanta rematori. Solo più tardi, quando gli Ateniesi erano in guerra contro gli Egineti, Temistocle riuscì a convincerli, anche nel timore che fosse imminente l'aggressione del popolo persiano, ad allestire triremi, con le quali poi effettivamente avrebbero combattuto: ma anche queste erano sfornite di ponti, a proteggere intera la lunghezza dello scafo.
15. Tale si presentava l'entità delle potenze navali greche: le più antiche e quelle sorte in epoche più recenti. Comunque, chi poteva esercitare la marineria, si creò una considerevole potenza, non solo in entrate economiche, ma anche in supremazia sugli altri. Spostandosi con la flotta, sottomettevano a tributo le isole, che costituivano uno sbocco particolarmente ricercato da quelli che non possedevano territorio sufficiente. Conflitti terrestri invece, da cui potesse nascere qualche rispettabile potenza, non se ne effettuarono: si trattava in complesso, quante se ne verificavano, di guerricciole impegnate con i propri vicini di confine; ma vere e proprie campagne. militari, molto lontane dal proprio paese e a scopo di dominio, i Greci non usavano organizzare. Perché non esistevano città che si fossero affiancate in soggezione a stati più potenti: nemmeno pensavano di sostenere, a condizioni di parità, spedizioni comuni; pertanto le singole genti preferivano guerreggiare coi propri vicini. In occasione tuttavia di un antico conflitto esploso tra Calcidesi e quelli di Eretria, anche le altre popolazioni greche si trovarono divise, alleandosi chi con l'uno chi con l'altro belligerante.
16. In vari paesi di Grecia intervennero diversi fattori negativi, che ne interruppero il progresso. Anche presso gli Ioni, per addurre un esempio: la loro potenza era già discretamente avanzata, quando Ciro con il regno di Persia, dopo aver abbattuto Creso e assoggettato il paese che si stende tra il fiume Alis e il mare, mosse loro guerra e soggiogò le città sul continente. Inoltre Dario, tempo dopo, forte della flotta fenicia, asservì le isole.
17. I tiranni, quanti v'erano nelle città greche, con lo sguardo egoisticamente teso al personale interesse, all'incolumità fisica oltre che al crescente prestigio della propria casata, preferivano dedicarsi, fin tanto ch'era loro possibile e per evidenti ragioni di sicurezza, alle questioni di politica interna, ciascuno nel chiuso delle proprie città: nessuna impresa pertanto fu da loro diretta, che fosse degna di memoria eccettuata forse qualche incursione a spese delle genti limitrofe. Non certo i tiranni di Sicilia, che invece conquistarono una grande potenza. In tal modo, da ogni parte e per lungo tempo, la Grecia si trovò praticamente preclusa la via a qualunque impresa veramente apprezzabile, poiché le città, singolarmente prese, mancavano di spirito d'iniziativa.
18. I tiranni d'Atene e quelli delle altre parti di Grecia, soggetta anche prima di Atene e in varie località alle tirannidi, furono abbattuti finalmente, per la maggior parte, eccetto quelli in Sicilia, dagli Spartani. (Poiché Sparta, dopo la sua fondazione ad opera di quei Dori che attualmente l'abitano, pur sconvolta da interni fermenti per il periodo di tempo più esteso di cui s'abbia storicamente memoria, pure fin dall'antichità godette per la concordia delle sue componenti politiche una temperata costituzione e in seguito fu sciolta sempre dalla tirannide: son corsi quattrocent'anni circa e poco più fino alla conclusione di questo conflitto, da quando gli Spartani adottano, immutato, quell'ordinamento politico. Fatti possenti da questa salda coesione interna stabilivano anche le forme di governo nelle altre città). Dopo l'espulsione dei tiranni dalla Grecia, dicevamo, trascorsi non molti anni si combatté a Maratona tra Persiani e Ateniesi. Passan dieci anni, e una seconda volta lo straniero cala in Grecia con quell'esercito sconfinato, deciso a soggiogarla. Il pericolo immineva gravissimo: gli Spartani, che eccellevano per potenza militare, si assunsero il comando dei Greci, serrati in alleanza a respingere il nemico. Per parte loro gli Ateniesi, mentre avanzava l'aggressione persiana. decisero di abbandonare del tutto la città raccolsero i loro beni di fortuna e si imbarcarono sulle navi da guerra: si fecero così esperti del mare. Respinto lo straniero con sforzo concorde, non passò molto che il fronte comune dei Greci, di quelli che si erano emancipati dal Gran Re e di quelli che ne avevano retto l'assalto, si spezzò in contrapposti blocchi, polarizzandosi l'uno intorno ad Atene l'altro a Sparta. Questi due stati disponevano evidentemente delle potenze maggiori: gli uni sulla terra, gli altri con la flotta. L'intesa fra loro non fu duratura. Presto i rapporti s'incrinarono. Spartani e Ateniesi entrarono in uno stato di guerra, con al fianco i rispettivi collegati. Gli altri Greci poi, se insorgevano contrasti, si inserivano nell'orbita dell'una o dell'altra potenza. Di conseguenza il periodo tra il conflitto persiano e questa guerra fu tutto un avvicendarsi continuo di tregue e di atti di ostilità reciproci o sferrati contro i propri alleati dissidenti: così i Greci raffinarono la tecnica delle azioni militari e, costretti all'esercizio ininterrotto tra effettivi pericoli, ne approfondirono la competenza.
19. Gli Spartani, esercitavano l'egemonia sugli alleati senza costringerli alla soggezione del tributo attenti solo a che i loro sistemi politici si conformassero ai precetti dell'oligarchia e riuscissero sostanzialmente di vantaggio solo alla loro città, Sparta. All'opposto, gli Ateniesi non solo requisivano via via le flotte dei paesi collegati, all'infuori di quelle di Chio e di Lesbo, ma imposero, in generale, il versamento di determinate quote. In effetti, le risorse e gli armamenti di cui disponevano preparandosi ad entrare in guerra superavano in potenza quelli del tempo in cui erano al fiorire del loro splendore e la loro coalizione non s'era ancora spezzata.
20. È questo il frutto delle indagini e dello studio, cui ho sottoposto i fatti antichi: materia difficile ad accertarsi, scrutando ogni singolo indizio e testimonianza man mano che si presentava. Poiché gli uomini in genere accolgono e tramandano fra loro, senza vagliarle criticamente anche se concernono vicende della propria terra, le memorie del passato. Ad esempio, la gente in Atene è convinta che Ipparco sia stato assassinato da Armodio e Aristogitone, mentre reggeva la tirannide e non è al corrente che era Ippia, primogenito dei figli di Pisistrato, a dominare e che Ipparco e Tessalo erano suoi fratelli. In quel giorno, e mentre proprio si accingevano all'azione, Armodio e Aristogitone furono colti dal sospetto che qualcuno del complotto li avesse denunciati ad Ippia. Si tennero quindi lontani da lui, convinti che fosse preavvertito. Ma pure desideravano, prima della cattura, por mano a qualche gesto esemplare, esporsi a qualche memorabile pericolo e imbattutisi in Ipparco che ordinava la processione Panatenaica nella località detta Leocorio, lo ammazzarono. Ma su numerosi altri particolari di vicende contemporanee, non ancora offuscati dal tempo, gli altri Greci non posseggono cognizioni chiare ed esatte. Sono persuasi, ad esempio, che i re Spartani dispongano ciascuno non di un voto, ma di due, e che presso di loro vi sia la schiera denominata Pitane, che in realtà non è mai esistita. Così intraprendono molti, con troppa leggerezza, la ricerca della verità, e preferiscono arrestarsi agli elementi immediati, che non esigono applicazione e studio.
21. Gli argomenti invece e gli indizi da me addotti assicurano la possibilità d'interpretare i fatti storici, quali io stesso ho passato in rassegna, con una certezza che non si discosta essenzialmente dal vero. Per questo, non ci si affidi piuttosto ai poeti, che nell'esaltazione del canto ampliano ogni particolare e lo fanno prezioso; insicure anche le opere dei logografi, composte più a diletto dell'ascolto, che a severa indagine della verità. Poiché si tratta di un campo di ricerca in cui la verifica è estremamente ardua: l'antichità stessa di questi casi ne ha velato i contorni di un favoloso, mitico alone. Si converrà che il prodotto delle mie ricerche, elaborato dall'analisi degli elementi di prova più sicuri e perspicui, raggiunge la sufficienza, se si considera la distanza di tempo che ci separa dagli eventi discussi. Questa guerra, sebbene di norma gli uomini valutino più grave il conflitto in cui sono di volta in volta impegnati, per poi, rivolgere, appena l'attuale è spento, la loro ammirazione ai fatti d'armi più antichi, risulterà sempre, a chi esamini la realtà con dati concreti, la più importante di tutte.
22. Per quanto concerne i discorsi pronunciati da ciascun oratore, quando la guerra era imminente o già infuriava, era impresa critica riprodurne a memoria, con precisione e completezza, i rispettivi contenuti; per me, di quanti avevo personalmente udito, e per gli altri che da luoghi diversi me ne riferivano. Questo metodo ho seguito riscrivendo i discorsi: riprodurre il linguaggio con cui i singoli personaggi, a parer mio avrebbero espresso nelle contingenze che via via si susseguivano i provvedimenti ritenuti ogni volta più opportuni. Ho impiegato il massimo scrupolo nel mantenermi il più possibile aderente al senso complessivo dei discorsi effettivamente declamati. Ho ritenuto mio dovere descrivere le azioni compiute in questa guerra non sulla base di elementi d'informazione ricevuti dal primo che incontrassi per via; né come paresse a me, con un'approssimazione arbitraria, ma analizzando con infinita cura e precisione, naturalmente nei confini del possibile, ogni particolare dei fatti cui avessi di persona assistito, o che altri mi avessero riportato. La boriosa e complessa indagine: poiché le memorie di quanti intervennero in una stessa azione, non coincidono mai sulle medesime circostanze e sfumature di quella. Da qui resoconti diversi, a seconda della individuale capacità di ricordo o delle soggettive propensioni. Il tono severo della mia storia, mai indulgente al fiabesco, suonerà forse scabro all'orecchio: basterà che stimino la mia opera feconda quanti vogliono scrutare e penetrare la verità delle vicende passate e di quelle che nel tempo futuro, per le leggi immanenti al mondo umano, s'attueranno di simili, o perfino d'identiche. Possesso per l'eternità è la mia storia, non composta per la lode, immediata e subito spenta, espressa dall'ascolto pubblico.
23. Delle antecedenti imprese, la più importante fu la guerra persiana: eppure si risolse rapidamente con due soli scontri navali e di fanterie. Questa guerra s'è trascinata invece a lungo, generando dolori e patimenti in Grecia, quali mai, in tale tratto di tempo, s'erano avuti. Mai tante città, travolte nel conflitto, languirono spopolate. Fu opera dei barbari per alcune, per altre degli stessi contendenti (non mancano esempi di città espugnate che mutarono i propri abitanti). Mai tanti profughi e tanto sangue, versato combattendo negli infiniti episodi di guerra o nelle lotte civili. Molti casi straordinari, trasmessi prima per tradizione orale, ma raramente verificati alla prova dei fatti, confermarono la loro indubbia esistenza: terremoti ad esempio, che sconvolsero zone molto ampie, intensificandosi con inusitata violenza. Eclissi solari che intervennero più frequenti di quelle accadute, a memoria d'uomo, nelle epoche andate. Certe siccità interminabili flagellavano talune contrade, onde carestie imperversanti, e quell'epidemia che tanta desolazione e lutto seminò per la Grecia: tutte sventure esplose parallele al decorso di questa guerra. La fecero scoppiare Ateniesi e Peloponnesi, abrogando i patti trentennali che avevano stipulato dopo l'occupazione dell'Eubea. Espongo dapprima le cause e gli attriti che produssero quest'atto d'abrogazione, perché nessuno debba più, in seguito, indagare le origini di questa guerra. Sono convinto che la motivazione più autentica, quella però che meno traspariva dai discorsi ufficiali, fosse la formidabile potenza conseguita da Atene e l'apprensione che ne derivava per Sparta: e la guerra fu inevitabile. Le ragioni invece, addotte nelle rispettive dichiarazioni rilasciate dai belligeranti, per la rottura dei patti e lo scoppio delle ostilità, erano le seguenti.
24. La città di Epidamno è situata alla destra di chi entri navigando nel golfo Ionio. Nei suoi dintorni hanno dimora i Taulanti, barbari di stirpe illirica. Questa località fu colonizzata dai Corciresi: ne fu fondatore e capo Falio, nato da Eratoclide, di schiatta Corinzia, dei discendenti da Eracle. Fu invitato a recarsi colà dalla madrepatria, in osservanza dell'antico costume. Presero parte alla colonizzazione anche alcuni tra i Corinzi e del resto delle genti doriche. Con il trascorrere del tempo, Epidamno si fece una città potente e popolosa. Dopo parecchi anni di lotte civili, come è fama, furono ridotti in rovina da una guerra sostenuta contro popolazioni barbare confinanti e la loro potenza declinò notevolmente. Negli ultimi tempi prima di questa guerra, la parte democratica aveva scacciato da Epidamno gli oligarchi, i quali, fiancheggiati dai barbari, fecero ritorno depredando quelli che erano rimasti in città, per terra e sul mare. Gli Epidamni che si trovavano in città, oppressi dalle continue violenze, spediscono una legazione a Corcira, come loro madrepatria: supplicano che non si assista inerti al loro massacro, che si cerchi di rimettere pace tra loro e gli esiliati, che si faccia cessare l'ostilità dei barbari. Queste le richieste avanzate dagli ambasciatori, postisi in atto di supplici davanti al tempio di Era. Il governo di Corcira non accolse la loro preghiera, rimandandoli senza aver rilasciato nessuna promessa concreta.
25. Quando gli Epidamni appresero che Corcira non avrebbe stanziato nessun aiuto per loro, non erano in grado di trovare un qualsiasi sbocco alle difficoltà presenti. Così mandarono dei legati a Delfi a consultare l'oracolo di Apollo, se dovessero consegnare la città ai Corinzi, come fondatori della colonia e tentare di ottener da loro una difesa. Il responso fu di affidarsi ai Corinzi, sottomettendosi fiduciosi alle loro direttive. Gli Epidamni si recarono dunque a Corinto secondo la volontà dell'oracolo e consegnarono la colonia avvalendosi del fatto che il loro fondatore era originario di Corinto e notificando il testo dell'oracolo: li pregavano di non tollerare senza far nulla il loro massacro, che accorressero a difenderli. I Corinzi si assunsero il compito della loro tutela, in parte per sentimenti di giustizia, riflettendo che la colonia in fondo apparteneva a loro non meno che ai Corciresi, ma più accesi di rancore nei confronti di quelli che, sebbene ne fossero coloni, non li rispettavano come si conveniva. Poiché in occasione delle grandi adunanze festive comuni non attribuivano loro i privilegi rituali e non offrivano la prima e scelta parte di ogni vittima sacrificale a un cittadino di Corinto, com'era regola per le altre colonie. Li trattavano inoltre con irriguardosa sufficienza, dacché in quel tempo disponevano di un potere economico pari alle città più ricche di Grecia, e militarmente, erano addirittura più preparati e forti. Quanto alla flotta, in qualche occasione si gloriavano d'esser superiori di molto, in relazione anche al fatto che i Feaci così celebri per la loro arte nautica, avevano avuto sede in Corcira (onde con tanto più impegno armavano la flotta e, in realtà, erano davvero potenti: al principio della guerra i Corciresi potevano contare su centoventi triremi).
26. Bruciando dunque di risentimento per le suddette ragioni i Corinzi furono lieti di inviare il contingente di soccorso ad Epidamno, incitando a recarvisi come coloro chiunque volesse, scortati da truppe di Ambracia, di Leucade e di Corinto stessa. I Corciresi quando conobbero che ad Epidamno affluivano coloni e scorte armate e che la colonia era stata consegnata ai Corinzi, s'irritarono. Posta rapidamente in mare una squadra di venticinque unità e poi un contingente ulteriore imponevano minacciosi agli Epidamni di riaccogliere gli esuli (i profughi di Epidamno si erano recati infatti a Corcira e, additando i sepolcri dei loro progenitori e con il ricordo dell'antica consanguineità, li avevano supplicati di ricondurli in patria). C'era l'ordine inoltre di licenziare le guarnigioni e i coloni mandati da Corinto. Gli Epidamni non prestarono orecchio a nessuna di tali richieste. I Corciresi allora con quaranta navi muovono contro di loro, coi profughi, decisi a restituirli in patria, e forti d'un corpo d'Illiri. Si attendarono davanti alla città proclamando che ne uscissero incolumi gli stranieri e chi volesse degli Epidamni; in caso contrario, li avrebbero tenuti per nemici. Nessun segno di risposta: i Corciresi si disposero ad assediare la città, collocata su un istmo.
27. I Corinzi, dal canto loro, quando li raggiunsero dei messaggeri da Epidamno con la notizia ch'erano stretti d'assedio, allestivano una spedizione e insieme facevano bandire una colonia ad Epidamno, promettendo uguaglianza di condizioni e di diritti a chiunque volesse recarvisi. Se poi uno lì sul momento non si trovava disposto alla partenza, ma desiderava prender parte alla colonia, restasse pure a casa, impegnando come cauzione cinquanta dracme corinzie. Così furono in molti a partire, e molti a depositare il denaro. Chiesero a quelli di Megara di scortarli con le loro navi temendo d'esser bloccati in mare dai Corciresi: e quelli si preparavano a seguirli con otto navi, e i Paleesi di Cefallenia con quattro. Ne richiesero anche agli Epidauri, ché ne fornirono cinque; gli Ermoniesi una e i Trezeni due; quelli di Leucade dieci e gli Ambracioti otto. Ai Tebani e ai Fliasi chiesero denaro, agli Elei denaro e navi senza ciurma. Le navi armate dai Corinzi erano trenta e i loro opliti tremila.
28. Giunta notizia di tali preparativi, i Corciresi si recarono a Corinto, accompagnati dagli ambasciatori spartani e di Sicione che avevano preso con sé e intimarono ai Corinzi di richiamare indietro le guarnigioni da Epidamno e i loro coloni, poiché Epidamno non era terra che li riguardasse. Se però i Corinzi ritenevano di poter avanzar qualche pretesa, erano disposti ad accogliere le decisioni di un arbitrato nel Peloponneso, presso la città su cui i contendenti si trovassero concordi. Riuscirebbe vincitrice quella delle due parti cui si decidesse di assegnare la colonia. Erano anche disposti a sottoporre la controversia all'oracolo di Apollo a Delfi. Erano decisi a non permettere la guerra: in caso diverso, si sarebbero visti costretti, dicevano, per la loro violenta condotta, a cercar di collegarsi con genti diverse dalle attuali alleate, e che a loro non piacevano, per ragioni di profitto. I Corinzi ribatterono: scenderebbero a trattati e solo a patto che fossero ritirati da Epidamno le navi e i contingenti barbari. Ma, in primo luogo, non era onorevole che gli uni subissero un assedio, e loro stessero a far discussioni. I Corciresi ripresero che solo se i Corinzi avessero richiamato da Epidamno i loro avrebbero accolto le proposte avanzate: erano anche pronti a questo, che le due parti rimanessero nelle posizioni occupate, si stilasse una tregua e si attendesse l'esito dell'arbitrato.
29. I Corinzi non accolsero nessuna delle proposte fatte, ma dopo che le loro navi furono fornite di equipaggi ed erano giunti gli alleati, mandarono subito avanti un araldo, con la dichiarazione di guerra ai Corciresi salpando con settantacinque navi e duemila opliti fecero rotta su Epidamno, per attaccare i Corciresi: erano strateghi della flotta Aristeo figlio di Pellico, Callicrate figlio di Callia e Timanore figlio di Timante, e dell'esercito Archetimo figlio di Euritimo e Isarchida figlio di Isarco. Quando quelli furono all'altezza di Azio nella regione Anattoria, dove è sito il santuario di Apollo, all'imboccatura del golfo di Ambracia, i Corciresi mandarono loro incontro su una scialuppa un araldo, intimando di non proseguire la navigazione contro di loro. Intanto però equipaggiavano le navi, riparando le vecchie, che erano in grado di tenere il mare, e altre che avevano allestite. Come l'araldo tornò a riferire che dai Corinzi non si aspettassero alcun segno di pace, e le loro navi furono pronte in numero di ottanta (quaranta infatti partecipavano all'assedio di Epidamno), si portarono a ridosso del nemico, e messisi in formazione, diedero battaglia. Vinsero nettamente i Corciresi: affondarono quindici navi nemiche. Quel giorno stesso si verificò un ulteriore vantaggio per loro: quelli che assediavano Epidamno avevano costretto la città alla resa con le condizioni seguenti: gli stranieri venduti schiavi, i Corinzi prigionieri in catene, fino a che intervenisse una decisione diversa.
30. Dopo lo scontro sul mare i Corciresi elevarono a Leucimma, che è un promontorio di Corcira, un trofeo; passarono per le armi tutti gli altri prigionieri catturati; i Corinzi invece furon posti in catene. In seguito, dopo che i Corinzi e gli alleati, sconfitti sul mare, tornarono ai loro paesi, i Corciresi restavano dominatori di quello specchio di mare, e messa la prua su Leucade, colonia di Corinto, ne devastarono il territorio e diedero fuoco a Cillene, porto militare degli Elei, in quanto avevano posto navi e denaro a disposizione dei Corinzi. Per quasi l'intero periodo che seguì lo scontro, i Corciresi ebbero la supremazia del mare e con la flotta da guerra infliggevano seri danni agli alleati dei Corinzi. Finché costoro l'estate successiva, mobilitando una flotta e un esercito, poiché i loro alleati si trovavano a mal partito, si attendarono ad Azio e presso Chimerio, un luogo della Tesprotide, per vigilare su Leucade e gli altri centri loro amici. Di contro anche i Corciresi posero il campo a Leucimma, con le navi e le truppe. Nessuna delle due parti prendeva l'iniziativa di un attacco: restarono accampati l'uno contro l'altro per tutta quell'estate e solo al sopraggiungere dell'inverno si ritirarono entrambi nei loro paesi.
31. Per l'intero anno che seguì lo scontro navale e per il successivo, i Corinzi, ardendo di rancore per l'esito del conflitto con Corcira, erano impegnati ad allestire navi e venivano armando una flotta che fosse forte il più possibile: per questo attiravano rematori, oltre che dal Peloponneso, dal resto della Grecia, promettendo una lauta paga. Le informazioni sui preparativi nemici suscitarono in Corcira uno stato d'allarme. Poiché non erano alleati con nessuna popolazione greca e non avevano aderito né alla coalizione ateniese né a quella spartana, presero consiglio di rivolgersi ad Atene, divenirne alleati, e tentare di ottenere di là una qualche forma di aiuto. I Corinzi informati di questa manovra, vennero anche loro ad Atene, in ambasceria, per vedere se fosse possibile impedire che alla flotta di Corcira si affiancasse anche quella ateniese, creando ostacoli alla conclusione della guerra, com'essi la desideravano. Di fronte all'assemblea convocata, posero a confronto le loro ragioni e i Corciresi, per primi, in tal modo le espressero.
32. "È cosa giusta, cittadini d'Atene, che chi ricorre al vicino con una preghiera di soccorso, come noi in questo momento, e non gode il credito di un importante beneficio reso da tempo o d'un patto d'alleanza precedentemente stretto, cerchi in primo luogo e soprattutto di chiarire a fondo che quanto richiede è anche di vantaggio agli interlocutori, in altro caso, almeno che non è loro di danno; poi, che la propria riconoscenza rimarrà incrollabile. Se non saprà porre nella più limpida luce questi assunti, non si sdegni poi del sicuro insuccesso. Quelli di Corcira ci hanno mandato a voi con la richiesta d'alleanza e intimamente persuasi di potervi garantire, in futuro, questi punti. In effetti, è risultato che il nostro tipo di atteggiamento politico non solo viene ora rivelando nei vostri confronti tutta la sua incongruenza rispetto alla richiesta che vi proponiamo, ma anche quanto sia di svantaggio a noi stessi, in questo particolare momento. Poiché noi, che fino ad ora non abbiamo mai gradito e accettato l'alleanza di nessuno, veniamo adesso da altri, proprio a richiederla. Non solo: nella presente guerra contro i Corinzi la nostra condotta ci ha fatti trovare isolati. Quel che prima giudicavamo prudenza, cioè il non sottoporci, alleandoci con genti estranee, ai loro medesimi rischi eseguendo i piani elaborati da un vicino, si chiarisce ora come dissennatezza e impotenza. Certo, nel precedente scontro navale abbiamo soverchiato i Corinzi con le nostre sole forze. Ma ora muovono contro di noi dal.Peloponneso e dal resto della Grecia con una potenza bellica ben più considerevole, da cui noi vediamo che non ci è possibile scampare, se restiamo isolati, con le nostre uniche risorse. Inoltre, è ben grave il pericolo per noi se cadremo in loro potere: perciò è indispensabile che noi chiediamo l'aiuto vostro o di chiunque altro. Ci si comprenda, se troviamo ora il coraggio di intraprendere un corso politico nuovo rispetto al precedente immobilismo, non per bassezza d'animo, ma nella coscienza che si è trattato di un errore di valutazione.
33. "Se vi lascerete persuadere, l'occasione della nostra richiesta vi sarà di vantaggio sotto molteplici riguardi. Principalmente, fornirete mezzi di soccorso a gente che subisce un'ingiustizia, non che la perpetra in danno altrui; in secondo luogo, accettandoci come alleati mentre ci troviamo in un rischio di gravità estrema, vi conquisterete la nostra assoluta riconoscenza con una testimonianza perenne. Da ultimo, noi possediamo la flotta più cospicua dopo la vostra. Riflettete ora: quale più rara occasione di fortuna per voi, o di danno per i vostri nemici, di questa. Se cioè quella potenza che voi, chissà a quale prezzo d'oro e di favori stimereste degno annettervi alleata, essa è qui spontanea, che vi si dà, senza rischi e senza costarvi nulla. Vi procura anzi, di fronte al mondo, fama di magnanimi, riconoscenza da parte di un popolo che difendete e, al vostro paese, un'accresciuta potenza: vantaggiose occasioni, che a ben pochi in ogni tempo si sono presentate tutte insieme, come ben pochi, cercando un'alleanza, possono offrire a chi interpellano sicurezza e decoro non inferiori a quelli che sperano di ricevere. Se alcuno di voi è convinto che non scoppierà la guerra, in cui potremmo esservi utili, commette un grossolano errore. Non s'avvede che gli Spartani desiderano la guerra per timore di voi; ché i Corinzi godono notevole ascendente su di loro e vi sono ostili; che tentano di sottometter prima noi e poi attaccarvi. Essi temono che il nostro comune odio ci colleghi strettamente contro di loro e di veder quindi sfumare uno dei due scopi che si propongono: danneggiare noi o acquistar loro in forza. Sia comune impresa dunque prevenirli: noi offrendo, voi accettando l'alleanza. Si preferisca attaccarli prima di dovercene difendere.
34. "Se poi i Corinzi diranno ingiusto il fatto che voi accettiate in alleanza i loro coloni, sappiano che ogni colonia se è trattata con benevolenza ha riguardo per la madrepatria, ma se subisce torti si volge altrove: lo scopo dei coloni, emigrando, è d'esser pari in diritti ai concittadini, non schiavi. L'ingiustizia è palese, poiché quando li invitammo ad Epidamno per un arbitrato preferirono cercare di sciogliere la questione con la guerra, che con procedimenti legali. Vi serva di prova la loro linea d'azione verso di noi, consanguinei: sicché non vi lasciate fuorviare dal loro inganno, né ottemperate con un aiuto pratico e immediato alle loro richieste, quando ve le porgeranno. Giacché è più sicura l'esistenza di colui che si procura motivi il più possibile scarsi di pentimento per aver favorito i propri avversari.
35. "Non infrangerete la tregua con gli Spartani, accettandoci nella vostra lega, in quanto non siamo alleati di nessuno dei due. Si proclama infatti nei trattati che a qualunque delle città greche, non comprese nelle coalizioni, si consente di cercare appoggio da chi meglio ritiene. Sarebbe un terribile controsenso politico se costoro potessero equipaggiare le navi con forze attirate dai paesi del patto e per giunta dal resto della Grecia, anzi perfino dalle città a voi soggette, e riuscissero poi ad escluderci dall'alleanza ora in discussione e da ogni altra possibilità di soccorso, considerando un iniquo colpo vibrato a loro la vostra eventuale adesione alla nostra istanza. Potremo avanzare noi, invece, rimostranze assai più gravi, se non riusciremo a convincervi. Respingerete infatti noi, in estremo pericolo e che pur non vi siano nemici, senza curarvi di apporre un valido freno all'ostilità aggressiva di costoro, anzi assisterete inerti allo spettacolo di Corinto che incrementa il proprio potenziale bellico con leve tratte dal vostro impero. Ebbene, non è giusto! sarebbe dover vostro d'impedir con la forza a quelli di assoldare mercenari dai vostri paesi e d'inviarci invece quel soccorso a cui vi lascerete persuadere: sarebbe più conveniente che ci accordaste aperta protezione, nella vostra lega. Molti lati vantaggiosi siamo in grado di mostrare, come anticipammo aprendo il nostro intervento: il più interessante è che ci opporremo agli stessi nemici, garanzia che è la più certa, e per giunta nemici niente affatto da sottovalutare, ma che dispongono di forze bastevoli a punire chiunque tenti la defezione. Poiché la nostra è profferta d'alleanza marinara e non terrestre, certo sarà per voi ben differente se la rivolgessimo ad altri: badate infatti, se potete, a non lasciare che un'altra nazione acquisti una flotta, altrimenti cercate l'unione con quella che si dimostri più forte sui mari.
36. "Chiunque è convinto dentro di sé dei sopraddetti vantaggi e tuttavia - può accadere - teme che la sua eventuale adesione costituisca una rottura dei patti rifletta che il suo timore, congiunto alla forza, indurrà piuttosto i suoi nemici a un prudente rispetto; l'eccessiva fiducia, qualora declini la nostra offerta d'alleanza, non fondata su un potenziamento concreto, preoccuperà debolmente dei nemici realmente forti. Tenga conto che ora si discute su Corcira ma ancor più su Atene, i cui affari non amministra con la preveggenza più accorta se, in vista di un futuro conflitto per poco non già effettivo, attento solo agli interessi presenti, esita ad aggregarsi le forze di un popolo con cui intrattenere rapporti di pace o di guerra è del massimo peso. Non solo Corcira è situata proprio sulla rotta per l'Italia e la Sicilia, onde può agevolmente bloccare una flotta che di là accorra ai Peloponnesi in appoggio, come favorirne una in transito da Atene a quelle terre, ma anche per altro è utilissima. Dunque riassumendo in breve la questione nel suo insieme e nei particolari, dovrebbe persuadervi a non respingerci la riflessione seguente: sono tre le forze navali considerevoli, in Grecia: la nostra, la vostra e quella corinzia. Se consentirete a due d'esse di congiungersi, e i Corinzi metteranno le mani su di noi, avrete contro sui mari le flotte di Corcira e del Peloponneso. Se ci accettate invece, potrete scendere in lotta contro di loro mobilitando in più anche le nostre navi." Tali gli argomenti espressi dagli uomini di Corcira. I Corinzi ribatterono come segue.
37. "È necessario, poiché i qui presenti Corciresi non hanno voluto limitare l'intervento alla loro alleanza e alla vostra eventuale adesione, ma vengono a sostenere che li vessiamo con una guerra illegittima, che similmente anche noi ci soffermiamo su questi due punti, esaurendo in seguito i successivi aspetti della questione, affinché disponiate in precedenza di una cognizione netta e sicura sulla volontà nostra e decliniate, a ragion veduta, la richiesta di costoro. Dicono di non essere entrati prima in lega con nessuno per prudenza: hanno intrapreso invece questa linea politica perché sono delinquenti, non per rettitudine. Non erano disposti ad allearsi con complici dei loro soprusi, né ad aver testimoni da reclamare poi a discolpa, con somma vergogna. La loro città, dalla posizione così indipendente, permette loro di essere giudici delle loro sopraffazioni, più che spingerli alle alleanze: è raro infatti che si rechino per nave in terre straniere, mentre spessissimo accade che ricevano gli altri Greci, cui è indispensabile l'approdo alle loro coste. Così questa decorosa facciata di un isolamento internazionale l'hanno eretta a ricovero non di una mancata complicità con altri, ma delle loro azioni illegali, commesse in perfetta solitudine; per disporre con la violenza di quanto riescono ad avere in pugno, per incrementare indisturbati i loro criminali guadagni, per predare quanto si può con tranquilla sfrontatezza. Che se fossero stati, come sostengono, uomini probi, quanto più erano inattaccabili dai vicini, tanto più sarebbe stato loro possibile far mostra di integrità, sottostando alle regole dei trattati in vigore.
38. "Non furono tali mai, né con altri, né con noi: sono nostri coloni, e si comportano da sempre con la più assoluta indipendenza, anzi ora ci attaccano, adducendo a pretesto che la patria non li avrebbe inviati laggiù per peggiorare la loro posizione. Siamo noi ora a reclamare che non abbiamo dedotto quella colonia per essere oltraggiati da costoro, ma per affermare la nostra supremazia e riscuoterne il doveroso tributo di rispetto. Certo presso le altre colonie ci circonda un profondo prestigio, per non dire un'affettuosa devozione. Indubbiamente, se siamo graditi ai più, la loro singolare malevolenza non potrebbe che risultare immotivata, né ci saremmo impegnati in questa spedizione fuori dell'ordinario, senza aver ricevuto un oltraggio veramente brutale. Se pure fossimo noi in colpa, sarebbe stato un atto decoroso per questi uomini piegarsi al nostro risentimento, per noi invece una vergogna sforzare la loro mansuetudine. Si sono esaltati invece, per le loro disponibilità finanziarie, e hanno preso a infliggerci torti l'uno dopo l'altro, finché da ultimo conquistarono a forza Epidamno, nostra colonia, e non la cedono, ora che siamo accorsi in suo aiuto, mentre non pretesero affatto di occuparsene quando versava in pessime acque.
39. "Sostengono d'esser stati prima disposti a un giudizio, in cui però, sia ben chiaro, un dibattito corretto e valido s'imposta non arroccati su un proprio vantaggio e provocando l'arbitrato da posizione inattaccabile, ma stabilendo preliminarmente una perfetta coerenza tra parole e fatti quindi affrontandosi pure nella disputa. Per contro, questi han tratto fuori quel bell'argomento del giudizio non prima di assediare Epidamno, ma dopo essersi convinti che non avremmo tollerato un atto simile. Ora si presentano, non soddisfatti dei crimini commessi laggiù, stimando di potervi convincere ad un'alleanza, che invero è una complicità, e sperando che li accogliate, in quanto voi e noi apparteniamo a blocchi politici opposti. Allora bisognava che essi si facessero avanti, quando erano completamente al sicuro; non ora che noi siamo oltraggiati e loro in pericolo. E voi, che non utilizzaste un tempo le loro forze armate, li metterete a parte della vostra protezione. Pur innocenti delle loro colpe, ne subirete, ai nostri occhi, un pari carico di responsabilità: solo se voi aveste già goduto l'appoggio, in antico, di una loro alleanza militare, dovreste ora sopportare con loro le conseguenze di una politica avventata.
40. "Che le nostre recriminazioni siano ben fondate e che costoro siano dei brutali prevaricatori, è ormai un punto saldo: passiamo ora a dimostrare che sarebbe illegittima la vostra adesione alle loro richieste. È vero: è pattuito nei trattati che a qualunque città autonoma sia lecito rivolgersi all'una o all'altra delle coalizioni: la clausola però non contempla chi s'iscrive per recar danno ad altri, ma chi, senza sottrarsi a precedenti impegni, è in cerca di un aiuto sicuro e non procurerà guerra invece che pace a coloro che lo accoglieranno, se hanno del buon senso. È quanto invece vi accadrà, se non ci date ascolto. Poiché non solo diverrete alleati in difesa di costoro, ma nemici nostri, e decadrà il valore dei patti. Inevitabilmente, se li appoggiate ora, dovrete collaborare alla loro difesa. La vostra neutralità invece sarebbe cosa più giusta: al più, il vostro impegno offensivo dalla nostra parte contro costoro. Poiché voi siete vincolati a un patto con Corinto. Con Corcira non stipulaste mai nemmeno una tregua. È opportuno che voi non erigiate a regola l'accogliere chi si ribella agli altri. Neppur noi infatti, quando si verificò la rivolta dei Sami, deponemmo un voto a voi contrario. Il resto dei Peloponnesi s'era invece trovato diviso nel voto sulle necessità di soccorrerli: allora in polemica con loro sostenemmo la tesi che ciascun popolo deve adottare autonome misure punitive nei confronti dei propri alleati. Attenti: il vostro appoggio a popoli che hanno compiuto azioni illegali nei nostri riguardi provocherà evidentemente una defezione di portata non inferiore di vostri soggetti dalla nostra parte. E avrete stabilito una norma più dannosa alla vostra città che a noi.
41. "Tali dunque i motivi di giustizia a sostegno della nostra causa, nei vostri confronti, validi secondo le leggi vigenti nel mondo greco: ma rechiamo anche l'invito e la pretesa di un atto di benevolenza che, poiché non siamo tanto nemici da compiere azioni d'aperta ostilità né tanto amici da sentirci autorizzati a chieder certi favori, pure riteniamo doveroso da parte vostra in questo momento, a titolo di riconoscenza. Nel tempo in cui eravate afflitti dalla scarsità di navi da combattimento, durante la guerra eginetica, prima dell'invasione persiana, riceveste dai Corinzi venti navi. Questo favore, e quello prestatovi in occasione dell'affare dei Sami (fu per intervento nostro che i Peloponnesi non li aiutarono) vi consentì di sopraffare gli Egineti e di punire i Sami. E ciò accadde in quei momenti particolari in cui gli uomini, totalmente assorti nello sforzo contro il nemico, non si preoccupano più di nulla, al di fuori della vittoria. Poiché accolgono come un amico chi li sostiene, anche se prima era nemico, e avversario chi li abbandona, anche se le loro precedenti relazioni potevano essere di amicizia. E lasciano cadere in rovina anche i propri interessi, nella brama d'una vittoria immediata.
42. "Riflettete su queste ragioni e chi è troppo giovane ne interroghi i più anziani tra voi, si convinca ch'è doveroso ricambiarci. Non ritenga che queste parole sian sì giuste ad udirle, ma, in caso di conflitto, l'utile stia da tutt'altra parte. Poiché la condotta più vantaggiosa consiste nel commettere un numero minimo d'errori e mentre il futuro di questa guerra, di cui tanto temono i Corciresi da spingervi alla loro complicità, è ancora del tutto ipotetico, considerate che per nulla incerta, anzi immediata vi attirereste l'ostilità di Corinto, se vi lasciate trascinare da quella paura. Sarebbe piuttosto prudente dissipare il sospetto che s'istaurò tra noi dall'affare di Megara. (Poiché un atto di favore, pure un po' in ritardo, e d'entità inferiore, è in grado di cancellare un capo d'accusa.) Non appoggiatevi con troppa fiducia alla prospettiva di quella grande alleanza navale che vi offrono: infatti, una politica di relazioni assolutamente corrette con potenze eguali costituisce, per un paese, una forza più salda che conquistarsi, nell'eccitazione provocata da momentanee e fallaci apparenze, un vantaggio a prezzo d'infiniti pericoli.
43. "Siamo noi ora a ricadere nella situazione cui si riferiva la nostra proposta avanzata a Sparta, che ciascuno si occupi da sé delle punizioni da infliggere ai propri alleati. Ora vi richiediamo di ricambiarci con lo stesso atteggiamento politico. Vi fu utile il nostro voto; non danneggiateci ora col vostro. Ripagateci con un pari favore, nella convinzione che proprio la presente è una delle occasioni nelle quali chi appoggia è amico, e chi si schiera contro è nemico. Non accettate questi uomini di Corcira come alleati contro il volere nostro. Non soccorrete la loro iniquità. Ispirate da questi principi, le vostre azioni saranno legali e avrete deliberato, anche per quanto concerne i vostri interessi, il meglio."
44. Tale fu il tenore del discorso pronunciato dai Corinzi. Gli Ateniesi udirono le parti e convocarono l'assemblea in due sedute. Nella prima accolsero i motivi addotti dai Corinzi con pari favore di quelli esposti da Corcira. Ma nella successiva mutarono opinione in questo senso: stringevano con Corcira non un'alleanza che prevedesse per le due potenze attacco o difesa contro gli stessi paesi (se i Corciresi infatti avessero loro imposto di partecipare a un assalto alla flotta di Corinto, Atene si sarebbe vista sciolta dai patti di tregua stipulati con i Peloponnesi); ma concordarono un'intesa militare di reciproco soccorso, nell'eventualità di un'aggressione a Corcira, ad Atene o ai loro alleati. Anche gli Ateniesi presentivano distintamente che sarebbe esplosa la guerra contro i Peloponnesi e non erano disposti a lasciare in mani corinzie Corcira, così potentemente armata sul mare. Cercavano perciò di esasperare al massimo il contrasto politico tra i due stati: nell'eventualità che un conflitto divenisse inevitabile, avrebbero avuto di fronte un nemico comunque più debole, si trattasse dei Corinzi o di altri con a disposizione una flotta da guerra. Da ultimo l'isola era sita in un punto molto opportuno, se ne avvedevano bene, sulla rotta per la Sicilia e l'Italia.
45. Fondandosi su queste considerazioni gli Ateniesi accolsero le richieste dei Corciresi e quando i Corinzi partirono, non molto dopo, inviarono a loro soccorso dieci navi al comando di Lacedemonio figlio di Cimone, Diotimo figlio di Strombico, e Protea figlio di Epicle. Ricevettero queste istruzioni: non impegnare le proprie navi in battaglia coi Corinzi, se questi non dirigevano su Corcira, o non mostravano l'intenzione di effettuare uno sbarco laggiù o in qualche località che appartenesse a Corcira. Solo in questo caso dovevano opporsi con ogni forza. Erano indispensabili tali avvisi per non provocare la rottura dei patti.
46. Così la flotta salpò per Corcira. Anche i Corinzi, quand'ebbero concluso i loro preparativi, si diressero verso l'isola con centocinquanta navi. Ve ne erano dieci di Elei, dodici dei Megaresi e dieci di Leucade, ventisette degli Ambracioti e una degli Anattori. Quelle di Corinto erano novanta: dalle singole città provenivano anche i loro comandanti; da Corinto Senocleide figlio di Euticle, con altri quattro. Salpati da Leucade si portarono nelle vicinanze della costa antistante Corcira. Porsero le navi all'ancora a Chimerio, nella Tesprotide. Si tratta di un porto: sorge su esso, un po' lontana dal mare, la città di Efira nel territorio eleatico della Tesprotide. Lì presso sbocca in mare il lago Acheronte. Bagnando la Tesprotide, il fiume Acheronte sfocia nel lago e gli dà il nome. Vi scorre anche il fiume Tiami, che segna il confine tra la Tesprotide e la Cestrine. Tra i due fiumi è situato il promontorio Chimerio. Proprio in questa località del continente i Corinzi gettarono l'ancora e si attendarono.
47. I Corciresi, come seppero che il nemico era in acque vicine, equipaggiarono centodieci navi, affidandole al comando di Miciade, Esenide e Euribato: posero il loro campo in una delle isole che hanno nome Sibota. Erano presenti anche le dieci navi attiche. Sulla punta di Leucimma era dislocata la fanteria dei Corciresi e i mille opliti che erano accorsi da Zacinto, in appoggio. Ma anche i Corinzi, sul continente, trovarono numerosi reparti di barbari, pronti all'aiuto. Infatti, gli abitanti di questa zona del continente erano sempre stati in rapporti di buona amicizia con loro.
48. Armate ed equipaggiate le navi, i Corinzi, presi con sé viveri per tre giorni, salparono di notte dal Chimerio, decisi alla battaglia sul mare. All'alba avvistarono in navigazione la flotta dei Corciresi: si trovava al largo e dirigeva su di loro. Si scorsero e rapidamente si contrapposero in formazione da battaglia: sul lato destro dello schieramento corcirese si notavano le navi attiche, il resto lo occupavano i Corciresi stessi, dopo aver formato tre squadre di navi, con al comando di ciascuna uno dei tre strateghi. Tale fu l'ordine dei Corciresi. L'ala destra del fronte Corinzio era tenuta dalle navi di Megara e di Ambracia. Al centro gli altri alleati, ciascuno al loro posto. All'ala sinistra si dislocarono i Corinzi, a contrastare gli Ateniesi, e l'ala destra degli avversari, con le navi che meglio tenevano il mare.
49. Da entrambe le linee si levò il segnale, vi fu lo scontro e la battaglia divampò. Disponevano di molti opliti sui ponti, di arcieri e lanciatori di giavellotti, in quanto le due parti, all'uso antico, possedevano scarsa esperienza tecnica d'armamento navale. La mischia durò violentissima: ma non fu notevole per la destrezza dei marinai combattenti, anzi in tutto paragonabile a uno scontro terrestre. Dopo ogni urto, non riusciva agevole alle navi districarsi l'una dall'altra, per l'addensarsi fitto e disordinato degli scafi. Si battevano, convinti che le possibilità di vittoria fossero in mano agli opliti sui ponti delle navi: e quelli combattevano saldi e dritti sulle tolde delle navi, immobili. Non attuavano manovre di rottura delle linee nemiche: d'impeto lottavano e d'appassionata violenza, più che con abilità consapevole. Lo specchio di mare in cui si scontravano le navi ferveva tutto di clamore e di scompiglio immenso. Intanto, le navi attiche si presentavano ad appoggiare i Corciresi, se in qualche punto minacciavano di cedere, e incutevano timore agli avversari. Ma non entravano mai nel vivo della battaglia, poiché i comandanti ricordavano bene il divieto d'Atene. L'ala destra dei Corinzi subiva la rotta più grave: con venti navi il nemico li costrinse a ripiegare, li disperse inseguendoli fino alla costa. Spinse le navi fino in prossimità del campo corinzio, sbarcò e arse le tende saccheggiandone i beni. Da questa parte dunque i Corinzi e i loro alleati avevano la peggio e i Corciresi dominavano. Ma dove combattevano i soli Corinzi, all'ala sinistra, stavano riportando una vittoria netta, perché ai Corciresi, già inferiori per numero di navi, mancavano anche quelle impegnate nello 'inseguimento. Gli Ateniesi, vedendo che i Corciresi ripiegavano, li sostenevano ormai senza più nessuna coperta esitazione, mentre prima si sottraevano a ogni urto diretto. Ma dopo che la disfatta dei Corciresi apparve in tutta la sua gravità e i Corinzi li premevano, allora ognuno entrò nella mischia in una confusione divenuta generale: la situazione, già intricata, degenerò inevitabilmente a tal segno che Corinzi e Ateniesi presero a battersi.
50. Travolto il nemico, i Corinzi tralasciavano di legare a rimorchio gli scafi delle navi avversarie poste fuori combattimento: ne uccidevano sistematicamente gli equipaggi, passando da una nave all'altra. Non catturavano prigionieri vivi. Massacravano ignari anche i loro stessi alleati: non si erano avveduti che quelli dell'ala destra ripiegavano. Operavano moltissime navi su entrambi i fronti e occupavano un'ampia distesa di mare; nel complesso groviglio della mischia, era difficoltoso per gli stessi combattenti riconoscere chi vincesse e chi fosse sopraffatto. Questa battaglia navale tra Greci risultò, per numero di navi impiegate, la più importante tra quelle combattute fino a quel tempo. Dopo che i Corinzi incalzarono i Corciresi fino alla loro terra, si volsero a raccogliere i relitti delle proprie navi e i cadaveri dei loro caduti. Se ne impossessarono della maggior parte e ne effettuarono il trasporto alle Sibota. Colà si era raggruppato il contingente dei loro ausiliari barbari. Le Sibota sono un porto deserto della Tesprotide. Dopo queste operazioni, serrarono ancora le file e presero il mare alla volta dei Corciresi. Anche costoro, con le navi ancora manovrabili e quante rimanevano, spalleggiati dalle navi attiche, si preparavano a contrastarli, nel timore che tentassero uno sbarco nella loro terra. Era ormai tardi: già era stato elevato il peana, preludio alla mischia, quando i Corinzi, d'un tratto, presero a far sforzo all'indietro sui remi. Avevano avvistato 20 navi ateniesi dirette contro di loro: gli Ateniesi le avevano fatte partire in seguito, per soccorrere le prime 10, nel dubbio, poi confermato dai fatti, che i Corciresi subissero un rovescio e le loro 10 navi non costituissero una copertura sufficiente.
51. I Corinzi manovravano per ripiegare: le avevano scorte da lontano e sospettavano che provenissero da Atene, e che fossero un numero maggiore di quante riuscivano ad avvistarne. Ai Corciresi non era possibile vederle (quelle si avvicinavano ma erano ancora fuori della loro portata visiva) e si stupivano che i Corinzi remassero indietro, finché alcuni, quando le videro, gridarono che da quella parte sopraggiungevano delle navi. Anch'essi allora stavano ritirandosi: calava già la sera e i Corinzi, volte le prue, posero fine alla battaglia. Così si separarono e lo scontro si concluse all'arrivo della notte. I Corciresi si attendarono a Leucimma. Quelle 20 navi ateniesi al comando di Glaucone figlio di Leagro e di Andocide figlio di Leogora, aprendosi la strada tra cadaveri e frantumi di chiglie, approdarono presso l'accampamento: non era molto da che erano state viste. I Corciresi (era notte) temettero dapprima un assalto, poi le riconobbero: e quelle si ormeggiarono.
52. L'alba successiva, le 30 navi attiche con quelle corciresi in grado di tenere il mare, navigarono fino al porto delle Sibota, in cui erano all'ancora i Corinzi. Era loro intenzione di sincerarsi se avrebbero accettato un nuovo scontro. Quelli, allontanate le navi dalla costa, le disponevano al largo, in formazione da combattimento e attendevano. Non avevano in mente d'essere loro a dare inizio alla battaglia. Vedevano in perfetta efficienza le navi ateniesi che s'erano aggiunte alla flotta nemica; inoltre varie difficoltà si eran loro presentate: la mancanza di attrezzature per riparare gli scafi in avaria, laggiù in un porto fuori mano. Inoltre, li tormentava l'apprensione per il ritorno in patria: era incerto per dove avrebbero potuto passare e temevano che gli Ateniesi, ormai convinti che la tregua fosse interrotta, dato che avevano combattuto, non li lasciassero partire.
53. Decisero dunque d'imbarcare alcuni dei loro su una scialuppa e di mandarli, sprovvisti di caduceo a scrutarne i disegni. Il messaggio inviato fu il seguente: "È ingiusto da parte vostra, Ateniesi, aprire le ostilità e rompere la tregua: noi procediamo alla punizione dei nostri nemici e voi ci create ostacoli con le armi. Se il vostro piano è d'impedirci l'accesso a Corcira, o a qualunque altro luogo scegliamo per la nostra rotta e considerate sospesa la tregua, eccoci per primi; trattateci da nemici". Tali le loro parole: tutti i Corciresi, che dalla loro posizione li avevano potuti udire urlarono di prenderli senza indugio e ucciderli, ma gli Ateniesi replicarono: "Uomini del Peloponneso, noi non violiamo i patti: solo veniamo in aiuto a Corcira, ch'è nostra alleata. In qualunque altro luogo preferiate dirigervi, non l'impediamo: ma se tenterete lo sbarco a Corcira o a qualcuna delle sue terre, non lo permetteremo, con tutte le nostre forze."
54. In seguito a questa risposta ateniese i Corinzi preparavano il ritorno a casa ed elevarono un trofeo nelle Sibota del continente. I Corciresi raccolsero i morti e i relitti che la corrente e la brezza avevano trascinato dalla loro parte ed eressero anche loro un trofeo nell'isola Sibota convinti d'aver avuto in pugno la vittoria. Entrambi si arrogavano il successo con tali ragionamenti: i Corinzi perché avevano dominato lo scontro fino a notte, potendo recuperare la maggior parte dei relitti e delle salme. Inoltre tenevano in catene non meno di 1000 uomini e avevano affondato circa 70 navi. Per questo innalzarono il trofeo. I Corciresi avevano distrutto circa 30 navi e dopo l'arrivo dei rinforzi ateniesi erano riusciti a raccogliere frantumi e salme, che erano dalla loro parte; e infine, il giorno prima i Corinzi, alla vista delle navi attiche, avevano remato indietro ripiegando di fronte a loro. Dopo il sopraggiungere degli Ateniesi non si erano più fatti incontro dal porto delle Sibota. Perciò eressero il trofeo. Così entrambi erano convinti della propria vittoria.
55. I Corinzi sulla rotta verso la patria, presero con l'inganno Anattorio, che è situata all'imbocco del golfo di Ambracia (apparteneva in comune a loro e ai Corciresi) e dopo avervi distaccata una colonia di Corinzi, fecero ritorno a casa. Dei prigionieri corciresi 800, tutti servi e personale di bordo, li vendettero, 256 li tenevano come prigionieri, ma con grandissime attenzioni, nella speranza che, al ritorno a Corcira, si adoperassero per ottener loro la riconciliazione. Si dava il caso che tra costoro vi fossero anche alcuni tra i più influenti della città. Con questo felice e agevole successo Corcira superò il conflitto con i Corinzi. Le navi Ateniesi si posero sulla rotta per rientrare in patria. Ma fu questa la causa prima della guerra tra Corinto e Atene, la circostanza cioè che gli Ateniesi, pur legati ai Corinzi da un trattato, li avevano combattuti sul mare per soccorrere Corcira.
56. Ben presto, dopo questi fatti, intervennero tra Ateniesi e Peloponnesi anche i seguenti motivi d'attrito, che li indussero alla guerra. Poiché i Corinzi brigavano meditando assiduamente una vendetta e gli Ateniesi ne temevano con sospetto l'odio, questi ultimi ingiunsero agli abitanti di Potidea, colonia di Corinto, alleata di Atene soggetta a tributo, situata sull'istmo di Pallene, di demolire il muro verso Pallene e consegnare ostaggi; dovevano allontanare poi gli attuali epidemiurghi e rifiutarsi di accogliere quelli che in futuro, ogni anno, sarebbero stati inviati dai Corinzi. Temeva Atene che quelli di Potidea defezionassero, subornati da Perdicca e dai Corinzi e convincessero a una rivolta generale anche gli altri alleati di Tracia.
57. Gli Ateniesi avevano deciso questi provvedimenti contro i Potideati, a scopo cautelativo, subito dopo lo scontro nel mare di Corcira: i Corinzi infatti mostravano ormai aperta tutta la loro ostilità. Anche Perdicca, figlio di Alessandro re dei Macedoni, s'era fatto ostile, da alleato ed amico. Motivo dell'avversione fu che gli Ateniesi avevano stretto un'alleanza con suo fratello Filippo e con Derda, che gli si erano coalizzati contro. Temendoli, da una parte tramava inviando messi a Sparta per far insorgere una guerra tra Atene e i Peloponnesi, dall'altra tentava di addurre i Corinzi dalla propria parte per agevolare la rivolta a Potidea. Intratteneva contatti con i Calcidesi sulla costa della Tracia e con i Bottiei per farli ribellare. Calcolava, che con l'appoggio e l'alleanza di queste terre di confine, gli sarebbe stato più facile condurre la guerra. Ma gli Ateniesi furono informati di queste relazioni e intenzionati a prevenire la rivolta nelle città (infatti avevano già pensato di inviare trenta navi con mille opliti nel paese di Perdicca, agli ordini di Archestrato figlio di Licomede con altri nove strateghi) inviarono ai comandanti la squadra navale l'ordine di prendere ostaggi dai Potideati e far demolire il muro: tenessero inoltre sotto sorveglianza le città circostanti, per impedirne la rivolta.
58. Gli abitanti di Potidea, pur mandando messi anche agli Ateniesi per tentare di convincerli a non adottare misure ostili nei loro confronti, si recarono in ambasceria a Sparta, accompagnati dai Corinzi, e là cercavano il modo d'ottenere un aiuto, nel caso che se ne presentasse il bisogno. Infatti, nonostante tutto il loro impegno, ad Atene non ricavavano nulla di promettente. Poiché le navi dirette in Macedonia facevano vela egualmente contro di loro e le autorità spartane avevano promesso, in caso di attacco ateniese contro Potidea, di invadere l'Attica, colsero questa occasione per insorgere, collegati da un patto con i Calcidesi e i Bottiei. Perdicca intanto persuase i Calcidesi ad abbandonare i centri della costa dopo averli rasi al suolo, per trasferirsi ad Olinto fortificando quest'unica città. A questi, che lasciavano la patria, distribuì da coltivare una parte dei suoi possedimenti in Migdonia intorno al lago Bolbe, finché durasse lo stato di guerra contro Atene. E quelli si andavano a stabilire nell'interno del paese, demolite le loro città, e insieme si preparavano al conflitto.
59. Le trenta navi attiche giunsero in Tracia e trovarono che Potidea e le altre località erano insorte. Gli strateghi, considerando che era impossibile con le sole forze a disposizione condurre la guerra contro Perdicca e la lega delle città in rivolta, si rivolsero contro la Macedonia, che in effetti era la prima meta della loro spedizione e, stabilitisi laggiù, intraprendevano azioni militari in collegamento con Filippo e i fratelli di Derda, che dall'interno del paese avevano fatto impeto con un esercito.
60. Nello stesso tempo i Corinzi, poiché Potidea aveva defezionato e le navi attiche incrociavano davanti alle coste della Macedonia, in ansia per la sorte di quei paesi e con la netta sensazione che il pericolo incombesse egualmente su loro stessi, inviano laggiù volontari propri e uomini assoldati dagli altri centri peloponnesiaci: in tutto 1600 opliti e 400 di armatura leggera. Erano al comando di Aristeo figlio di Adimanto. La maggior parte dei volontari corinzi lo seguì per il profondo senso d'amicizia che li legava a lui. Aveva sempre avuto con quelli di Potidea rapporti molto amichevoli. Giunsero in Tracia il quarantesimo giorno dalla ribellione di Potidea.
61. Ben presto arrivò ad Atene la notizia che quelle città erano insorte e, quando giunse successiva l'informazione che anche quelli al comando di Aristeo s'eran posti in marcia, gli Ateniesi inviarono 2000 dei loro opliti e 40 navi contro le città ribelli, e come stratego Callia figlio di Calliade, con altri 4 colleghi. Pervenuti in Macedonia, constatarono subito che i mille opliti inviati in precedenza avevano da poco conquistato Terme ed erano impegnati nell'assedio di Pidna. Stabilitovi anch'essi il campo assediarono Pidna, ma in seguito, accordatisi con Perdicca e avendo stretto con lui un'alleanza ormai inevitabile, poiché li urgeva l'ansia delle vicende di Potidea e del sopraggiungere laggiù di Aristeo, si levarono dalla Macedonia, giunsero a Beroia e di là a Strepsia. Fu vano il tentativo di occupare quella fortezza: desistettero mettendosi in marcia per via di terra verso Potidea, con 300 opliti dei loro oltre a numerosi alleati e ai 600 cavalieri macedoni al seguito di Filippo e Pausania: contemporaneamente 70 navi li accompagnavano costeggiando. Avanzando a brevi tappe, il terzo giorno toccarono Gigono e lì posero le tende.
62. Quelli di Potidea e i Peloponnesi agli ordini di Aristeo, attendendo gli Ateniesi, si erano accampati sull'istmo, nei pressi di Olinto e avevano costituito un mercato fuori le mura. Gli alleati elessero a stratego dell'intero esercito Aristeo, e capo della cavalleria Perdicca: infatti, costui aveva ben presto abbandonato la parte ateniese e combatteva con Potidea, dopo aver sostituito in Macedonia il suo comando con quello di Iolao. Il piano di Aristeo si configurava così: trattenere con sé sull'istmo il suo esercito, a vigilare sugli Ateniesi, se mai tentassero l'avanzata; i Calcidesi, gli alleati esterni all'istmo e i 200 cavalieri agli ordini di Perdicca dovevano acquartierarsi invece in Olinto, e qualora gli Ateniesi muovessero contro Aristeo e i suoi, con un assalto alle spalle, avrebbero serrato il nemico nel cerchio dei due schieramenti. Per parte sua Callia, stratego ateniese, e i suoi colleghi di comando inviano ad Olinto la cavalleria macedone e un ristretto contingente alleato, per bloccare l'eventuale soccorso al nemico da quella direzione. Il resto di loro invece, levato il campo, si diresse a Potidea. Quando furono prossimi dell'istmo e avvistarono i nemici schierati e pronti alla battaglia, si contrapposero anch'essi in ordine e in breve divampò la mischia. L'ala personalmente diretta da Aristeo e le truppe scelte dei Corinzi e di altri collegati che operavano in quel settore travolsero i loro immediati avversari e li incalzarono in fuga per gran tratto; ma l'altra ala dell'esercito dove combattevano le milizie di Potidea e degli altri Peloponnesi, cedette sotto l'urto degli Ateniesi e trovò rifugio nelle mura.
63. Ripiegava Aristeo dall'inseguimento, e s'avvide che il resto delle truppe era in rotta. Non seppe al momento decidere in quale direzione scatenare la battaglia, per aprirsi una ritirata: se verso Olinto o Potidea: ritenne preferibile serrare i suoi in un gruppo il più possibile compatto e tentare di corsa un varco in direzione di Potidea. E vi riuscì, percorrendo un molo sul mare, sotto una tempesta di colpi nemici e a gran fatica. Perse pochi uomini: gli altri, il maggior numero, furono condotti in salvo. Le truppe attestate in Olinto, in attesa di soccorrere Potidea (la distanza tra le due località è di 60 stadi circa e il terreno è scoperto) al principio della battaglia, quando si levarono le insegne, avanzarono di poco, mostrando l'intenzione di soccorrere: ma la cavalleria macedone sbarrò subito il passo, in ordine di battaglia. Poiché gli Ateniesi conseguirono una vittoria così fulminea, le insegne furono nuovamente abbassate: e quelli si convinsero a ripiegare verso le mura, mentre i Macedoni retrocedevano per ricongiungersi con gli Ateniesi. Le opposte cavallerie non si erano gettate nel fuoco della mischia. Dopo la battaglia, gli Ateniesi elevarono un trofeo e permisero a quelli di Potidea, sotto la garanzia di una tregua, il recupero dei caduti. Sul campo giacevano poco meno di trecento uomini di Potidea e dei suoi alleati; centocinquanta Ateniesi e lo stratega Callia.
64. Gli Ateniesi eressero in fretta, opposto alle mura di Potidea, sull'istmo, un baluardo per tagliarle fuori, e vi stallarono postazioni di guardia. La cinta di mura verso Pallene rimaneva invece sguarnita. Calcolavano di non aver truppe bastevoli al presidio dell'istmo e, nello stesso tempo, per effettuare il passaggio di una parte degli uomini dalla parte di Pallene per costruire anche di là un muro di sbarramento: temevano che, quando avessero divise le forze per attuare quel piano, quelli di Potidea e gli alleati li aggredissero. Quando gli Ateniesi rimasti in città appresero che Pallene non era ancora bloccata da fortificazioni murarie, dopo un certo periodo inviano 1600 dei loro opliti, sotto gli ordini dello stratego Formione figlio di Asopio. Costui, giunto a Pallene e muovendo dalla base di Afitia faceva avvicinare il suo esercito a Potidea avanzando a brevi tappe e desolando intanto la regione. Nessuno si presentava a contrastarli. Tagliò fuori con un baluardo le mura di Potidea rivolte a Pallene. In tal modo da entrambi i lati la città era cinta da un assedio poderoso, e bloccata dal mare per le navi lì presso ormeggiate.
65. Aristeo comprese che la circostanza era critica: la città isolata dalle muraglie nemiche, e nessuna speranza di salvezza, se non nel caso di qualche soccorso proveniente dal Peloponneso o qualche altra insospettabile fortuna. Consigliò che, tranne cinquecento uomini, tutti gli altri aspettassero il vento opportuno e tentassero di allontanarsi per nave, per far in modo che le scorte di viveri durassero più a lungo: si dichiarava disposto a condividere la sorte di quanti restavano. Poiché non riusciva a persuaderli ed era deciso sia a porre riparo alle presenti difficoltà sia a procurare che la situazione all'esterno si evolvesse in modo più favorevole, compì per mare una sortita, elusa la guardia ateniese. Attendandosi nella Calcidica, partecipò ad alcune azioni militari tra cui un agguato presso la città dei Sermili, cui inflisse pesanti perdite. Frattanto manteneva contatti con i Peloponnesi, per ricavarne una qualche forma di aiuto. Dopo il blocco di Potidea, Formione, coi suoi milleseicento soldati, devastava i territori calcidesi e bottiei, conquistando anche alcuni fortilizi.
66. S'erano dunque creati, prima del conflitto, nei rapporti tra Atene e i popoli del Peloponneso, questi nuovi motivi di recriminazione: per i Corinzi, il fatto che gli Ateniesi cingessero di assedio Potidea, loro colonia, e i soldati corinzi e peloponnesi chiusi dentro, per gli Ateniesi invece, nei riguardi dei Peloponnesi, il fatto che essi avevano fomentato la rivolta in una città soggetta all'alleanza e al tributo d'Atene e che, venuti apertamente in loro soccorso, si battevano a fianco di quelli di Potidea. E invero la guerra non era ancora divampata, ma vigeva sempre una tregua d'armi, in quanto i Corinzi avevano agito su iniziativa puramente privata.
67. Eppure costoro, mentre Potidea era stretta dall'assedio, non si potevano tenere inattivi, non solo perché vi erano rimasti bloccati loro concittadini, ma temendo anche per il futuro di quella fortezza. Convocarono subito gli alleati a Sparta e recativisi anch'essi scagliavano veementi accuse contro gli Ateniesi, che avevano infranti i patti rendendosi colpevoli contro gli stati del Peloponneso. Anche gli Egineti, pur evitando di scoprirsi mandando delegazioni ufficiali, perché temevano Atene, soffiavano di nascosto sul fuoco della guerra, diffondendo la voce che non erano indipendenti come dovevano garantire i trattati. Dopo aver invitati anche quanti della loro lega sostenevano di aver subito torti dagli Ateniesi, gli Spartani adunarono la consueta assemblea ed esortarono ad esporre ciascuno le proprie rimostranze. Così fecero, presentandosi a turno, e tra gli altri anche quelli di Megara che esposero numerosi motivi di dissenso con Atene, soffermandosi sulla circostanza che, contro i trattati, si vietava loro l'accesso ai porti del dominio ateniese e venivano esclusi dagli scambi commerciali con l'Attica. Intervenuti ultimi i Corinzi, dopo aver lasciato che gli altri esacerbassero lo sdegno spartano, così si espressero:
68. "La fiducia, uomini di Sparta, che nella vostra comunità impronta i rapporti pubblici e i personali contatti, vi ispira una esagerata diffidenza se talvolta muoviamo una critica alla condotta altrui: qualità che vi conferisce una misurata prudenza, ma per cui siete affetti, nelle vostre relazioni con gli altri stati, da un'acuta miopia politica. Poiché, sebbene in varie occasioni vi avessimo preavvertito degli attacchi che ci avrebbe inferto Atene, voi non vi davate la pena di chiarire e interpretare le informazioni che vi venivamo, di volta in volta, porgendo, ma preferivate accogliere i nostri sfoghi con il consueto sospetto, fra voi persuasi, in fondo, che ci si presentasse a perorare per motivi di contrasto essenzialmente particolari e privati. Onde, non prima di patire qualche ingiuria, ma quando già ne subiamo praticamente l'esperienza, raccoglieste a concilio gli alleati qui presenti, tra i quali spetta a noi reclamare più forte, in quanto più pesanti risultano i capi d'accusa che abbiamo in serbo oltraggiati dagli Ateniesi e offesi dalla vostra noncuranza. Se usassero macchinare nell'ombra le loro illegalità ai danni dei Greci, allora vi si converrebbe far luce, come a gente che ignora: ma ora, c'è necessità di prolissi discorsi? Vedete chiaro: essi già tengono soggiogati alcuni, mentre insidiano la libertà d'altri, non ultimi anche alcuni tra i nostri alleati; con notevolissimo anticipo stanno effettuando la loro preparazione militare, calcolando l'eventualità di un conflitto. Non avrebbero potuto, altrimenti, non solo annettersi Corcira con la frode, contro il nostro volere, ma nemmeno tenere Potidea assediata: località di cui l'una è piazzaforte di primaria importanza per il successo delle operazioni belliche sulla costa della Tracia, mentre l'altra avrebbe dotato le forze dei Peloponnesi di una flotta molto considerevole.
69. "La responsabilità dell'attuale situazione è nettamente vostra: in primo luogo, avete loro consentito di far potente la città, dopo le guerre persiane, e in seguito di erigere le lunghe mura, defraudando così fino ad ora sistematicamente della loro indipendenza non solo quanti già servono sotto il loro giogo, ma perfino genti che sono vostre alleate: poiché non tanto chi effettua un asservimento quanto chi pur potendo cancellarlo, ne assiste inerte allo spettacolo, è il suo più autentico esecutore. Soprattutto se reca in sé il vanto e la considerazione di valoroso e di liberatore della Grecia. Appena ora ci riuniamo nel presente consesso, ma neppure in questa occasione con propositi lucidamente definiti. Occorre che si esamini ora non se subiamo oltraggio, ma la nostra futura linea difensiva: poiché gli uomini veramente d'azione sono quelli che portano con fulminea energia il loro attacco dopo che hanno ponderato il loro piano in ogni particolare contro gente che non ha ancora deciso e valutato a fondo la situazione. E noi conosciamo i procedimenti degli Ateniesi e come guadagnino spazio a poco a poco a danno dei limitrofi. Pensando di eludere inosservati la vostra apatica indifferenza, limitando per ora il loro ardimento, ma quando s'avvedranno che voi siete al corrente e pure li lasciate liberi d'agire, incalzeranno con più impavido vigore. Poiché voi soli di tutti i Greci, uomini di Sparta, restate immobili anteponendo una difesa fondata sull'indugio a una che faccia ricorso all'azione, voi soli a proporvi di demolire la potenza nemica in espansione, non quand'è al suo inizio, ma quand'è doppia di forze. Eppure si diceva che foste un popolo pieno di sicurezza: ma certamente questa voce era superiore alla realtà. Noi stessi sappiamo infatti che il Persiano ebbe tutto l'agio di venire dai confini del mondo fin nel Peloponneso prima che da parte vostra si muovesse un'opposizione armata degna d'esser considerata tale. Ora consentite libertà d'azione agli Ateniesi che non sono, come quello, remoti, ma prossimi, e invece d'esser voi a scatenare l'assalto preferite dover difendervi da loro, porvi nel rischio di una lotta contro un avversario molto superiore in potenza. Sapete che i barbari determinarono la loro stessa disfatta con la propria imprevidenza e che anche contro gli Ateniesi molti dei nostri successi furono dovuti più ai loro errori che a un aiuto proveniente da voi: poiché proprio le speranze in voi riposte hanno causato in molte occasioni la rovina di quanti si lasciarono cogliere sprovveduti, forti solo della fiducia in un vostro soccorso. Ma in nessuno tra voi queste critiche suscitino il pensiero di una ostilità da parte nostra: di una recriminazione piuttosto. Il rimproverare è usuale con uomini amici che siano in errore, l'accusare con nemici che siano in colpa.
70. "Al tempo stesso, noi ci sentiamo in diritto, forse come nessuno, di muovere rimproveri agli altri, soprattutto in quanto si tratta per noi di questioni vitalmente importanti e in relazione alle quali non ci pare proprio che usaste mai un certo discernimento, né che abbiate mai calcolato attentamente quali siano gli Ateniesi, con cui verrete a prova, e quanto, e come in tutto differisca il loro ingegno dal vostro. Sono innovatori essi, acuti e mobilissimi nei progetti, dinamici a convertirli in realizzazioni pratiche: e voi, sempre a cercar di conservare appena quanto possedete; mai un disegno ardito, uno slancio mentale, perfino nella pratica vi limitate al disbrigo del minimo necessario, e spesso anche in quello mancate. Ancora: accesi quelli d'audacia oltre il loro potere, temerari al di là di ogni logica, forti sempre delle loro speranze in ogni cimento: e a voi compete d'ottener invece, di regola, risultati scadenti in rapporto all'impegno che avreste potuto profondere; sfiduciati anche quando la riflessione v'assicura che le circostanze sono favorevoli saldamente; bravi solo a pensare in ogni frangente che non ne riuscirete mai indenni. E invero essi son sciolti da ogni impaccio o esitazione rispetto a voi, perennemente torpidi: vibranti al fascino delle terre lontane, come voi siete radicati alle pareti domestiche. Poiché quelli fidano di trar guadagno dal loro viaggiare, voi invece di mettere a rischio il vostro avere col muovere un passo fuori di casa. Vittoriosi sul nemico, avanzano più che possono; sconfitti ripiegano e cedono al minimo. E aggiungete che quelli, a servir lo stato, non curan di gettare energie e vita, come cose le più estranee; ma dell'intelligenza propria son gelosi, come della più adatta al progresso della città. Quanti progetti poi, per un caso o l'altro, non concludono, ritengono d'esser frodati di possessi loro per diritto; ma quando perseguendo alcunché l'ottengono, lo giudicano mediocre guadagno rispetto a quelli ch'essi s'aspettano futuri. Se talvolta, come accade, falliscono una prova, accesi di nuove e migliori speranze, infallibilmente colmano la momentanea perdita. Solo per loro sperare e possedere sono una cosa, ogni volta che si pongono in animo un traguardo; poiché son soliti tradurre celermente in opera ogni loro progetto. E sono i frutti questi d'un impegno strenuo, durato l'arco intero della vita, tra fatiche e pericoli; godono pochissimo i propri averi presenti, per la loro perenne tensione all'acquisto, e non considerano altra festa all'infuori che operare il proprio dovere ed è per loro più struggente sciagura sia un'inerzia improduttiva, che una attività aspra di fatica. Cosicché se alcuno volesse definire in breve la loro indole, direbbe giusto ch'essi sono venuti nel mondo per non goder mai loro stessi pace, né per lasciarla avere al resto degli uomini.
71. "Sebbene sia tale, uomini di Sparta, la città che vi si dispone contro, prendete tempo e non vi mostrate convinti che la pace sia per lo più possesso di quanti vivono in armi, senza commettere soprusi, ma lasciando trasparir chiaro dal loro atteggiamento morale che, se subiscono un'offesa, son fermi a non tollerarla. Voi invece interpretate l'equità come non recar danni altrui, per non dovere voi stessi sostenere il doloroso onere di un impegno difensivo. Otterreste a stento un simile risultato se aveste dimora presso una città eguale alla vostra: ma ora, come vi abbiamo da poco chiarito, i vostri intendimenti son troppo all'antica rispetto ai loro. È inevitabile, come nel campo dell'arte, che anche in politica abbia la supremazia chi di volta in volta avanza e si rinnova: quando uno stato è in pace, è preferibile certo che le istituzioni non mutino, ma se si è costretti ad affrontare diverse e fluide situazioni, occorre mobile ingegno, sempre pronto all'inventiva. Per questo, la capacità politica degli Ateniesi, scaltrita da molte e varie esperienze, è immensamente all'avanguardia, rispetto a voi. Ma il vostro torpore non oltrepassi questo limite: fornite ora, a quelli di Potidea e agli altri, quell'aiuto che avevate promesso, invadendo al più presto l'Attica, per non abbandonare agli avversari più accaniti uomini che vi sono amici e consanguinei. Non vogliate spingere noi pure a legarci, presi dallo sconforto, a un'alleanza diversa dalla vostra, Se tale fosse la nostra mossa futura non commetteremmo nulla d'ingiusto, ne al cospetto degli dei che tutelano i giuramenti, né degli uomini di senno. Scioglie i patti non chi, per esser stato abbandonato, si rivolge ad altri ma coloro che non Prestano il dovuto soccorso a quelli cui sono vincolati da un giuramento. Se voi intendete mostrare una decisa fierezza, resteremo: poiché non agiremmo secondo la santità dei patti né potremmo incontrare altri alleati più congeniali di voi. Prendete con senno la vostra decisione su questi fatti: badate che il vostro dominio non s'eserciti su un Peloponneso più angusto di quello che vi hanno lasciato i padri."
72. Questo fu il tenore dell'intervento corinzio. Si trovava già presente prima, per un caso, a Sparta, un'ambasceria ateniese, per questioni diverse: ma come ebbero udite le parole dei Corinzi, ritennero doveroso presentarsi agli Spartani, senza voler architettare una difesa alle imputazioni che le città avevano via via intentato, ma per chiarire da una prospettiva più generale come fosse conveniente a Sparta non decidere di fretta, ma solo dopo matura riflessione. E.volevano al tempo stesso far comprendere quale fosse in potenza la propria città e non solo rinverdire la memoria nei più anziani tra loro di quanto sapevano, ma anche esporre ai giovani le cose di cui non avevano esperienza, convinti che dal proprio racconto sarebbero stati esortati più alla pace che alla guerra. Presentatisi dunque agli Spartani, dichiararono di aver anch'essi desiderio di parlare davanti alla loro assemblea, se non s'interponeva qualche ostacolo. Quelli li invitarono a presentarsi pure e, davanti al consesso di Sparta e alleato, gli Ateniesi pronunciarono il seguente discorso:
73. "La nostra ambasceria non aveva lo scopo di sostenere un dibattimento con i vostri alleati, ma di trattare i punti per cui Atene ci ha inviato in missione. Ma, apprendendo che invettive non lievi sono scagliate contro di noi, ci presentiamo non per controbattere le imputazioni delle città vostre alleate (non siete voi i giudici infatti al cui cospetto dovrebbero pronunciarsi i discorsi nostri e di questi messi), ma perché non accada che voi, forse troppo facilmente persuasi dai vostri alleati su questioni politiche d'estrema gravità, scegliate il partito più nocivo. Inoltre siamo decisi a spiegare, in relazione al complesso delle voci e delle opinioni che sul nostro conto si sono ormai stabilite, che il frutto delle nostre conquiste non irragionevolmente ci appartiene e che la città nostra è degna di considerazione. È indispensabile ripercorrer fatti remoti nel tempo, di cui l'unica prova sono i racconti sorti dalla tradizione, non la testimonianza visiva di chi si disporrà ad udirli? Eppure le gesta contro il Persiano e quante appartengono anche alla vostra esperienza, se pur ne derivi annoiato fastidio verso chi di continuo le propone, vanno commemorate. Poiché quando agivamo si correva pericolo per la utilità collettiva, dei cui pratici frutti godete ora una parte, e della cui gloria quindi, se pur può giovarci a qualcosa, non vogliate del tutto privarci. Si parlerà ora qui non per ottenere una discolpa, ma per testificare e chiarire la natura della città contro cui sosterrete il vostro sforzo di guerra, nel caso di una deliberazione sconsiderata. Dichiariamo infatti che fummo soli a Maratona, quando ci esponemmo all'urto del barbaro; anche quando calò un'altra volta, non avendo milizie sufficienti a una difesa terrestre, imbarcati tutti sulle navi, combattemmo serrati sul mare a Salamina: con l'effetto che i Persiani non furono più in grado di devastare il Peloponneso assalendo per mare una città dopo l'altra. Centri cioè che non avrebbero potuto, contro una flotta numerosa, recarsi vicendevole soccorso. Il barbaro stesso ne forni la prova più convincente: sconfitto sul mare, non disponendo più di una potenza pari a quella nemica, si ritirò in patria con il grosso delle milizie.
74. "Risultò dunque decisivo il peso di quell'avvenimento e si fece ormai chiaro che la salvezza della Grecia era consistita nelle navi: a ciò fornimmo noi i tre fattori di più fondamentale rilevanza: il numero maggiore di navi, lo stratego più abile, l'animo più impavido. Infatti, di circa quattrocento navi, i due terzi appartenevano a noi, come era nostro stratego Temistocle, autore principale del piano che prevedeva lo scontro in quell'angusto specchio d'acqua. Circostanza che fuor di dubbio ci salvò. Per questo merito appunto lo gratificaste di un onore più grande che qualsiasi altro straniero giunto in visita da voi. Il nostro slancio sorpassò in audacia qualunque altro; noi che, poiché nessuno ci sovveniva per terra, e tutti i popoli circostanti erano già servi, stimammo di abbandonare la città e i nostri averi alla rovina, non per tradire la comune causa degli alleati superstiti né per disperderci, ormai inetti alla loro difesa, ma per salire sulle navi da guerra e dar battaglia, senza rancori per voi, per il vostro mancato soccorso. Sicché possiamo dichiarare d'esservi stati autori d'un aiuto non inferiore a quello che da voi ricevemmo. Voi infatti dalle vostre città, in cui ancora abitavate e al fine di potere ancor viverci in futuro, dopo che foste in preda al panico per la loro sorte, non già per noi, accorreste allora (nel tempo infatti in cui eravamo incolumi, non compariste mai); noi invece, muovendo da una città che ormai non esisteva più e tentando la fortuna delle armi in sua difesa, mentre il suo futuro era sospeso a una fievole speranza, salvammo insieme una parte di voi e noi stessi. Se fossimo subito passati dalla parte del Persiano, come gli altri o, convinti in partenza d'essere perduti, non avessimo avuto in seguito l'audacia d'imbarcarci sulle navi, non ci sarebbe più stata necessità per voi, che non avevate navi a sufficienza, di combatter sul mare in tutta tranquillità il nemico avrebbe conseguito gli obiettivi desiderati".
75. "Non siamo degni cittadini di Sparta per i nostri trascorsi atti di valore, e per la perspicacia dei nostri intendimenti di esercitare sui Greci l'attuale supremazia senza attirarci un'invidia e un odio così pesanti? Eppure noi l'assumemmo non con la violenza, ma poiché voi non eravate disposti ad affrontare il resto delle truppe barbare. Da noi invece si presentarono gli alleati con la spontanea preghiera di porci alla loro guida. La forza insita nei fatti ci indusse in un primo tempo a ampliare fino a questo segno il nostro dominio, soprattutto per il timore ispirato dallo straniero, in seguito per il nostro decoro, solo più tardi in vista nel nostro utile. Tenevamo ormai per poco sicuro, essendo invisi alla maggior parte degli alleati, di sottoporci al rischio di lasciarli indipendenti (avrebbero defezionato dalla parte vostra). Alcuni, dopo un tentativo di rivolta, erano già stati ridotti in condizione di sudditi, mentre voi non ci ricambiavate di pari amicizia, ma ci trattavate con sospetto e ostilità. Si concede a tutti, senza animosità, di stabilire al meglio, quando versa nei più gravi pericoli, la propria situazione.
76. "Per esempio voi, uomini di Sparta, esercitate la signoria sulle città del Peloponneso dopo averne confermati gli ordinamenti politici al vostro interesse: se, in quel tempo, perseguendo la guerra contro il barbaro fino alla sua conclusione, vi foste attirati, nel vostro dominio, un odio pari a quello che ora ci circonda, sappiamo bene che non avreste adottato meno rigide misure con gli alleati e vi sareste visti costretti o a governare con sistemi ferrei, o a rischiare voi stessi di perder l'impero. Così noi non ci siamo comportati in modo assolutamente straordinario: non ci pare estraneo alla mentalità umana, se accettammo una signoria che c'era offerta, non rinunciandovi più, sotto la spinta di tre potenti fattori: il decoro, il timore e l'utile. Non fummo noi i primi a porre in vigore questa legge, ma è universale e perenne norma che il più debole sia suddito del più forte. In aggiunta, noi ci stimiamo meritevoli del nostro dominio e tali anche a voi siamo sempre sembrati. Finché, per calcolo d'utilità ora sbandierate il concetto di giustizia. Ma chi realmente preferisce applicarlo, quando si offra l'occasione di realizzare con la forza un acquisto? Tutti procurano piuttosto d'incrementare i loro interessi. Meritano lode quanti, pur aderendo all'istinto proprio dell'uomo di dominare sugli altri si comportano con maggior giustizia rispetto alla potenza di cui dispongono. Pensiamo che se altri fossero entrati in possesso del nostro impero darebbero più chiaro risalto alla nostra moderazione, mentre dalla nostra equità è scaturito, del tutto fuori luogo, biasimo più che plauso.
77. "Sebbene infatti ci troviamo in condizioni di svantaggio rispetto agli alleati quando si discutono in casa loro processi relativi a trattati commerciali, mentre nei tribunali ateniesi vengono applicate norme del tutto imparziali, pure abbiamo fama di litigiosi. Ma nessuno esamina com'avviene che quanti posseggono in altre parti del mondo un dominio e con minor comprensione della nostra lo fanno valere sui loro alleati, non ne ricavino un tale biasimo. Chi ha licenza infatti d'usar la forza, non ha alcun bisogno di procedimenti giudiziari. I nostri alleati, per la consuetudine di intrattenere con noi rapporti d'assoluta parità, se in qualche sentenza patiscono un inaspettato rovescio o per una nostra decisione legale o per l'esercizio del nostro potere imperiale o per motivi diversi, non ci tributano gratitudine per aver conservato il più dei loro beni, ma si sdegnano per quanto vien loro sottratto, più profondamente che se noi, avendo fin dall'inizio cancellato ogni parvenza di legalità, esercitassimo sistematiche e inoppugnabili sopraffazioni. Allora neppur essi avrebbero negato la necessità che il debole sia soggetto al più forte. Quando subiscono un torto, com'è naturale, gli uomini si gonfiano di rancore più di quando sottostanno a una violenza: nel primo caso si ha l'impressione d'esser soverchiati da chi è eguale, nel secondo, di soggiacere a uno più forte. Per esempio, sottoposti dai Persiani a privazioni ben più dolorose di queste le tolleravano, ma la nostra signoria par troppo grave, è naturale; poiché la situazione presente è la più insopportabile per chi è soggetto. Se voi ci toglieste di mezzo e governaste al posto nostro, vedreste in breve tramontare il favore che ora godete, conseguenza diretta della paura che mai ispiriamo, qualora adottaste metodi uguali a quelli che lasciaste indovinare nel breve periodo di egemonia prima del conflitto persiano. Le usanze in vigore presso di voi sono incompatibili con quelle degli altri paesi e, per giunta, ognuno di voi, uscendo dalla propria città non si uniforma più ad esse, né a quelle in uso nel resto della Grecia.
78. "Ponderate la vostra decisione, che non è su questioni di piccolo momento: non vi lasciate indurre da sentimenti e recriminazioni altrui ad assumere un carico che sarebbe poi interamente vostro. Cercate di riflettere in anticipo alla dose d'imprevisto insita in una guerra, prima d'impegnarvi: una guerra, quando si prolunga, degenera di solito in un puro gioco della sorte, su cui nessuno dei due belligeranti, pari sotto questo rispetto, può esercitare un controllo, e il suo esito è sempre ignoto. Quando gli uomini entrano in guerra, si danno a precipizio all'azione: cosa che dovrebbero fare solo in un secondo momento. Solo quando subiscono le prime disfatte, si mettono a ragionare. Non abbiamo mai commesso questo errore, e vediamo che voi pure ne siete immuni. Perciò vi diciamo, fintanto che dipende ancora da entrambi la scelta di una decisione assennata, non sciogliete i patti e non trasgredite i giuramenti, risolvete le controversie secondo le convenzioni. In altro caso, ci siano testimoni gli dei che proteggono i giuramenti, se scatenerete la guerra vi respingeremo con ogni forza e coi mezzi che voi stessi ci avrete indicato."
79. Fu tale il contenuto delle parole ateniesi. Dopo aver dato ascolto alle accuse che gli alleati intentavano agli Ateniesi e all'intervento di questi ultimi, gli Spartani fecero allontanare tutti per tener consiglio, tra di loro, sullo sviluppo della situazione. I pareri dei più concordavano su un punto: il comportamento ateniese era illegale e bisognava scendere in guerra in gran fretta: ma si presenta Archidamo il loro re, considerato uomo capace e prudente, ed espone le sue osservazioni:
80. "Anch'io, o Spartani, ho esperienza di numerose guerre: come quanti vedo tra voi della mia stessa età. Quindi nessuno può desiderare la guerra per inesperienza, come a molti potrebbe accadere, né ritenerla utile e priva d'incognite. Se ponderaste saggiamente e a fondo questa guerra di cui ora si discute, trovereste che non è delle meno importanti. In confronto agli stati del Peloponneso e ai vicini, il nostro potenziale offensivo è pari, e sarebbe possibile scatenare un attacco in qualsiasi direzione, nel giro di pochissimi giorni. Ma ora la lotta è contro uomini che abitano una regione lontana e per di più espertissimi del mare; la loro preparazione militare è ottima e completa. Dispongono di possibilità finanziarie private e pubbliche, di flotte, cavalieri, armamenti, riserve d'uomini quante non esistono in nessun altro stato di Grecia, singolarmente considerato. Possono contare su un numero enorme di alleati soggetti a tributo. Come sollevare una guerra, così, alla leggera contro uomini simili? E su quali elementi fidarsi, per scaternarla a precipizio, senza adeguata preparazione? Sulla flotta? Siamo inferiori sul mare. Dovremo attendere per completare a nostra volta i preparativi bellici: ci vuol tempo. Sul denaro? Qui il nostro distacco è ancora più netto: la cassa pubblica ne è vuota e non possiamo esigerne sollecitamente dai privati.
81. "Qualcuno potrebbe alimentare i suoi propositi bellicosi con l'idea che li superiamo per armamenti e numero di soldati, e pensa che potremmo devastare il loro paese con ripetute irruzioni. Ma le terre su cui si stende il loro dominio sono molte e si riforniranno via mare di quanto mancano. Se poi cercheremo di far sollevare i loro alleati, bisognerà appoggiare i loro tentativi con le flotte, perché la maggior parte abita le isole. Che tipo di guerra condurremo dunque? Se infatti non li batteremo sul mare e non taglieremo loro l'afflusso di tributi con cui mantengono la loro forza navale, subiremo una completa disfatta. Non sarà allora decoroso per noi in queste condizioni riappacificarci, specialmente se prevarrà l'opinione che siamo stati noi i primi a sollevare la contesa. Non esaltiamoci neanche a quell'altra speranza che la guerra finirà in breve, se guastiamo il loro paese, temo piuttosto che la lasceremo in eredità ai nostri figli. Non è verosimile che gli Ateniesi, con la loro fierezza, si leghino schiavi alla propria terra né che, con la loro esperienza, si lascino piegare dalla guerra.
82. "Neppure comando di restare insensibili, e permettere che gli Ateniesi danneggino i nostri alleati, o di starli semplicemente a guardare mentre intessono le loro trame. Non agitiamo per il momento le armi. Inviamo ambasciatori ad Atene, presentiamo le nostre rimostranze: senza dichiarare troppo apertamente la nostra volontà di guerra, ma mostrando d'essere inflessibili. Nel frattempo badiamo a rafforzarci e a prepararci, procuriamoci alleati, tra i Greci e tra i barbari. Occorre che ci costituiamo una potenza navale e finanziaria (non è motivo di biasimo per quanti come noi, sono esposti agli attacchi di Atene, cercar l'appoggio non solo dei Greci, ma anche dei barbari, per salvarsi): frattanto sfruttiamo anche le nostre risorse. Se presteranno orecchio alle nostre missioni diplomatiche, tanto di guadagnato: in caso contrario nel giro di due o tre anni, se saremo ancora dell'avviso li attaccheremo forti di un allestimento militare più efficiente. Consideriamo inoltre che forse vedendo l'ampiezza dei nostri preparativi e confrontandola con il corrispondente tono delle nostre ambascerie saranno più invogliati a mostrarsi remissivi, mentre il loro paese sarà ancora incolume e le loro deliberazioni verteranno su fortune ancora intatte. Sappiate che per voi la loro terra è come un ostaggio, tanto più importante quanto meglio è coltivata: bisogna astenerci il più possibile dal rovinarla, per evitare che, spinti dalla disperazione, si difendano con più furiosa energia. Se, pressati dalla richiesta e dalle accuse degli alleati, ci risolveremo a devastare il loro paese, senza prepararci prima, guardate che non si abbattano sul Peloponneso, come coerente risultato, disonore e miseria. Le controversie tra gli stati e gli individui si possono sempre in qualche modo risolvere: ma se scoppia per motivi d'interessi particolari, una guerra comune, ché non è dato sapere come andrà a finire, non è facile uscirne con un pretesto onorevole.
83. "A nessuno sembri viltà la nostra esitazione, pur essendo in molti alleati, ad aggredire una città sola. Dispongono anch'essi di alleati non meno numerosi, che procurano loro fondi: la guerra non si combatte per lo più con le armi ma con il denaro, su cui si appoggiano le armi, soprattutto se è guerra di continentali contro gente di mare. Vediamo di procurarcene prima e molto: non lasciamoci trascinare in anticipo dalle proposte degli alleati. Poiché, qualunque sia l'esito della guerra, saremo noi a sopportarne le più gravi conseguenze, bisogna che le esaminiamo e le discutiamo con calma e in un certo tempo.
84. "La vostra lentezza e il vostro prender tempo, difetti che gli altri per lo più ci rimproverano, non vi siano motivo di vergogna. Agendo affrettatamente, terminereste l'impresa assai più tardi, per avervi posto mano senza i necessari preparativi. Eppure abitiamo una città libera e stimata da sempre. Dopo tutto, questo particolare del nostro carattere può ben essere interpretato come assennata prudenza. Per esso infatti noi soli non ci inebriamo nell'esaltazione dei successi e meno degli altri ci abbattiamo nelle sventure. Non può nulla su di noi il fascino dell'adulazione, se qualcuno intende eccitarci ad avventure rischiose oltre il limite che consideriamo ragionevole. Se altri ci pungola con i rimproveri, non per questo ci lasciamo indurre a una pronta adesione. Affondano nell'interiore equilibrio le radici della nostra virtù guerriera e della temperata saggezza. Eccelliamo nella prima perché essenzialmente dalla prudenza promana il senso dell'onore, il cui culto ispira il coraggio l'esser savi nelle nostre deliberazioni dipende strettamente dal sistema educativo cui siamo avvezzi, troppo essenziale e schietto per istillare nelle nostre menti l'irriverente sufficienza verso l'ordine legale, e troppo rigidamente severo per consentircene la trasgressione o il disprezzo. Senza dissipare la nostra intelligenza in vane e lambiccate sofisticherie senza spregiare gli armamenti del nemico con adorne parole tanto diverse dall'effettiva inerzia in cui, di solito, si risolvono, noi riteniamo che i disegni ostili non siano in sagacia inferiori ai nostri, perfettamente convinti che le impennate del caso non si possano imbrigliare e definire con la dialettica dei discorsi. In ogni circostanza la nostra preparazione militare obbedisce a un'idea fissa: che le forze nemiche sono altrettanto abili e preparate. Le nostre speranze di vittoria non si basano sulla convinzione che, prima o poi, l'avversario commetterà un errore: ma nella consapevolezza preventiva ed esatta dei nostri mezzi. Non differisce molto l'uomo dall'uomo: ma sempre è superiore colui che è stato educato alla più rigorosa disciplina.
85. "Non trascuriamo dunque questi fondamenti di vita, trasmessi dai padri, che abbiamo da sempre praticato con nostro vantaggio. Non decidiamo in fretta, nel giro di poche ore: si tratta di molte vite umane, della sorte di stati e di averi, del nostro prestigio. Ponderiamo bene: a noi è concesso, data la nostra potenza. Mandate messi ad Atene, che sollevino la discussione su Potidea, sui soprusi che gli alleati sostengono di subire, soprattutto ora che si dichiarano pronti a render ragioni: non è legale attaccare chi ha in sé questa disposizione, prima di chi commette un'aperta sopraffazione. Ma insieme preparate la guerra. Saran queste le decisioni più utili per voi, e più temibili per il nemico." Fu questo il contenuto del suo intervento. Si presenta da ultimo Stenelada, che era eforo in quel tempo, con queste parole rivolte agli Spartani:
86. "Non so che vogliano dire gli Ateniesi, con tutti quei loro bei discorsi: si son rivolti grandi lodi, è vero. Ma sul fatto che soverchiano illegalmente i nostri alleati che cosa han saputo ribattere? Se pure furono valorosi un tempo contro i Persiani, e con noi agiscono da scellerati, meritano un castigo doppio, perché il loro valore è degenerato in bassezza. Noi siamo immutati, adesso come allora; e se è vero che siamo prudenti non lasceremo nei guai i nostri alleati né indugeremo a soccorrerli: loro non hanno aspettato troppo a lungo la sventura. Gli altri si tengano pure i loro denari, le navi e i cavalli: a noi bastano bravi alleati, che non dobbiamo lasciare in mano agli Ateniesi. Né bisogna dirimere la questione con arbitrati e chiacchiere, dato che le loro aggressioni non avvengono certo a forza di chiacchiere. Corriamo in aiuto subito e con ogni mezzo. Nessuno ci venga a dire che dobbiamo riflettere, mentre subiamo un torto. Chi sta per commetterlo invece, conviene che ci pensi su a lungo. Votate dunque Spartani, in modo degno di Sparta: la guerra. Non consentite agli Ateniesi di farsi più potenti. Non lasciamo alla loro discrezione gli alleati; puniamo, col favore degli dei, chi li tormenta."
87. Dopo un tale discorso, mise egli stesso ai voti la questione, davanti all'assemblea spartana. Ma diceva di non poter distinguere quale acclamazione risuonasse più forte (votano infatti per acclamazione, non con il sassolino). Desiderando che col manifestare in modo più tangibile la loro opinione si eccitassero alla guerra, propose: "Chi di voi, Spartani, pensa che i patti siano rotti e la colpa ricada su Atene, si collochi da questa parte", e mostrava un settore dell'assemblea. "Chi è d'idea contraria da quest'altra". Alzatisi, si divisero e furono molti di più quelli che ritenevano interrotta la tregua. Fatti venire gli alleati rivelarono il responso dell'assemblea: gli Ateniesi erano colpevoli. Desideravano però invitare al voto tutti gli appartenenti alla lega, affinché, se la decisione fosse stata in questo senso, sollevassero una guerra comune. Acquisito questo risultato, gli alleati tornarono in patria e la missione ateniese si trattenne fino a espletare gli affari per cui era stata inviata. Questa deliberazione dell'assemblea, che cioè i patti dovevano considerarsi sciolti, è avvenuta nel quattordicesimo anno del trattato trentennale, stipulato dopo i fatti dell'Eubea.
88. La votazione spartana sui patti da considerarsi sciolti e sulla guerra da intraprendere, non è scaturita dall'opera di convinzione degli alleati, quanto dall'apprensione suscitata dalla potenza ateniese, in costante sviluppo. Vedevano infatti che Atene aveva le mani sulla maggior parte della Grecia.
89. Esporrò ora le circostanze che hanno preceduto e favorito l'avvento della potenza ateniese. Disfatti sul mare e nelle battaglie di fanteria, i Persiani si erano ritirati dalla Grecia; quanti di loro avevano cercato la salvezza dirigendo con la flotta a Micale, erano stati distrutti. Leotichida, re Spartano, che a Micale aveva avuto il comando sui Greci, fece ritorno in patria con gli alleati del Peloponneso. Gli Ateniesi invece e gli alleati della Ionia, e dell'Ellesponto che s'erano già ribellati al Re, proseguivano la lotta con l'assedio di Sesto, ancora in mano persiana. Svernarono laggiù e presero la città quando lo straniero l'abbandonò loro, facendo vela immediatamente dopo ciascuno verso le proprie sedi. Gli abitanti di Atene, dopo che l'invasore ebbe lasciato finalmente libero il loro paese, si dedicavano subito a ricondurvi i figli e le donne, dal luogo in cui li avevano posti in salvo, e a trasportarvi le suppellettili sottratte alla rovina. E si preparavano a far risorgere la città con le sue mura, la cui cerchia restava ancora in piedi per tratti brevissimi. Le case erano rase al suolo, quasi tutte: poche erano intatte, quelle in cui si erano sistemati i notabili persiani.
90. Gli Spartani, avuto sentore di ciò che gli Ateniesi avevano in animo di fare, inviarono messi. Vedevano di buon occhio che né Atene né alcun'altra città possedesse mura a difesa; gli alleati poi li incitavano in questo senso, temendo la potenza navale degli ateniesi, che in effetti prima non esisteva, e lo slancio guerresco di cui avevano fornito prova nella guerra persiana. Da Sparta si esigeva che Atene non elevasse mura: anzi, che collaborasse a demolire quelle che ancora cingevano le città esterne al Peloponneso. Naturalmente, i diplomatici spartani non svelavano agli Ateniesi il reale desiderio, misto a una sospettosa diffidenza, che il loro piano celava. Il pretesto era di sottrarre al barbaro, nel caso di un nuovo assalto, la possibilità di occupare teste di ponte fortificate, da cui muovere: come proprio di recente era accaduto, con Tebe. La giustificazione era che il Peloponneso costituiva un'area difensiva abbastanza ampia per tutti, e una base sufficiente per le operazioni di guerra. Ma gli Ateniesi, consigliati da Temistocle, licenziarono in gran fretta i messi spartani con le loro proposte, ribattendo che avrebbero inviato loro un'ambasceria a trattare della questione. Temistocle propose d'inviar lui, al più presto: scegliessero con calma gli altri componenti la missione e non li facessero partire subito. Era preferibile trattenerli fin quando il muro in costruzione si fosse elevato fino all'altezza necessaria per una difesa accettabile. Dovevano collaborare tutti senza distinzione, donne e fanciulli, alla fabbrica, ricavando da qualsiasi edificio, fosse privato o pubblico, senza riguardi, i materiali che risultassero utili all'opera, anche se si rendesse indispensabile demolire la città intera. Dopo aver disposto queste istruzioni, aggiunse che al resto avrebbe pensato da sé, e si mise in cammino. A Sparta prendeva tempo, non si presentava alle autorità, interponeva pretesti e giustificazioni. Quando qualche notabile spartano gli faceva chiedere perché tanto ritardo nel presentarsi, la sua risposta era che stava attendendo i colleghi di missione, probabilmente trattenuti ad Atene da qualche affare improvviso, ma ch'era certo della loro venuta, ormai imminente: si stupiva anzi che non fossero ancora arrivati.
91. Lo ascoltavano e gli davano credito, per il sentimento d'amicizia che ispirava loro. Ma quando incominciarono a venir altri da Atene, a denunciare senz'ombra di dubbio che la città si fortificava di mura ed i lavori erano già a buon segno, non era più possibile nutrire incertezze. Le voci approdano anche a Temistocle, che li esorta a non dar troppo credito alle chiacchiere: mandino invece ad Atene uomini loro, fidati, che vedano pure con i propri occhi, e tornino a riferire notizie finalmente chiare. Così fanno: ma intanto, in gran segreto, Temistocle spedisce ad Atene un suo uomo, con l'ordine di trattenerli il più a lungo possibile senza darne l'aria, e di non rilasciarli fino al loro ritorno (lo avevano raggiunto a Sparta i colleghi, Abronico figlio di Lisicle e Aristeide, figlio di Lisimaco, con la notizia che il muro era già a un livello rispettabile). Una vaga inquietudine lo molestava, che gli Spartani non avrebbero permesso loro di rimpatriare, quando fossero stati perfettamente certi di come si evolvevano le cose. Come Temistocle aveva consigliato, gli Ateniesi trattenevano gli ambasciatori: egli, recatosi dai magistrati di Sparta, rivelava ora senza reticenze che la sua città era protetta da una cerchia di mura, sufficiente alla difesa di tutti gli abitanti. Se gli Spartani o gli alleati volevano mandar loro ambasciatori, tenessero conto che avrebbero trattato con gente ben decisa a riconoscer distinti in futuro gli interessi propri da quelli comuni dei Greci. Quando s'eran risolti ad abbandonar la città e ad imbarcarsi, la decisione era sorta spontanea, e non ci fu nessun bisogno del consiglio spartano per osare. Inoltre, in ogni deliberazione concepita in accordo con loro, non erano mai risultati meno valenti in accortezza politica. In questo momento, ritenevano più sicuro per la propria città possedere una cinta murale, che più avanti avrebbe certo mostrato la propria utilità non solo per i cittadini d'Atene ma per tutti i loro alleati. Non era concepibile infatti di risolversi in futuro a qualche impresa comune, cui tutti partecipassero in condizioni di assoluta parità, se non si disponeva, fin dal principio, di potenziali bellici equivalenti. O entravano nell'ordine di idee che tutti gli alleati fossero sguarniti di difese murali, o accettavano di buon animo la nuova situazione, convinti della sua giustezza.
92. Gli Spartani stanno a sentire questo discorso senza dimostrare un'aperta animosità verso gli Ateniesi (scopo ufficiale delle loro ambascerie non era infatti di frapporre ostacoli alla costruzione delle mura, ma di consigliarli in amicizia dichiaravano, soprattutto allora che i loro rapporti erano ottimi, in virtù della decisione con cui Atene aveva fronteggiato lo straniero). Ma copertamente erano gonfi di livore per aver fallito nel loro disegno. Senza ulteriori proteste le due missioni tornarono in patria.
93. In questo modo gli Ateniesi si erano fortificati di mura in brevissimo tempo. È ancor oggi evidente che la costruzione è stata condotta in gran fretta. Le fondamenta infatti e le parti inferiori poggiano su strati di pietre grezze, di ogni forma talvolta neppure levigate per adattarle, ma disposte l'una accanto all'altra, come via via le venivano gettando. Sono state giustapposte perfino stele tombali e lastre, già lavorate per destinazioni diverse. Il perimetro della cerchia è stato ampliato ovunque oltre i confini precedenti della città e perciò devono aver ammassato ogni specie di materiale, nella febbre di concludere in fretta. Fu Temistocle ad esortarli a completare anche le opere difensive del Pireo (vi s'era posto mano già prima, nell'anno del suo arcontato). Riteneva adatta quella località, che disponeva di tre ripari naturali, ed era convinto che lo sviluppo d'Atene sul mare sarebbe stato di fondamentale importanza per la crescita della sua potenza politica (fu sua infatti l'originale audacia di proporre il mare come campo d'espansione per il futuro d'Atene) e collaborò subito a gettarne le fondamenta. Seguendo il suo piano, sorsero le mura, di cui ancor oggi è dato rilevare la larghezza, intorno al Pireo: due carri potevano trasportarvi il loro carico di massi, incrociandosi per poi procedere in direzioni opposte. L'interno non consisteva di ghiaia o di argilla, ma di enormi pietre squadrate e regolarmente giustapposte, connesse salde da ganci di ferro all'esterno e da piombo fuso nelle fessure. L'altezza fu elevata fino a metà dell'originario progetto. Era desiderio di Temistocle di contrapporre agli eventuali attacchi del nemico l'altezza imponente e lo spessore del baluardo. Riteneva che sarebbe così bastata la guardia di un gruppo ristretto d'uomini, i meno validi. Gli altri avrebbero preso posto sulle navi. Il suo pensiero era costantemente incentrato sulla flotta: era convinto, a mio parere, che un'eventuale armata del Re avrebbe più facilmente aggredito dal mare che da terra. Perciò considerava il Pireo più utile e sicuro della città alta e andava spesso proponendo ai suoi concittadini questo consiglio; nel caso di un attacco dal continente, si trasferissero giù nel Pireo e contrastassero qualunque nemico con la flotta. Così Atene si armò di fortificazioni e mise a punto gli altri dispositivi di difesa, dopo la ritirata dei Persiani.
94. Pausania, figlio di Cleombroto, era partito da Sparta per assumere il comando delle forze greche con venti navi del Peloponneso. Le affiancavano trenta navi ateniesi e un numero consistente di alleati. La spedizione era rivolta contro Cipro e gran parte dell'isola fu sottomessa. Si diressero poi verso Bisanzio, ancora possesso persiano, e vi posero l'assedio, agli ordini di Pausania.
95. La condotta prepotente di quest'uomo aveva già suscitato non lieve malumore negli altri Greci ma soprattutto negli Ioni e in quelli che si erano da poco affrancati dal dominio del Re. Presero quindi ad insistere con gli Ateniesi, affinché assumessero loro il comando, per i vincoli di stirpe che li univano, e non permettessero a Pausania di accanirsi in quel modo su di loro. Gli Ateniesi si mostrarono ben disposti a dar loro soddisfazione, lasciando intendere che non avrebbero tollerato nessun atteggiamento prevaricatore. Quanto al resto, avrebbero disposto nel senso a loro più vantaggioso. Quand'ecco, gli Spartani richiamano Pausania per interrogarlo sui fatti di cui è giunta voce. Sono molte e pesanti le critiche sollevate dai Greci che di tanto in tanto giungono a Sparta, sui suoi arbitri e illegalità. L'esercizio del suo comando ha piuttosto l'aria di modellarsi sulla tirannide. La citazione in tribunale lo raggiunge proprio nel momento in cui gli alleati, tranne le truppe del Peloponneso, passano agli Ateniesi, per l'odiosità che ispirava. A Sparta, fu ritenuto colpevole di certe irregolarità a danno di privati, ma sciolto dalle più gravi accuse: era principalmente imputato di sospetta inclinazione verso la Persia e, pareva, senza ombra di dubbio. Comunque, non è più proposto capo delle spedizioni armate. Sparta manda Dorchis, e altri colleghi di carica, con un ristretto contingente. Ma neppure a costoro gli alleati commisero più il supremo comando. Intuito il clima che li circondava, tornarono a Sparta, che in seguito non inviò più altri comandanti, nel dubbio che, fuori del suo controllo, degenerassero, come insegnava l'esperienza patita con Pausania. Gli Spartani volevano anche chiudere con la guerra persiana: riconoscevano agli Ateniesi, legati in quel momento da rapporti d'amicizia con loro, le doti di comando atte a perfezionare l'impresa.
96. Accettato in tal modo il comando che le forze alleate, avverse a Pausania, avevano loro spontaneamente offerto gli Ateniesi disposero l'entità delle quote in denari o armamenti navali, con cui ogni città doveva singolarmente contribuire alla comune lotta contro lo straniero. Fine dichiarato era quello di dar corpo a una lega che, devastando i paesi del Re, vendicasse le sofferenze patite. S'istituì per la prima volta allora, con sede in Atene, la carica di Ellenotami, con l'ufficio di esigere il "contributo" (si definì così il versamento contributivo in denaro, cui erano tenuti gli alleati). Il primo "contributo" fu fissato in quattrocentosessanta talenti. La tesoreria della lega era situata a Delo e le assemblee si radunavano nel sacro recinto.
97. Egemoni di una lega alleata, in cui vigeva dapprima l'indipendenza dei singoli membri, e l'uso di deliberare in assemblee plenarie, gli Ateniesi conseguirono una serie di progressivi successi militari, diplomatici e, più ampiamente, politici, nell'intervallo di tempo tra questa guerra e quella persiana, impegnati nella lotta contro il barbaro, contro gli alleati che manifestassero disegni di defezione e contro le città del Peloponneso che, di volta in volta, trovassero come ostacolo sulla loro strada. Ho descritto queste imprese aprendo una digressione nell'esporre la mia storia, in quanto tutti coloro che prima di me si sono occupati di opere storiche hanno trascurato questo spazio di tempo, concentrandosi o sull'epoca anteriore alla guerra persiana o propriamente su quest'ultima. Solo Ellanico, nella sua "Storia dell'Attica" ha toccato di scorcio l'argomento, ma troppo in breve e senza esattezza cronologica. Nello stesso tempo, si avrà dimostrazione di come si sia venuta costituendo la signoria d'Atene.
98. Come prima impresa, gli Ateniesi agli ordini di Cimone figlio di Milziade, occuparono e ridussero in servitù Eione, un possesso persiano sullo Strimone. In seguito assoggettarono Sciro, isola dell'Egeo dimora dei Dolopi e vi collocarono una loro colonia. Intrapresero poi una guerra contro i Caristi da soli, senza l'intervento delle altre città dell'Eubea e dopo un certo tempo vennero a un accordo. Organizzarono una campagna contro i Nassi, che erano in rivolta, e li piegarono con un assedio, primo esempio di una città alleata asservita contro i trattati in vigore nella lega, seguita poi via via da altre, in tempi e circostanze diverse.
99. Tra i numerosi motivi di defezione, primeggiavano il mancato versamento del "contributo", il rifiuto di consegnare le navi e la renitenza al servizio armato, quando toccava. Gli Ateniesi procedevano con inflessibilità; perciò le loro pretese pesavano intollerabili su gente che, non avvezza e meno disposta a durar fatiche, si vedeva costretta da un'energia ferrea a subire le privazioni e le miserie di una guerra continua. Anche per altri e diversi motivi gli Ateniesi esercitavano il comando non più circondati dal consueto favore. Non partecipavano infatti in parità di condizioni alle campagne: per loro era immensamente più facile piegare i ribelli. Ma di questo stato di cose si rendevano responsabili gli alleati stessi: per la loro renitenza al servizio armato, la maggior parte di essi, per poter restare a casa, si lasciava imporre il pagamento di una somma pari in valore alle navi non corrisposte. In tal modo cresceva la potenza navale degli Ateniesi, che vi impegnavano i fondi derivati dalle varie contribuzioni, e gli alleati quando accennavano a un tentativo di rivolta, si trovavano in guerra senza preparazione né esperienza.
100. Si è svolto, dopo tali avvenimenti, lo scontro di fanteria e di navi sull'Eurimedonte, fiume della Pamfilia, di Ateniesi e alleati contro i Persiani, con la vittoria ateniese ottenuta nello stesso giorno su entrambi i fronti, sotto gli ordini di Cimone, figlio di Milziade. Catturarono e distrussero circa 200 triremi fenicie. In un tempo successivo si verificò la rivolta dei Tasi, causata da controversie attinenti certi empori commerciali dislocati sulla costa della Tracia, loro antistante, e alla miniera che possedevano. Gli Ateniesi fan vela a Taso, danno battaglia con le navi e dopo il successo effettuano uno sbarco sul territorio nemico. Circa in quel tempo inviarono sullo Strimone diecimila coloni dei loro e alleati con l'intento di colonizzare la località detta allora Nove Vie, ora Anfipoli. Occuparono Nove Vie prima possesso degli Edoni; ma avanzati in terra di Tracia furono distrutti a Drabesco Dodonica dalle forze collegate dei Traci, che interpretavano la fondazione di una colonia in quel luogo, Nove Vie, come atto di scoperta ostilità.
101. I Tasi, sbaragliati sul campo e cinti d'assedio, invocarono il soccorso spartano, pretendendo che Sparta, per provvedere alla loro difesa e vendetta invadesse l'Attica. Quelli rispondevano con promesse, segrete agli Ateniesi, ma il loro effettivo intervento fu impedito da un terremoto, in occasione del quale esplose anche la rivolta degli Iloti dei Perieci di Turia e degli Etei, che si rifugiarono a Itome. La maggior parte degli Iloti discendeva dagli antichi Messeni, ridotti schiavi in tempi lontani: perciò avevano tutti il nome di Messeni. Sparta dovette così sostenere una guerra contro quelli che si erano asserragliati in Itome, con la conseguenza che i Tasi dopo tre anni d'assedio, si arresero agli Ateniesi a condizione di demolire le loro mura e consegnare le navi. Versarono immediatamente la dovuta imposta, con l'impegno di contribuire in modo regolare per il futuro. Persero i possessi del continente e la miniera.
102. La guerra contro i rivoltosi chiusi in Itone si trascinava per le lunghe, finché Sparta decise di chiedere man forte agli alleati tra cui agli Ateniesi, che si presentarono con un esercito numeroso, agli ordini di Cimone. Il loro aiuto era il più richiesto, poiché avevano fama di esperti ed abilissimi nelle operazioni di assedio, ma essendosi questo, intorno a Itome, protratto già a lungo, il loro vanto parve impari alle effettive qualità militari: altrimenti avrebbero conquistato la rocca d'impeto. Emerse drammaticamente per la prima volta in occasione di questa campagna l'attrito tra Spartani e Ateniesi. La tenacia della piazzaforte, imprendibile di slancio e la molesta diffidenza istillata dalla sciolta audacia del carattere degli Ateniesi e dalla loro sovversiva inclinazione alle novità (mista al netto sentimento di appartenere a stirpi diverse) suscitavano non lieve inquietudine negli Spartani. Li tormentava il timore che protraendo l'assedio, il contatto con i ribelli di Itome ispirasse agli Ateniesi chissà che eversiva e rivoluzionaria macchinazione. Perciò idearono di rinunciare al loro aiuto, e di contare su tutti gli altri alleati. Naturalmente non rivelarono il sospetto che li agitava, limitandosi ad osservare che il loro appoggio era divenuto superfluo. Gli Ateniesi intuirono immediatamente che quello era un puro pretesto, neppure il più abile, per allontanarli. Certo doveva esser sorto qualche diverso e non dichiarato motivo di diffidenza nei propri riguardi: ne concepirono una sdegnata amarezza, convinti nell'intimo di non meritare una offesa tanto bruciante da quelli di Sparta. Al loro ritorno in Atene seguì l'immediato scioglimento del patto difensivo attuato con Sparta contro i Persiani, e la creazione di una nuova sfera d'intese politico militari con gli Argivi, i nemici più accaniti di Sparta, e contemporaneamente con i Tessali: un blocco di alleanze sancito da giuramenti comuni.
103. In Itome si resisteva da dieci anni, finché, non potendo più reggere lo sforzo della difesa, i ribelli scesero a trattare con gli Spartani, ottenendo di partire, sotto garanzia d'incolumità, dal Peloponneso, a patto di non tentarvi mai più il ritorno. Chi di loro fosse sorpreso in quella terra, sarebbe stato schiavo di chi l'avesse arrestato. Ancor prima della guerra un vaticinio di Apollo Pizio aveva ingiunto agli Spartani che presso di loro fosse sempre lasciato andare chi si fosse appellato supplice a Zeus di Itome. Uscirono dunque dalla fortezza e da quel paese con i figli e le donne: furono accolti dagli Ateniesi che, pieni di rancore contro gli Spartani, li collocarono come coloni a Naupatto, un'isola che avevano recentemente occupato, un antico possesso dei Locri Ozoli. Anche quelli di Megara cercarono l'appoggio dell'alleanza ateniese, dopo essersi staccati da Sparta, in quanto i Corinzi li tenevano impegnati in una lunga guerra per questioni di confine. Così gli Ateniesi s'impossessarono di Megara e di Peghe, elevarono in difesa dei Megaresi le lunghe mura che collegano la città al porto di Nisea, guarnendole con proprie scorte armate. L'accanita avversione che divise poi sempre Ateniesi e Corinzi, deve essenzialmente a questo fatto la sua prima origine.
104. In quel tempo Inaro figlio di Psammetico, di razza libica, signore dei Libici che confinano con l'Egitto, partendo da Marea, la città soprastante Faro, istigò la maggior parte dei centri d'Egitto a sollevarsi contro il re Artaserse, e divenuto lui stesso re sollecitò l'appoggio degli Ateniesi. Costoro (si trovavano sulla rotta per Cipro, con duecento navi da guerra, tra le loro e quelle degli alleati) accorsero, trascurando l'impresa di Cipro. Entrarono con la flotta nel Nilo, lo risalirono e ne sottoposero a controllo il corso, occuparono i due terzi della città di Menfi e sferrarono un attacco a quell'ultimo settore urbano che ha nome Mura Bianche, dove si erano ritirati i Medi e i Persiani che avevano trovato salvezza nella fuga e quanti tra gli Egizi non avevano aderito all'insurrezione.
105. Intanto un gruppo di soldati ateniesi, sbarcato ad Alie, si scontrò con Corinzi ed Epidauri, uscendone disfatto. Tempo dopo gli Ateniesi attaccarono una squadra di navi del Peloponneso nelle acque di Cecrifalea e la sconfissero. Esplose poi una guerra tra Egina ed Atene ed ebbe luogo un ingente scontro navale nel mare di Egina. I belligeranti erano affiancati dai rispettivi alleati. La vittoria fu degli Ateniesi con la cattura di settanta navi. Segui uno sbarco in territorio nemico e un assedio, condotto da Leocrate figlio di Strebo. Poco tempo intercorse e i Peloponnesi, impegnatisi alla vendetta e alla difesa di Egina, mobilitarono trecento opliti, già truppe ausiliarie dei Corinzi e degli Epidauri, trasportandoli sull'isola. Nel frattempo i Corinzi con gli alleati avevano occupato la catena montagnosa di Gerania e di lì erano calati nella Megaride, calcolando che sarebbe riuscito impossibile agii Ateniesi accorrere alla difesa di Megara, poiché molte delle loro milizie erano dislocate parte ad Egina, parte in Egitto. La loro speranza era anche che, quand'anche spedissero forze in soccorso, dovessero togliersi da Egina. Ma gli Ateniesi non spostarono il contingente stanziato ad Egina: furono i più anziani e i più giovani, cioè quelli rimasti in città, a partire per Megara, sotto gli ordini di Mironide. La mischia con i Corinzi si risolse con un esito sostanzialmente equilibrato; i due eserciti si separarono, persuasi entrambi di non aver riportato la sconfitta in campo. Furono gli Ateniesi che, a dire il vero, avevano conseguito un nuovo vantaggio) a elevare un trofeo dato l'allontanamento delle truppe corinzie, mentre questi ultimi, tacciati di codardia dai più anziani rimasti in città, e dopo essersi riorganizzati, trascorsi circa dodici giorni, ritornarono a contrapporre a quello ateniese anche un proprio trofeo, per significare che il successo era toccato a loro. Frattanto gli Ateniesi irrompono da Megara e annientano l'esiguo gruppo di quelli che si occupavano del trofeo da erigere; si scontrano anche con gli altri, sconfiggendoli.
106. I Corinzi battuti ripiegavano. Un gruppo piuttosto consistente, cedendo alla pressione nemica, si precipita in rotta in direzione sbagliata e piomba in un terreno di proprietà privata, delimitato intorno da un fossato fondo e ampio, privo di vie d'uscita. Gli Ateniesi non tardarono a intuirlo: lo bloccarono di fronte con gli opliti e schierati intorno al fosso, a cerchio, quelli di armatura leggera, fecero lapidare fino all'ultimo i nemici incappati in quella trappola. Fu un disastro gravissimo per Corinto. Il nerbo dell'esercito riuscì tuttavia a tornare a casa.
107. Fu circa a quell'epoca, che gli Ateniesi posero mano alla costruzione delle lunghe mura, collegando la città al mare, da una parte fino al Falero, dall'altra al Pireo. Apprendendo che i Focesi avevano invaso la Doride, madrepatria degli Spartani, con obbiettivo Beo, Citinio ed Erineo, cittadine di cui avevano già occupato la prima, Sparta inviò truppe di soccorso a quelli di Doride, agli ordini di Nicodemo figlio di Cleombroto, che sostituiva il re Pausania, figlio di Plistoanatte, ancor troppo giovane: si mossero millecinquecento opliti dei loro e diecimila alleati. Costrinsero in breve i Focesi alla resa e alla restituzione della città. Concluse le operazioni decisero il rientro in patria. Non era facile: la flotta ateniese, che aveva effettuato il periplo del Peloponneso, stazionava nel golfo Criseo, pronta a bloccarli se avessero tentato la traversata in quel tratto di mare. Anche il ritorno via terra, attraverso le alture Geranie, non pareva cammino esente da rischi, con gli Ateniesi che presidiavano Megara e Peghe. Era tra l'altro una strada dirupata, quasi impraticabile, guardata in permanenza da postazioni ateniesi, e s'era sparsa la notizia che anche per quella parte gli Ateniesi si preparavano a ostacolarli. Non rimaneva pertanto che temporeggiare in Beozia, vagliando accuratamente le prospettive di ritorno che presentassero meno gravi pericoli. Non mancarono perfino uomini d'Atene che, con trattative segretissime, li incitavano a dirigersi da loro: avevano speranze di soffocare il partito democratico e far sospendere l'erezione delle lunghe mura. Si presentarono ad affrontarli a un tratto gli Ateniesi al completo, con mille Argivi e con i singoli effettivi provenienti da ciascun paese della lega: si ritrovarono in campo quattordicimila uomini. Li animava la certezza che il nemico si dibattesse in gravi difficoltà, non avendo via d'uscita: per questo, e per la diffusa impressione che qualche complotto si stesse tramando per rovesciare la democrazia scatenarono l'attacco. Si posero a disposizione degli Ateniesi anche i cavalieri Tessali, secondo il testo dell'alleanza, ma passarono al nemico appena s'accese lo scontro.
108. La battaglia divampò in località Tanagra, in Beozia: la vittoria tocca a Sparta e ai suoi, ma le perdite sono ingenti sui due fronti. Gli Spartani si misero subito in marcia per la Megaride, ne raggiunsero e devastarono il territorio, rientrarono in patria per le alture della Gerania e attraverso l'istmo. A sessantadue giorni dalla battaglia, gli Ateniesi con lo stratego Mironide aggredirono i Beoti e sconfittili presso Enofita dilagarono per la Beozia e la Focide, fecero demolire le muraglie a difesa di Tanagra, intimarono ai Locri Opunzi l'immediata consegna di cento ostaggi scelti tra i concittadini più facoltosi. Perfezionarono in quel tempo la fabbrica delle lunghe mura. Non molto dopo questi fatti anche quelli di Egina cedettero agli Ateniesi: subirono l'abbattimento del loro muro, la consegna delle navi, l'imposizione di un tributo da versare in seguito per sempre. Compivano frattanto gli Ateniesi il periplo del Peloponneso, sotto il comando di Tolmide, figlio di Tolmeo. Riuscirono a incendiare l'arsenale spartano, a occupare Calcide, un centro corinzio, a piegare i Sicioni in uno scontro, seguito a uno sbarco sulla loro terra.
109. Gli Ateniesi e gli altri della lega, impegnati in Egitto, vi si trattenevano già da gran tempo protagonisti di alterne vicende di guerra. In una prima fase, gli Ateniesi erano riusciti a impadronirsi dell'intera estensione dell'Egitto, quando il re mandò a Sparta un persiano, tale Megabazo, fornendolo di risorse finanziarie ingenti con l'intento di indurre i Peloponnesi a invadere l'Attica, e la conseguente speranza che gli Ateniesi fossero costretti a sgomberare dall'Egitto. Missione improduttiva la sua, con il denaro che s'involava per vie traverse, senza effetto: sicché Megabazo, con l'oro che gli restava, rimpatriò. Al posto suo e dell'oro, il re spedisce Megabizo, figlio di Zopiro, e un esercito potente. Al suo arrivo costui annientò gli Egizi e gli alleati in una battaglia terrestre: strappò da Menfi i Greci e li incalzò fino a bloccarli sull'isola Prosopitide, e ve li tenne assediati per un anno e sei mesi. Alla fine, prosciugando il canale con la deviazione delle sue acque, ridusse in secca le navi ateniesi e, congiunta al continente la maggior parte dell'isola, vi condusse le sue milizie e la prese.
110. Dopo sei anni di lotta le forze greche patirono quella rovinosa disfatta: furono pochi, dei molti ch'erano partiti, a trovare salvezza a Cirene, attraverso la Libia. I più erano caduti. L'intero Egitto tornò sotto il dominio del re, tranne Amirteo, che signoreggiava ancora sulle paludi, intorno al corso inferiore del Nilo. Le milizie del re, non erano in grado di occupare questa che è la zona più ampia del paese e che ospita gli abitanti della palude, i più accaniti combattenti d'Egitto. Il signore di Libia, Inaro, autore del complesso moto insurrezionale in Egitto, catturato con il tradimento, fu ucciso con il supplizio del palo. Intanto, cinquanta triremi ateniesi e di altri alleati, che recavano truppe fresche in Egitto, approdarono alla foce di Mendes, completamente ignare degli ultimi sviluppi. Da terra si scagliarono su di loro le fanterie nemiche, dal mare un contingente di Fenici distrusse la maggior parte della flotta; il resto, un minimo numero di navi, si volse in fuga, a precipizio, sulla via del ritorno. Fu questa la conclusione dell'imponente sforzo bellico che gli Ateniesi e i loro alleati avevano prodotto in terra egizia.
111. Oreste, figlio del re tessalo Echecrate, tentò d'indurre Atene a rimpatriarlo. Mobilitate le milizie beote e focesi, allora alleate, gli Ateniesi marciarono su Farsalo, città tessala. Presero a occupare il territorio, senza tuttavia allontanarsi troppo dall'accampamento, poiché i cavalieri tessali lo impedivano. Ma non riuscirono a conquistare la città, né a conseguire qualcuno degli obiettivi in vista dei quali avevano organizzato la spedizione. Dovettero rimpatriare, con Oreste e a mani vuote. Non passò molto tempo e mille ateniesi, equipaggiate le navi all'ancora presso Peghe, (la base era ancora in mano agli Ateniesi), sfilarono lungo la costa, fino a Sicione, al comando di Pericle, figlio di Santippo..Effettuarono uno sbarco e quelli di Sicione, che tentavano di opporsi, furono battuti in uno scontro. Mobilitarono in fretta, subito dopo, gli Achei e attraversato con loro il braccio di mare che li separa dall'Acarnania si diressero a Eniade, la assediarono, ma senza successo. Seguì subito il rientro in patria.
112. Trascorrono tre anni da questi fatti d'armi, e tra Ateniesi e Peloponnesi si stipula un patto quinquennale. L'asse degli interessi militari ateniesi si spostò quindi dalla Grecia, orientandosi su Cipro. Cimone, con una flotta di duecento navi ateniesi e alleate, assunse il comando della nuova impresa. Sessanta navi furono però dirottate in Egitto, su richiesta di Amirteo, che regnava ancora sulle paludi; le altre si accingevano al blocco di Cizio. La morte di Cimone e l'imperversare di una carestia li indussero a ripiegare da Cizio. Incrociando nelle acque di Salamina Cipria, vennero a contatto con forze fenicie ciprie e cilicie, impegnandole in mare e in uno scontro terrestre. Vinsero sui due fronti e ripresero la rotta verso la patria: erano con loro anche le navi reduci dalla diversione in Egitto. Nel periodo successivo a questo gli Spartani intrapresero la guerra cosiddetta sacra. Si impadronirono del santuario di Delfi e lo riconsegnarono agli abitanti del paese. Non impiegarono gran tempo gli Ateniesi, dopo la loro partenza, a comparire con un esercito, riprendere il santuario e riconsegnarlo ai Focesi.
113. Poco dopo gli ultimi avvenimenti narrati i fuoriusciti Beoti che tenevano Orcomeno, Cheronea, e qualche altra piazzaforte della regione, subirono l'urto di mille opliti ateniesi con il rinforzo di singoli reparti alleati, agli ordini di Tolmide, figlio di Tolmeo. La conquista di Cheronea e l'asservimento dei suoi abitanti segnò l'esito di quest'impresa: in Beozia rimasero guarnigioni ateniesi. Mentre gli altri, poco fuori Cheronea, sono in marcia per rientrare, si vedono piombare addosso i profughi beoti di Orcomeno spalleggiati dai Locri, dagli esuli eubei e da quanti partecipavano con loro della stessa fede politica. L'assalto ebbe successo: il contingente ateniese fu annientato, pochi i prigionieri vivi. Gli Ateniesi lasciarono libero tutto il territorio beota, concludendo un trattato che consentiva il recupero dei loro uomini, prigionieri o caduti. I fuoriusciti beoti rimpatriarono e con tutti gli altri riacquistano l'indipendenza.
114. Non intercorse molto tempo da questi ultimi avvenimenti alla ribellione esplosa in Eubea. Pericle era già passato nell'isola con un corpo di spedizione ateniese, quando la raggiunsero preoccupanti notizie, che cioè anche Megara si era sollevata, che i Peloponnesi preparavano un'invasione in Attica, che le guarnigioni ateniesi erano state annientate da quelli di Megara, tranne i pochi che erano riusciti a trovar scampo a Nisea. I ribelli di Megara avevano sollecitato rinforzi da Corinto, Sicione, Epidauro. Pericle procedeva allora all'immediato rientro del suo esercito d'Eubea. Quasi contemporanea scattò l'invasione dell'Attica da parte dei Peloponnesi, che agli ordini di Pausania, re spartano, penetrarono fino a Eleusi e a Trio, devastando il paese. L'avanzata non si spinse oltre; rientrarono così alle basi di partenza. La circostanza si offrì propizia ad Atene per effettuare un secondo sbarco in Eubea. Con Pericle stratego l'assoggettarono intera, sistemando conformi ai loro interessi gli ordinamenti politici dei vari centri isolani, mediante trattati: solo gli Estiei furono espulsi e costretti a cedere la loro terra.
115. Dopo il rimpatrio delle forze ateniesi che avevano operato in Eubea, furono sanciti con Sparta e i suoi alleati) patti di pace trentennali, tra cui si contemplava la riconsegna di Nisea, Peghe, Trezene e l'Acaia, tutte località peloponnesiache ancora in possesso di Atene. Trascorsi cinque anni, scoppiò tra quelli di Samo e i Milesi una guerra per Priene: la sconfitta patita in campo militare dai Milesi li indusse a spedire una missione ad Atene, che esprimesse con forza le loro rimostranze contro i Sami. Vi si aggregavano anche cittadini di Samo stessa, desiderosi di rivolgimenti politici in patria. Gli Ateniesi, convinti, comparvero a Samo con quaranta navi, vi istituirono una costituzione democratica, garantendosi con cinquanta giovani presi in ostaggio e altrettanti uomini, trasportati al sicuro nell'isola di Lemno. Stabilitavi una guarnigione, gli altri rientrarono. Alcuni di Samo però, incapaci di tollerare oltre quel clima politico, esularono nel continente. Ottenuto il sostegno dei personaggi in quel momento al vertice della vita politica cittadina e l'alleanza militare di Pissutne, figlio di Istaspe, signore in quell'epoca di Sardi, raccolto un corpo di circa settecento ausiliari, una notte passarono a Samo. L'attacco al partito democratico fu la loro prima azione, con l'immediato arresto dei personaggi più considerevoli: procedettero subito dopo alla liberazione dei loro ostaggi, rinchiusi in Lemno, e alla ribellione aperta contro Atene, consegnando a Pissutne i componenti le guarnigioni e le autorità ateniesi che soggiornavano a Samo. Infine, si accingevano a una rapida preparazione della campagna contro Mileto. Si sollevarono anche quelli di Bisanzio, sul loro esempio.
116. Alla notizia, gli Ateniesi misero sulla rotta per Samo sessanta navi da guerra, tra cui però sedici fecero vela parte verso la Caria, per sorvegliare le mosse della flotta fenicia, il resto verso Chio e Lesbo, per presentare una richiesta d'aiuto. Con le altre quarantaquattro, Pericle con altri nove strateghi, impegnò in una mischia, nelle acque di Traghia, settanta navi dei Sami, tra cui venti adibite a trasporti militari (stavano tutte tornando da Mileto). La vittoria fu ateniese. Quaranta navi di rinforzo salparono subito da Atene e venticinque giunsero da Chio e da Lesbo. Dopo lo sbarco e una vittoria conseguita in uno scontro terrestre, procedevano all'assedio della città con l'erezione di mura sui tre lati di essa, e bloccando dal mare il quarto. Pericle, dalla flotta che partecipava all'assedio, prelevò sessanta navi per accorrere a tutta forza verso Cauno in Caria, da dove era giunta notizia che unità fenicie muovevano contro di loro. Infatti anche da Samo, Stesagora ed altri erano salpati con cinque navi per congiungersi con la flotta fenicia.
117. La circostanza propizia permise a quelli di Samo di operare un fulmineo assalto dal mare sulla squadra navale all'ancora, scoperta e priva di protezione. I navigli di vedetta furono subito affondati, le unità che salparono contro di loro per contrastare l'aggressione, furono travolte e vinte. Tennero quindi per quattordici giorni sotto controllo armato lo specchio di mare che si apre davanti alla loro costa permettendo così tranquillamente di esercitarvi in ogni direzione il trasporto di tutti i beni di consumo a loro necessari. Il ritorno di Pericle con la squadra ai suoi ordini permise agli Ateniesi di ripristinare un efficace blocco dal mare. Salpò poco dopo da Atene una flotta di rinforzo, costituita di quaranta navi agli ordini di Tucidide, a Agnone e Formione, venti comandate da Tlepolemo e Anticle, trenta da Chio e da Lesbo. I Sami si batterono una volta sul mare, in uno scontro di breve durata ed entità ma in nove mesi d'assedio la loro forza e la capacità di resistenza si affievolirono, finché, costretti a capitolare, accettarono le condizioni seguenti: l'abbattimento del loro muro, la consegna di ostaggi e della flotta, il risarcimento a rate delle spese belliche. Anche a quelli di Bisanzio non rimase che sottoporsi ancora al loro precedente stato di sudditi.
118. Erano trascorsi pochi anni dalle ultime vicende narrate, quando si verificarono i casi, già riferiti, di Corcira e Potidea e gli incidenti che costituirono il motivo dichiarato per lo scoppio di questa guerra. Questo complesso quadro di operazioni militari e politiche, di rapporti reciproci tra Greci e con popolazioni straniere, si estende nel periodo di cinquant'anni circa che corre tra la ritirata di Serse e l'esplosione di questa guerra. Furono anni per Atene d'intensa e fruttuosa attività espansiva con l'ampliamento e l'energica organizzazione dell'impero e un impulso vigoroso, all'interno, della sua potenza economica e militare. Gli Spartani avvertivano questa crescita pericolosa, ma non sapevano frapporvi che limiti e ostacoli di breve respiro. Preferivano in più occasioni, una politica di acquiescenza: non avevano mai avuto, neanche prima, la dote della fulmineità nel risolversi a una guerra. Occorreva in genere che vi fossero costretti, senza alternative: e in più fu un periodo difficile e inquieto per Sparta, sconvolta dalle sommosse civili. Ma alla fine la potenza d'Atene s'era imposta, rigogliosa e superba all'attenzione del mondo: perfino la sfera d'influenza e d'alleanza tradizionalmente legata a Sparta non era immune dai suoi attacchi. La situazione critica suggerì agli Spartani che la loro supina linea di condotta era ormai superata; si doveva sferrare, loro per primi, un'offensiva, gettarvi ogni energia e demolire, se fosse possibile, quella molesta e invadente potenza. Gli Spartani erano dunque giunti alla convinzione che i patti fossero stati violati e che la responsabilità ricadesse su Atene. Mandarono quindi una delegazione a Delfi, a interrogare l'oracolo, se la guerra rappresentasse per loro la scelta migliore. Corre voce che la risposta fosse concepita in questi termini: se avessero profuso nella guerra ogni sforzo, la vittoria era loro; per parte sua, il dio rivelò che li avrebbe assistiti in ogni caso, sia invocato, sia senza suppliche.
119. Ne scaturì l'ordine, per gli alleati, di una nuova convocazione: si desiderava che deponessero il loro voto sulla necessità di affrontare il conflitto. Affluirono le missioni inviate dai paesi del patto e s'adunò un consesso, in cui molti si presentarono a esporre le loro rimostranze: si trattava in genere di accuse contro Atene e di esplicite volontà di guerra. I Corinzi, dopo avere in precedenza avanzato passi non ufficiali verso le altre delegazioni per sollecitarle a votare la guerra (erano in ansia per Potidea, temevano che la situazione laggiù degenerasse, prima di una positiva conclusione dell'assemblea); alla fine, comparvero davanti a tutti e tennero questo discorso:
120. "Sarebbe ormai fuori luogo, o alleati, che noi imputassimo agli Spartani di non aver essi stessi deliberato la guerra e di averci invece qui tutti riuniti per discutere e decidere su questo problema. Ed è giusto: giacché è dovere delle potenze dominanti amministrare con particolare scrupolo e prudenza i comuni interessi dei paesi inclusi nelle loro orbite politiche, oltre naturalmente ai propri, con principi di equità. Onde si giustifica il superiore e generale prestigio di cui godono nelle altre circostanze. Chi di voi ha già sperimentato qualche rapporto con Atene non ha bisogno di particolari avvertimenti, perché ne stia in guardia. I paesi dell'entroterra piuttosto e quanti non abitano le zone costiere devono fermamente convincersi che se non collaborano alla difesa delle città marine diverrà per loro difficoltoso usufruire di comodi e sicuri nodi di smercio delle derrate agricole e dei prodotti affluenti dal mare e diretti all'interno. Non valutino le questioni qui trattate con superficialità distratta convinti che non concernano intimamente i loro interessi. Accolgano quest'idea, questa eventualità: se lasciano al loro destino i centri costieri, il pericolo potrebbe minacciare anche loro, un giorno. Nella assemblea attualmente riunita, il loro voto riguarda sé stessi, non meno che gli altri. Nessuna esitazione dunque nell'abbandonare la pace per la guerra. Gli uomini ragionevoli vivono in quiete, se nessuno fa loro un torto: ma chi è forte prende subito le armi, se offeso, pronto, all'occasione favorevole, a interrompere le ostilità e intavolare trattative. Resta immune dalla eccitazione che i successi militari ispirano. Si ribella all'oltraggio e accantona l'amabile serenità di un'esistenza in pace. Pericoloso ed effimero incanto, per chi se ne lascia sedurre e rinuncia all'azione. Se coltiva placidamente l'inerzia che tanto l'allieta e che gli fa balenare così remota la necessità di combattere rapidamente essa gli sarà strappata. Ma anche chi concepisce per qualche felice episodio di guerra un insensato ardimento, non pondera da che fragile e temeraria illusione si slancia il suo volo di speranze. Giacché spesso difettosi e deboli progetti s'imbattono in avversari ancor più sventati, e riescono compiutamente: non meno infrequenti i casi di consigli ritenuti ottimi, dimostratisi in pratica disastrosi e fonte di discredito. Concepire un disegno e proseguirne con intatta fiducia l'attuazione, è impresa impossibile. Un senso di sicurezza pervade i momenti dell'ideazione, ma nella fase esecutiva di un piano, un accorato sgomento ci coglie per via e ci frena.
121. "La nostra volontà di guerra scaturisce da un'ingiuria patita e da ragioni ben valide di risentimento. Ottenuta la punizione di Atene, cesseremo le ostilità, nel tempo opportuno. Molti elementi concorreranno alla vittoria finale, come si può prevedere. Principalmente dominiamo il nemico per numero di combattenti ed esperienza bellica; poi, la nostra azione offensiva è un disciplinato e concorde impeto, appena si riceve il comando. Quanto alla marina, considerata loro punto di forza, si provvederà attingendo in parte alle disponibilità di ciascuno e in parte ai tesori custoditi in Delfi e in Olimpia: prestito che ci consentirà ai sottrarre agli Ateniesi, con l'offerta di una mercede più sostanziosa, i loro equipaggi formati da forestieri. Il nerbo della loro flotta militare è mercenario, non cittadino. Il nostro esercito subirà in misura minore questo rischio, poiché trae la sua forza dagli uomini, non dal denaro. Una sola vittoria sul mare ci basterà: saranno perduti. Se dovessero resistere, ci eserciteremo anche noi a lungo nell'arte di combattere sulle navi. Quando avremo conseguito una eguale perizia, li schiacceremo sotto un'altra superiorità: quella del coraggio. Virtù che la natura stessa ci istilla alla nascita e che nessun insegnamento potrà loro fornire. Noi invece possiamo annullare, con l'allenamento, lo svantaggio che ci separa dal loro livello di destrezza tecnica. Procureremo noi i mezzi economici indispensabili a questo scopo. Sarebbe un'infamia se, mentre i loro alleati non ricuseranno di versare quei tributi che servono a mantenere e rafforzare i loro ceppi, noi non vorremo sostenere le spese per la vendetta sul nemico e per la nostra stessa libera sopravvivenza, e per difenderci, quando ci aggrediranno per spogliarci dei nostri beni, di cui poi disporrebbero per alimentare la guerra e per distruggerci.
122. "Ci si prospettano anche diversi metodi di guerra: far sollevare gli stati della loro lega (sarebbe il blocco più efficace delle entrate, fonte essenziale della loro potenza); piazzare fortilizi nell'Attica e altri dispositivi di lotta che sarebbe difficile qui anticipare. Il corso della guerra non si incanala in leggi immobili; per lo più possiede regole proprie, secondo le quali s'evolve, e che occorre opportunamente sfruttare, al variare delle contingenze. Principale norma è che chi vi s'accinge con fredda determinazione procede più sicuro. Il furore conduce a precipizio nelle catastrofi più rovinose. Riflettiamo: le singole divergenze che possono opporre ciascuno di noi ai suoi avversari, questioni di confini e simili, appaiono, nel loro complesso, un tollerabile fenomeno della convivenza tra stati. Ora, gli Ateniesi posseggono forze in campo bastanti non solo a contrastarci in massa, ma, evidentemente, a dominare ogni nostra città, di per sé considerata. Quindi, se non li affronteremo in un saldo blocco, nazione con nazione, città con città, forti di un deciso e unico volere, faranno leva sulla nostra, divisione e ci soggiogheranno uno per uno, senza sforzo. La sconfitta produrrà un asservimento certo e immediato: realtà dolorosa! Il cui timore, anche se solo espresso a parole, disonora il Peloponneso: che un tal numero di città sia sopraffatto da una sola! Circostanza che, se si verificasse, dimostrerebbe che la nostra ignominia è meritata, o che stiamo soggetti per codardia, indegni dei nostri padri, che procurarono alla Grecia la libertà: un valore che ormai non siamo più in grado di difendere. Permettiamo che una città affermi la sua tirannide, mentre mostriamo la volontà d'abbattere i despoti, in qualunque paese si trovino. Non sapremmo come difendere questa linea politica, dimostrarla esente dalle tre più disastrose aberrazioni: il rozzo ingegno, la fiacchezza, l'incuria. Giacché, proprio per non aver evitato questi errori vi siete ridotti a quello sdegno sprezzante del nemico che ha già amaramente punito moltissimi, e che dall'illusione ingannevole con cui persiste nell'irretire le sue innumerevoli vittime ha cangiato il suo in un nuovo e tristo nome: follia.
123. "È vano recriminare sui fatti passati, più di quanto sia utile alla situazione attuale. Occorre invece provvedere alle esigenze del presente, mirando al futuro, senza risparmio di energie e fatiche; (è una vostra virtù tradizionale d'uscire sempre più rinfrancati dai pericoli). Non rinnegate la vostra dirittura morale, se oggi potete contare su una certa superiorità di ricchezza e di mezzi; (non è giusto che dissipiate nel momento d'attuale abbondanza le fortune accumulate durante il periodo di povertà). Avete molti motivi di fiducia per approntare la guerra: il favorevole vaticinio del Dio e la sua promessa d'appoggio. Tutta la Grecia si prepara allo sforzo comune: alcuni paesi per timore altri sperando un guadagno. Non sarete voi a violare i patti per primi: il Dio stesso, con il suo monito a battervi fa intendere che li considera oltraggiati. Voi piuttosto accorrete a tutela di quei patti offesi. Il trattato è sciolto non da chi si difende, ma chi aggredisce per primo.
124. "Da ogni lato la guerra si presenta per voi sotto felici prospettive. Vi esortiamo quindi a dichiararla, con il pensiero ai comuni vantaggi: poiché è dimostrato che l'identità di interessi è la diretti va politica più sicura per gli stati e gli individui. Non ritardate l'aiuto a Potidea: è una città dorica assediata da Ioni. Accadeva il contrario nei tempi andati. Restituite l'indipendenza agli altri Greci. Non è più possibile temporeggiare: alcuni di noi già soffrono il giogo, altri non aspetteranno a lungo una sorte altrettanto indecorosa. Giacché si saprà che ci siamo adunati, ma non abbiamo l'ardire di organizzare una difesa. Pensate che la necessità incombe, alleati; riflettete: questo è il più proficuo consiglio, votate la guerra, senza pensare al rischio immediato, ma aspirando alla pace più certa e duratura che ne deriverà. Dalla guerra sorge una pace più ferma. Ma il non voler passare dalla pace alla guerra non è altrettanto privo di pericoli. Sia questo il vostro pensiero: la città che ha imposto la sua tirannide in Grecia, minaccia egualmente l'indipendenza di tutti. Su alcuni già domina, altri progetta d'asservire. Attacchiamo questa città e soggioghiamola: non solo la nostra esistenza futura scorrerà senza pericoli, ma anche renderemo liberi i Greci già servi." Con queste parole si concluse l'intervento dei Corinzi.
125. Gli Spartani completarono così l'ascolto di tutte le opinioni, e fecero votare per ordine tutti gli alleati presenti, gli stati maggiori e i minori: la maggioranza decise la guerra. Non era possibile tuttavia tradurre immediatamente in pratica la deliberazione: non erano preparati a sufficienza, perciò decisero che ogni singolo paese contribuisse alla fornitura di quanto era necessario, senza perdite di tempo. Impiegarono poco meno di un anno ad allestire i preparativi indispensabili: seguì l'invasione dell'Attica e l'inizio aperto delle ostilità. Intanto, in quell'anno, giungevano frequenti le loro ambascerie in Atene, in genere con lagnanze e critiche da notificare, con lo scopo, qualora Atene non le considerasse degne, di sferrare l'attacco con un insieme di motivazioni più nutrito e solido.
126. La prima missione spartana intimò agli Ateniesi di espellere, in espiazione, gli autori del sacrilegio contro la Dea. Il sacrilegio di cui parlavano era stato così commesso. Cilone era un cittadino ateniese, vincitore di un'Olimpiade, nobile per discendenza antica e politicamente influente. Aveva preso in moglie la figlia di Teagene, un Megarese che in quegli anni reggeva la tirannia su Megara. Un giorno, Cilone interpellò l'oracolo di Apollo a Delfi: il dio profetò che nella più fausta festività di Zeus Cilone avrebbe occupato l'acropoli d'Atene. Cilone si fece consegnare da Teagene un nerbo d'armati e persuase alcuni amici a seguirlo. Quando giunse il tempo delle feste Olimpiche, che si celebrano nel Peloponneso, occupò l'acropoli con un colpo di mano, intenzionato a stabilirvi la tirannide. Aveva interpretato quella come la solennità più importante dedicata a Zeus e vi aveva perfino intravisto una certa relazione con la sua persona, perché aveva conseguito una vittoria proprio ad Olimpia. Se però la festa in questione dovesse essere la più importante di quelle celebrate in Attica, o in qualche altra parte di Grecia, Cilone non se l'era chiesto; nemmeno dal testo del vaticinio traspariva chiaro (ad esempio in Atene esistono le feste cosiddette Dionisie, le più solenni in onore di Zeus Meilichio: vengono celebrate fuori le mura e la cittadinanza interviene al completo, porgendo in offerta non vittime di sangue, ma altri prodotti locali). Persuaso d'aver inteso esatto l'oracolo, pose mano all'impresa: al diffondersi della voce gli Ateniesi accorsero in folla dalle campagne, li circondarono sull'acropoli e si disposero all'assedio. L'affare si trascina: la fatica e la noia del lungo blocco ne distoglie quasi tutti i cittadini, che affidano, desistendo, il compito della sorveglianza ai nove arconti con pieni poteri, con la raccomandazione che dispongano tutto il necessario al miglior esito dell'impresa: era ancora il tempo in cui gli arconti espletavano la quasi totalità delle funzioni governative e politiche. L'assedio, e soprattutto la scarsità di cibo e d'acqua intaccavano pesantemente la resistenza di Cilone e dei suoi: finché Cilone e il fratello riescono a fuggire. I loro compagni, prostrati e decimati dagli stenti si trascinano supplici all'altare collocato sull'acropoli. Gli Ateniesi che vigilavano li fecero alzare, come si accorsero che stavano spirando in uno spazio consacrato, e assicurando incolumità assoluta, li trassero fuori e li giustiziarono. Giunsero ad assassinarne per via alcuni, che si erano rifugiati nel santuario delle Venerande Dee e si appigliavano ai loro altari. Queste uccisioni fecero pesare sul capo dei loro esecutori la colpa di sacrilegio e di empietà al cospetto della Dea: anche la loro famiglia condivise la colpa e l'infamia. Di conseguenza, gli Ateniesi stessi espulsero questi sacrileghi e li bandì in seguito anche Cleomene spartano, con l'appoggio d'una fazione ateniese, durante una sommossa civile. I vivi patirono l'esilio; le ossa di quelli morti nel frattempo furono dissepolte e sparse fuori del territorio attico. Ma finirono sempre col ritornare, e la loro discendenza vive ancora in città.
127. La richiesta spartana riguardava proprio l'espiazione di quell'antico sacrilegio: principalmente, diceva Sparta, per difendere la dignità santa degli dei. In realtà sapevano che Pericle, figlio di Santippo, vi era implicato per parte di madre, e prevedevano che da un eventuale bando di quell'uomo la loro politica verso Atene avrebbe avuto il corso immensamente più agevole e libero. D'altra parte non potevano certo sperare che fosse scacciato: ma un desiderio segreto li possedeva, di poterlo almeno mettere in pessima luce di fronte al pubblico credito dei suoi concittadini, istillando loro la sensazione che la guerra, in parte, sarebbe scoppiata a causa del suo stato morale d'impuro. La vita politica d'Atene aveva in quel tempo in Pericle il suo uomo di punta, il prestigioso e geniale ispiratore d'una linea d'assoluta avversione e intransigenza nei confronti di Sparta, l'esecutore di una continua pressione psicologica degli Ateniesi alla guerra.
128. In risposta, gli Ateniesi intimarono analogamente a Sparta l'espiazione del sacrilegio perpetrato nel Tenaro. Si trattava di questo: gli Spartani tempo prima, avevano invitati i supplici Iloti a togliersi dal santuario di Posidone sul Tenaro dove avevano trovato scampo. Li massacrarono sul posto appena usciti. Sono ancora convinti che il potente sisma che ha scosso Sparta sia stata la conseguenza di quel gesto nefando. Anche i responsabili del sacrilegio contro Atena Calcieca dovevano essere espulsi, secondo Atene. Ecco il fatto: Pausania, quello spartano che i concittadini avevano richiamato dall'Ellesponto, revocandogli il comando in capo di quel settore operativo, fu giudicato dai tribunali di Sparta e prosciolto. Ma non ottenne più incarichi di comando ufficiali. Si procurò privatamente una trireme di Ermione e, senza autorizzazione governativa, fece la sua comparsa sull'Ellesponto, nominalmente per appoggiare le forze greche impegnate contro la Persia, in realtà per infittire con il re quella trama di relazioni segrete che aveva già ordito all'epoca del suo comando, e tramite la quale sperava con ardore in un personale dominio sull'intera Grecia. Aveva colto l'occasione di porgere un servizio al re, principio e base di un rapporto che si sarebbe in seguito sviluppato, nella seguente circostanza. Ripiegando da Cipro, nel periodo in cui comandava le forze in Ellesponto, aveva preso Bisanzio (un possesso persiano, in cui vennero catturati alcuni parenti e famigliari del re che vi dimoravano). Concepì allora il piano di restituire queste personalità al re, senza rivelarlo agli alleati: ufficialmente si sarebbe trattato di un tentativo di fuga riuscito. Allacciò contatti tramite Gongilo di Eretria, cui affidò la città di Bisanzio e i prigionieri. Aggiunse una lettera che Gongilo avrebbe recapitato al re. Vi stavano scritte queste parole, come si appurò in seguito: "Pausania, generale di Sparta, desiderando farti cosa gradita, ti rimanda costoro, presi con la forza e le armi. Ho in animo, se la proposta è anche a te gradita, di prendere tua figlia in moglie e consegnarti in soggezione Sparta e il resto della Grecia. Mi stimo adatto e pronto all'impresa, che dirigerò secondo i tuoi consigli. Se la prospettiva sollecita il tuo interesse, manda alla costa del mare un uomo fidato, che fungerà da intermediario per la nostra corrispondenza futura."
129. Era questo il contenuto della lettera, di cui Serse si compiacque molto. Dispone subito infatti l'invio di Artabazo, figlio di Farnace, verso la costa con l'ordine di prelevare la satrapia Dascilitide, da cui aveva rimosso il precedente governatore Megabate. Ordina ad Artabazzo di raggiungere Pausania a Bisanzio e di consegnargli una missiva di risposta, al più presto, mostrandogli il sigillo reale. Se Pausania gli avesse affidato qualche incarico o mansione pertinenti gli interessi del Re, li eseguisse al meglio e con la più scrupolosa discrezione. Artabazo eseguì gli ordini con accuratezza e trasmise la lettera. Vi era stilata la seguente risposta: "Così dice Serse il Re a Pausania: per le persone che mi hai inviate incolumi da oltre mare, da Bisanzio, durerà perenne, iscritta nella nostra casa, la gratitudine che ti è dovuta. Approvo le tue proposte. Né la notte né il giorno t'ostacolino nell'esecuzione di quanto mi prometti: nessuna spesa d'oro o d'argento deve bloccarti, o la necessità di un esercito forte, in qualunque luogo debba comparire. Utilizza Artabazo, uomo che t'ho inviato; è di grandi capacità. Coltiva i tuoi e i miei interessi con la massima energia, in modo che producano a entrambi i più splendidi e preziosi frutti."
130. Pausania era anche prima una figura di prestigioso rilievo tra i Greci, per come aveva diretto e vinto la battaglia di Platea. Ma quelle righe, ricevute dal Re, esaltarono la sua superbia, sicché gli era diventato impossibile vivere da persona normale, secondo il costume tradizionale. Usciva da Bisanzio panneggiato in abiti persiani e in viaggio per la Tracia ammetteva la sola scorta di dorifori persiani ed egizi. Di gusto persiano erano anche le sue vivande a tavola. Non sapeva celare le inclinazioni della sua mente, le sue simpatie: perfino dai suoi atti esteriori, anche da quelli particolari e irrilevanti, traspariva e baluginava quali più orgogliosi disegni architettasse per le sue attività future. Era divenuto inaccessibile: tanto altezzoso e tirannico nel trattar con tutti senza distinzione, che nessuno lo poteva accostare. Per il profondo disgusto nato dalla sua condotta, molti alleati furono lieti di passare agli Ateniesi.
131. La notizia pervenne anche a Sparta, che prese un primo provvedimento d'immediato richiamo. Ma quello con la nave di Ermione prese subito il mare una seconda volta, senza avere ricevuto l'ordine dal governo, e insistette chiaramente con il suo consueto comportamento. Quando le forze ateniesi lo ridussero a fuggire da Bisanzio espugnata invece di rientrare a Sparta, si stabilì a Colono nella Troade. Laggiù, secondo le voci che ne trapelavano a Sparta, intratteneva relazioni poco chiare con la Persia: era evidente che il suo soggiorno era dovuto a scopi politici nient'affatto onesti. Gli efori decisero di far cessare lo scandalo: inviarono un araldo a consegnargli la scitala e a ingiungergli di seguirlo. In caso diverso, Sparta lo dichiarava nemico. Pausania, intendendo dissipare i sospetti addensatisi sulla sua condotta e convinto di poter dissolvere le accuse con offerte di denaro, rimpatriava per la seconda volta. In un primo momento gli efori lo incarcerarono (è lecito agli efori operare un arresto anche del re) ma con l'intrigo ottenne in seguito la libertà, ponendosi a disposizione di chi avesse desiderio di intentargli un processo sulla base di accuse concrete e precise.
132. Ma gli Spartani, sia gli avversari di Pausania sia in generale, la cittadinanza, non potevano contare su indizi sicuri e decisivi: eppure era indispensabile congegnare un'accusa su prove inoppugnabili, per poter punire un personaggio di famiglia reale e che ancora rivestiva la carica di re (era tutore infatti, in qualità di cugino, di Plistarco il vero re, figlio di Leonide, in età ancora minorile). Ma il suo disprezzo della legalità e l'eccessiva simpatia per lo stato straniero costituivano occasioni di pesante sospetto che non volesse contenersi nei limiti dell'ordine vigente. Sottoposero a indagine il precedente corso della sua esistenza, per scoprire se avesse già commesso qualche infrazione al sistema di vita allora in uso. Trovarono che sul tripode, dedicato qualche anno prima dai Greci a Delfi, come primizia del bottino persiano, aveva voluto, di sua personale iniziativa, che fosse inciso il seguente distico: "Annientò l'armata persiana, il capo dei Greci Pausania e a Febo questo consacrò a ricordo". Gli Spartani, fin da quell'epoca avevano già fatto cancellare quel distico dal tripode, e vi avevano inciso il nome delle città che, avendo collaborato alla disgregazione della potenza persiana, avevano dedicato il tripode stesso. Anche a quell'epoca, per il vero, il gesto di Pausania sembrò una palese irregolarità: l'ispirazione di quell'atto, analizzata e interpretata alla luce dei gravi sospetti che si erano andati, consolidando intorno alla sua figura, denunciò subito la sua analogia con l'atteggiamento spirituale mostrato da Pausania in più recenti circostanze. Serpeggiava l'indiscrezione, provata poi pienamente esatta, che organizzasse complotti con gli Iloti: aveva loro promesso libertà e diritti politici, se si fossero sollevati a un suo comando, e se gli avessero prestato l'appoggio necessario. Fu sporta qualche denuncia da parte degli Iloti: anche in questo caso, pur con la sensazione che quelle accuse erano fondate, gli Spartani decisero per il momento di non prendere misure straordinarie contro di lui. Aderivano all'uso, ormai invalso presso di loro, di non lasciarsi trasportare dalla fretta, di non deliberare qualche provvedimento irrimediabile su un personaggio spartiate, senza aver in mano prove effettivamente inconfutabili. Ma da ultimo, come si dice, l'uomo incaricato di consegnare ad Artabazo l'ultima lettera per il re, un tale Argilio, intimo di Pausania e fedelissimo, fa pervenire agli efori la sua denuncia. L'aveva stimolato una paurosa sensazione, nata dal considerare che nessuno dei messi precedenti aveva fatto ritorno. Decide di contraffare il sigillo per cautela, nel caso che la sua diffidente impressione sia vana, o che Pausania gli chieda la lettera per aggiungervi qualche riga. Apre dunque la missiva, e a confermare i sospetti, vi legge, in fondo, un'istruzione supplementare: la propria condanna a morte.
133. La lettera, scritta personalmente da Pausania, rappresentava per gli efori una prova consistente; pure, per averne una definitiva, vollero ascoltare con le proprie orecchie qualche frase pronunciata da Pausania in persona, che lo compromettesse apertamente. A questo scopo, di concerto con gli efori, l'uomo si recò sul Tenaro come supplice, eresse una capanna e con una parete divisoria ne ricavò due ambienti, in uno dei quali fece appostare alcuni degli efori. Udirono chiara ogni parola, in quell'incontro tra Pausania e il suo uomo. Pausania esordì chiedendo il motivo di quella supplica ed ebbe in risposta le rimostranze del suo interlocutore, per quegli ordini contenuti nella lettera, che lo riguardavano. Elencava distintamente ogni altro particolare, facendo notare che nei suoi uffici d'intermediario presso il re non lo aveva mai esposto. Eppure gli si riservava il bel privilegio d'esser messo a morte, come gli altri che lo avevano preceduto in quel compìto. Le frasi di Pausania, che riconosceva in pieno i suoi torti e conveniva su ogni punto, che pregava l'altro di non lasciarsi fuorviare dall'irritazione di quel momento, giunsero alle orecchie degli uditori. Come le sue assicurazioni di incolumità, se quello usciva dal santuario, e l'istanza di mettersi quanto prima in viaggio, senza pregiudicare le trattative in corso.
134. L'ascolto diretto degli efori questa volta fugò ogni dubbio: ormai incrollabilmente certi della sua colpa, predisposero la cattura di Pausania in città. Si dice che un attimo prima dell'arresto per via, Pausania intuisse dall'espressione dipinta sul viso di uno degli efori, mentre gli si accostava, lo scopo di quell'incontro. Un altro eforo gli avrebbe fatto un cenno impercettibile con il capo, per fargli intendere le loro intenzioni, spinto da un senso d'amicizia. Pausania comunque scattò di corsa verso il santuario di Atena Calcieca e riuscì a rifugiarvisi in tempo: poiché il recinto sacro era vicino. Sorgeva adiacente un edificio non ampio, in cui si precipitò, per avere almeno un riparo alle intemperie. Non si mosse più. Gli inseguitori non lo raggiunsero subito: fecero smantellare il tetto della costruzione e certi che si trovasse all'interno, ve lo rinchiusero murando le porte. Circondarono l'edificio e aspettarono di prenderlo per fame. Quando si accorsero che così incarcerato in quella stanza, era vicino a spirare lo trascinano all'esterno del recinto sacro. Respira ancora ma cade subito morto, appena fuori il santuario. Avevano già stabilito di precipitarlo nel Ceada, come usava con i malfattori: prevale però l'idea di dargli sepoltura più vicino. Ma il Dio, attraverso l'oracolo di Delfi, intimò agli Spartani di traslarne la salma nel punto stesso della morte (ancor oggi riposa infatti all'ingresso del santuario, come provano le iscrizioni di alcune stele). Ingiunse anche di espiare l'atto commesso, un sacrilegio grave, dedicando ad Atena Calcieca due corpi in cambio di uno solo. Furono così fatte erigere e consacrare alla dea due statue di bronzo, quasi a compenso di Pausania.
135. Gli Ateniesi, rilevando che anche il dio aveva giudicato il loro gesto un sacrilegio, imposero a loro volta a Sparta di espellerne i responsabili con le loro famiglie. Ambasciatori spartani giunti appositamente ad Atene, implicarono anche Temistocle nell'accusa di complotto con la Persia che aveva perduto Pausania. Risultava dall'analisi dei capi d'accusa raccolti contro Pausania: onde la loro ferma richiesta che Temistocle fosse egualmente punito. Gli Ateniesi si lasciarono persuadere (poiché egli aveva già subito l'ostracismo e abitava ad Argo in quel tempo, quando non si recava, di tanto in tanto, in altre località del Peloponneso). Mobilitarono un gruppo d'uomini, cui si diede istruzione di scovarlo, in qualunque luogo si trovasse, e ricondurlo ad Atene, con l'aiuto dei messi spartani che si dichiararono disposti a collaborare nella ricerca.
136. Una voce preavverte in tempo Temistocle, che lascia in tutta fretta il Peloponneso per passare a Corcira, contando sul debito di riconoscenza che aveva contratto con quel paese. Ma i Corciresi gli confessano che temono forte le rappresaglie spartane e ateniesi, se gli danno ricovero. Abbandona anche quel rifugio e si fa sbarcare sulla terra che si estende davanti a Corcira. L'incalzare sistematico degli inseguitori, informati via via di ogni spostamento, lo costringe, in una circostanza di particolare smarrimento a fermarsi presso Admeto, re dei Molossi, che gli è ostile. Costui però, temporaneamente, si trova fuori casa. Rivolge allora la sua richiesta d'ospitalità alla moglie del re: ne riceve il consiglio di prendere in braccio il loro figlioletto e di assidersi supplice presso il focolare. Ad Admeto, che non tarda molto a rientrare, Temistocle rivela la sua identità e l'implora, anche se ha avversato ad Atene le richieste che un tempo il re vi aveva avanzato, di non vendicarsi ora su di lui, profugo e inseguito. In quelle condizioni, anche un uomo assai meno potente di Admeto avrebbe agio di rovinarlo: è proprio invece di uno spirito generoso cercare la vendetta quando gli avversari sono in una situazione di parità. Inoltre gli s'era opposto in questioni concernenti interessi particolari, non la salvezza stessa della vita; Admeto invece, se lo avesse consegnato (svelò chi e con quale scopo lo perseguitava) lo avrebbe privato dell'esistenza.
137. A queste parole, il re lo fa levare, mentre ancora tiene in braccio il figlioletto, nell'atteggiamento stesso con cui se ne stava prima seduto e che rappresenta il più solenne modo d'implorare protezione. Quando si presentano, solleciti, Ateniesi e Spartani, Admeto non ha riguardo per le loro insistenti proteste e non consegna l'ospite. Soddisfa anzi il suo desiderio di raggiungere il re, facendolo scortare per via di terra fino all'opposto mare alla corte di Alessandro a Pidna. Trova qui una nave da carico, in procinto di salpare per la Ionia, e vi s'imbarca. Ma un fortunale li trascina proprio davanti a un campo di Ateniesi intenti all'assedio di Nasso. Temistocle si lascia prendere dal panico e rivela al comandante della nave (a bordo infatti la sua identità era ignota) chi sia in realtà e le ragioni della sua fuga. Se non lo condurrà in salvo, minaccia che sosterrà la tesi d'averlo corrotto e comprato con il denaro il passaggio sulla sua nave. Il provvedimento più sicuro è che nessuno scenda a terra, mentre non si può riprendere la navigazione. Se si mostra d'accordo, la sua gratitudine sarà adeguata e sostanziosa. Il comandante accetta le condizioni di Temistocle e dopo aver tenuto ormeggiata la nave un giorno e una notte al largo del campo ateniese, salpa per Efeso. Temistocle gli compensa il favore con l'oro (gli erano state fatte pervenire da Atene e da Argo, per opera di amici, tutte le sue sostanze), e direttosi all'interno, accompagnato da un Persiano della costa, manda una lettera al re Artaserse figlio di Serse, asceso da poco alla dignità del trono. Era questo il tenore di quella missiva: "Giungo ora presso di te, io che tra i Greci sono il principale autore delle disfatte più rovinose che si sono abbattute sulla tua famiglia: nel tempo in cui mi vidi obbligato a contenere l'aggressione del padre tuo. Ma più importanti risultano i miei meriti, dal momento che la sua ritirata avvenne in condizioni per me di sicurezza assoluta, per lui di estremo pericolo. Mi è dovuta quindi riconoscenza (seguiva nella lettera l'accenno al consiglio dato al padre, subito dopo Salamina, di ritirarsi subito, e il divieto, che Temistocle falsamente si attribuiva, di, tagliare i ponti in quell'occasione) ma, anche ora mi presento fornito di cospicue possibilità di esserti utile, inseguito dai Greci a causa dell'amicizia che nutro per te. Desidero soggiornare nel tuo paese per un anno, prima di comparire al tuo cospetto per svelarti il mio disegno".
138. Il re, secondo le voci che circolano, ammirò il suo piano e lo esortò a porlo in pratica. Temistocle impiegò il tempo del suo soggiorno a impratichirsi della lingua persiana e dei costumi di quel popolo, quanto poté. Al termine stabilito di un anno si presentò al re e conquistò presso di lui un'influenza superiore a quella di qualunque altro greco, parte per la stima di cui godeva anche precedentemente, parte per la speranza suscitata nel re di offrirgli soggetta la Grecia, ma principalmente per le molte occasioni in cui aveva fatto rifulgere la propria intelligenza. Era meritevole infatti Temistocle della più ammirata meraviglia, particolarmente per la straordinaria sicurezza con cui aveva imposto in molte occasioni il suo temperamento geniale. Doveva all'agilità innata del suo intelletto, libera da ogni preparazione di studio o riflessione scaturita dall'esperienza, la perspicacia potente con cui, dopo un fulmineo esame interpretava frangenti improvvisi e l'infallibile sagacia per cui ne individuava, nel futuro, anche le conseguenze più remote. Sapeva con precisione e chiarezza esplicare ogni aspetto delle azioni cui prendeva parte personalmente: su quelle di cui non possedeva diretta esperienza, era ben lontano dal non poter formulare un giudizio criticamente valido. Eccelleva nel presagire con notevole anticipo le proficue o negative conseguenze di un fatto, quando si celavano ancora per chiunque altro indistinte. Per concludere, in una parola, quest'uomo dal genio possente, dalla concentrazione istantanea fu ineguagliato nell'improvvisare in brevi attimi la soluzione per qualunque ostacolo. Morì di malattia: alcuni soggiungono che si sia dato la morte con il veleno, vedendosi nell'impossibilità di compiere le promesse formulate al re. Rimane di lui un monumento funebre nella piazza di Magnesia d'Asia. Era governatore di questa regione. Il re gli aveva donato Magnesia come "pane" (gli fruttava infatti cinquanta talenti l'anno), Lampsaco come "vino" (le sue campagne infatti godevano fama d'esser le più fertili di viti), Miunte come "companatico". Dicono i suoi parenti che le ossa furono traslate in patria, come aveva desiderato e che siano sepolte in Attica, di nascosto da Atene: sepoltura illegale, poiché egli era esule imputato di tradimento. Furono questi i casi estremi di Pausania spartano e di Temistocle ateniese, gli uomini di più fulgido prestigio, tra quelli della loro epoca, in Grecia.
139. Gli Spartani dunque, nella prima ambasceria diedero e ricevettero queste istruzioni relative alla cacciata dei sacrileghi. Poi con una serie di richieste, ingiungevano ad Atene di levare l'assedio a Potidea e restituire l'indipendenza ad Egina. Ma insistevano, nelle loro relazioni, a chiarire un punto: la guerra non sarebbe stata dichiarata se avessero abrogato la disposizione presa ai danni di Megara, vale a dire il divieto di usufruire dei porti del dominio ateniese e d'intrattenere scambi commerciali con l'Attica. Gli Ateniesi come non prestavano ascolto alle altre richieste, così non cancellavano quel decreto: accusavano anzi i Megaresi di coltivare il suolo sacro, dove i confini non erano determinati, e di offrire ricetto ai loro schiavi ribelli. Infine, giunse da Sparta un'altra ambasceria composta da Ramfia, Melesippo, Agesandro, i quali non si soffermarono sui temi consueti ma espressero solo queste parole: "Gli Spartani hanno volontà di pace; la pace può affermarsi a condizione che voi lasciate ai Greci l'indipendenza". Gli Ateniesi convocarono l'assemblea, e aprirono il dibattito decisi ad esprimere, dopo responsabile e completa riflessione, una risposta definitiva. Si presentarono numerosi oratori a sostenere opposte ragioni. Dichiaravano gli uni che la guerra era inevitabile, gli altri che il decreto su Megara non doveva costituire un ostacolo alla pace, e ne caldeggiavano l'abrogazione. Comparve a parlare anche Pericle, figlio di Santippo, il primo ateniese di quel tempo, valentissimo nella parola e nella pratica politica, e consigliò in questo senso:
140. "La mia convinzione, Ateniesi, rimane sempre invariata: non cedere di un palmo ai Peloponnesi. Eppure sono consapevole che gli uomini stentano a profondere nella realizzazione pratica della guerra quello stesso ardore che li ispira al dichiararla, poiché adattano i loro sentimenti al variare delle contingenze. Vedo che anche nella attuale occasione è mio dovere impartirvi consigli sostanzialmente identici e pretendo che quanti di voi condividono il mio sentire appoggino in futuro la deliberazione qui presa in comune anche se dovessimo incappare in qualche disfatta o in caso contrario, nell'eventualità cioè di un successo, non usurpino il vanto della sagacia politica. Poiché si può tranquillamente ammettere che il corso degli avvenimenti pieghi con scarti non meno imprevedibili che le intenzioni umane: perciò è nostra abitudine imputare alla fortuna quanto sfugge al controllo delle nostre facoltà logiche. La politica di Sparta ci è sempre stata nettamente ostile: ora più di prima. Il trattato contempla due punti qualificanti: le singole città si accordano sull'arbitrato, come strumento per dirimere le reciproche vertenze; entrambe le parti mantengono i territori attualmente in loro possesso. Ora, a dispetto della nostra offerta, Sparta non accetta l'arbitrato e preferisce cercare nella guerra una soluzione alle controversie, scartando il dibattito. Hanno perfino sostituito le loro consuete lagnanze con dei comandi. Tre ordini per la precisione: levare l'assedio da Potidea, concedere l'autonomia ad Egina, cancellare il decreto su Megara. Con quest'ultima missione ci ingiungono di lasciare l'indipendenza agli altri Greci. Fra voi nessuno pensi che si scenda in guerra per una motivazione futile, nel caso si decida di non abrogare la disposizione su Megara. Insistono continuamente proprio con questo tema: l'abrogazione scongiurerebbe la guerra. Badate a non lasciar sorgere in futuro ed attecchire nel vostro intimo un senso di colpa, come se aveste preso le armi per una causa di lieve importanza. Questo movente così futile impegna in realtà la vostra coerenza politica ad ogni livello, costituendone una prova sicura e definitiva. Cedete, anche di poco, a Sparta: si abbatterà su di voi, senza dubbio, un'imposizione più gravosa, perché si convinceranno laggiù che siete scesi a trattare piegati dalla paura; con un atto di fermezza, avrete posto decisamente in chiaro che con voi i rapporti si istituiscono da pari a pari.
141. "Deliberate subito: o accondiscendere, prima di subire qualche colpo, o prendere le armi. Risoluzione che a me pare la più proficua, senza cedere per nessun motivo, grave o futile che sia, e dominando, sciolti da ogni timore, i territori che ora occupiamo. Una rivendicazione di diritto, su qualsiasi oggetto, gravissimo o irrilevante, che sia imposta da un paese fornito di pari potenza e facoltà a un proprio vicino, eludendo la procedura regolare, provoca sempre, inevitabilmente, un medesimo stato d'asservimento. In materia di preparazione militare e di mezzi difensivi a disposizione delle due potenze in causa, state certi, seguendo punto per punto il mio ragionamento, che non ci troveremo inferiori. I Peloponnesi fanno i campagnoli: non possono contare su risorse finanziarie private o pubbliche. Non hanno esperienza di conflitti lunghi o sostenuti al di là del mare. Sono troppo poveri per resistere ad altro che a guerricciole di confine, subito sedate. Simile gente come può essere in grado di armare e equipaggiare navi? Nemmeno campagne terrestri, a breve intervallo di tempo l'una dall'altra, si possono permettere. I contadini non disertano facilmente il loro podere e tanto meno son disposti a pagar le armi di tasca propria. Aggiungete che si vedranno precluse le vie del mare. Le riserve di denaro sono il più fermo sostegno della guerra, non le contribuzioni coatte. Le masse contadine espongono più volentieri la vita in guerra, che il loro denaro: convinti di poter anche scampar vivi dallemischie, ma per niente sicuri che i loro risparmi non sfumino del tutto prima della pace, specialmente se la guerra si trascina, come per il solito, oltre ogni previsione. In un singolo scontro, Peloponnesi e alleati fronteggerebbero gli altri Greci in blocco: ma non dispongono dei mezzi per condurre una vera guerra, contro un nemico che disciplina la sua potenza bellica con metodi radicalmente diversi. Poiché non sono diretti da una decisione e un comando unitari; di conseguenza, difetta loro la rapidità di esecuzione. Inoltre dispongono tutti di parità nel voto, ma appartengono a stirpi diverse, con interessi quindi divergenti, che ognuno caldeggia: condizione in cui generalmente non si conclude mai nulla. Questi premono, per punire un loro privato nemico; quelli recalcitrano, per non patir danni in casa propria. Nelle loro rare assemblee sbrigano in fretta gli affari comuni; la maggior parte del tempo se ne va nel discutere questioni particolari. Ciascun membro del patto non si rende conto del danno che produce con la sua indifferenza: è convinto che qualche altro provvederà in vece sua. Questo rovinoso pregiudizio, generalmente diffuso, non consente loro di accorgersi che l'interesse comune della coalizione langue e decade.
142. "Sarà per lo più la scarsità di capitali a bloccarli, quando perderanno tempo per procurarseli: in guerra invece, le occasioni opportune non consentono indugi. Le loro piazzeforti erette entro i nostri confini e la forza sul mare non preoccupano: quanto alle prime, sarebbe già impresa ardua in tempo di pace armare una città in modo che ci resista, immaginate dunque in terra nemica, tenuto anche conto del fatto che noi disponiamo di fortezze non meno potenti piazzate nel loro territorio. Potranno dislocare una guarnigione: guasterebbero una parte delle nostre campagne, con razzie e incentivi alla diserzione, ma non basterà a impedirci di gettare teste di ponte fortificate sulle loro coste, e di devastarle per rappresaglia con la flotta, la nostra arma più micidiale. Dalla pratica del mare abbiamo accumulato più esperienza noi di guerra terrestre, che loro di tattica navale dai combattimenti di terra. Non sarà facile per loro dominare anche l'arte di battersi con le navi. Perfino voi, che vi allenate ad essa dal tempo delle lotte persiane, non la possedete ancora perfettamente. Come potrebbero distinguersi, in quest'arte difficile, uomini dei campi, non di mare, cui neppure è concesso di esercitarvisi con metodo, sistematicamente bloccati dalle vostre navi numerose? Contro una flotta esigua potrebbero anche arrischiare una offensiva, supplendo alla carenza tecnica con la spavalderia ispirata dalla superiorità di numero; ma contro una squadra potente che li costringa a restare ancorati, dovranno restare inoperosi e la mancanza d'esercizio li ridurrà ancor più maldestri e, di conseguenza, meno pronti ad osare. La marineria è un'arte, più di qualunque altra: non ammette d'esser coltivata per passatempo, quando capita. Esclude piuttosto ogni diversa pratica, che le si voglia svolgere a fianco.
143. "Se poi attingono ai tesori di Olimpia e di Delfi nel tentativo di sottrarci le ciurme forestiere, attratte da paghe più consistenti, sarebbe grave che non riuscissimo a contrastarli con successo imbarcandoci noi stessi, con il rinforzo dei meteci, sulle navi da guerra. In realtà un'operazione di questo tipo è alla nostra portata e, elemento ancor più decisivo, disponiamo, tra i nostri concittadini, di piloti e altri membri d'equipaggio più numerosi e preparati che tutto il resto della Grecia. Quando il pericolo sarà imminente, nessuno dei nostri mercenari sceglierà di sua spontanea volontà il rischio di vivere esule dalla propria terra, per schierarsi (sorretto da una speranza di vittoria senza dubbio più fievole) a fianco del nemico con il miraggio di pochi giorni di paga più lauta. Mi pare questa, in sostanza, la situazione del Peloponneso. La nostra invece, immune dalle deficienze che ho additato in quelli, può contare su altri e superiori punti.di vantaggio. Se invadono l'Attica con le forze di terra, salperemo contro il loro paese. Risulterà allora ben differente il peso strategico delle nostre azioni, che devasteranno una parte del Peloponneso, e le loro contro l'Attica intera. Poiché il nemico non potrà pacificamente annettersi altro territorio in compenso. Il nostro dominio è sconfinato: si estende sulle isole e sul continente: l'egemonia sul mare è vantaggio incalcolabile. Riflettete infatti: se fossimo isolani, quale popolo sarebbe più invincibile? E anche ora è indispensabile che la nostra condotta di guerra si uniformi il più possibile a questo assunto: abbandoniamo le campagne e le loro case, puntiamo alla difesa della città e al dominio sul mare. Il dolore per la desolazione dei campi non ci induca ad accettare lo scontro aperto con le truppe dei Peloponnesi, più agguerrite. (In caso di vittoria lotteremmo sempre contro un nemico non meno numeroso e una disfatta causerebbe l'abbandono da parte degli alleati, che sono la nostra forza: non si asterranno dalla rivolta, se non potremo marciare contro di loro). Non dovremo aver rimpianto per la rovina della terra e delle case, ma delle vite umane: quei beni non danno vita agli uomini, ma sono gli uomini che creano quei beni. Se ritenessi di potervi convincere, v'ordinerei d'uscir voi stessi a distruggere raccolti e case, per dimostrare al nemico che non vi piegherete mai, per salvare quei possessi.
144. "Sono in grado di sostenere la speranza della futura vittoria con molti altri argomenti; a patto che siate disposti a non ampliare il vostro dominio, mentre siete in lotta, e a non affrontare rischi superflui. Mi incute più preoccupazione la possibilità di un nostro passo falso, che l'accortezza strategica del nemico. Ma rimando la spiegazione di questi punti a un altro discorso, quando saremo in piena guerra. Licenziamo ora gli ambasciatori con questa risposta: riapriremo a Megara il mercato e i porti, a patto che anche Sparta non applichi più né ai danni nostri né degli alleati, le norme di legge relative al bando degli stranieri. Poiché nessuno articolo del trattato impedisce espressamente questo o quello. Concederemo l'indipendenza alle città della lega che la possedevano già quando fu stipulato il trattato, ma solo nel caso che anche gli Spartani rendano alle loro genti la facoltà di governarsi con costituzioni politiche che rispecchino le loro libere scelte non che si modellino sulle loro pressioni e a vantaggio di Sparta. Secondo le clausole del trattato, siamo disposti ad affrontare un arbitrato. Non attaccheremo, ma, attaccati, respingeremo il nemico. Questa è l'unica risposta corretta e dignitosa che la città di Atene intende fornire. Bisogna rendersi conto che la lotta è inevitabile. Tanto più veemente sarà il nostro slancio all'inizio tanto meno fieri avversari avremo contro. Dai rischi più gravi rifulge alla città e all'individuo l'onore più splendido. I nostri padri contrastarono i Persiani fino alla vittoria finale: eppure non disponevano di così imponenti risorse. Anzi, si videro obbligati ad abbandonare le loro esigue fortune: ma respinsero lo straniero, fidando più nell'intelligenza che nel caso, nell'indomabile coraggio che nel vigore delle armi E hanno elevato la potenza d'Atene a tali vette! Non dobbiamo mostrarci inferiori, ma respingere l'attacco nemico con ogni forza e cercare di lasciare ai nostri figli l'eredità di un dominio e d'un prestigio intatti."
145. Fu questa la sostanza del discorso di Pericle. Gli Ateniesi, persuasi che le sue direttive fossero le più brillanti per la contingenza politica che attraversavano, le ratificarono con il loro voto. Aderirono al Suo consiglio, modellando la risposta ufficiale agli Spartani sullo spirito complessivo del suo intervento e sulle singole considerazioni che aveva espresse e giustificate. Che cioè non avrebbero dato corso a nessuna delle intimazioni spartane e che erano invece pronti a cercare un accordo secondo il senso dei trattati, su una base di assoluta parità riguardo alle accuse che gravavano su di loro. L'ambasceria fece ritorno in patria: da quel momento non comparvero più in Atene ambasciatori di Sparta.
146. Furono questi i motivi di recriminazione e dissenso che vennero alla luce nei rapporti tra le due potenze, prima che si instaurasse lo stato di guerra. La tensione che lo precedette era la conseguenza diretta dei fatti di Epidamno e di Corcira. Le relazioni, però, non si interruppero del tutto in questo periodo: i rapporti erano anzi frequenti e non si ricorreva alla funzione mediatrice degli araldi. Ma la diffidenza tra loro era acuta: poiché quegli eventi significavano l'infrazione dei patti e fornivano motivo per lo scoppio di una guerra.
1. Tucidide d'Atene descrisse la guerra tra Peloponnesi e Ateniesi, come combatterono fra loro. Mise subito mano alla stesura dell'opera, dallo scoppio della guerra, che prevedeva sarebbe stata grave, anzi la più degna di memoria tra le precedenti. Lo deduceva dal fatto che i due popoli vi si apprestavano all'epoca della loro massima potenza e con una preparazione completa osservava inoltre il resto delle genti greche schierarsi con gli uni o con gli altri, chi immediatamente, chi invece meditando di farlo. Fu senza dubbio questo l'evento che sconvolse più a fondo la Grecia e alcuni paesi barbari: si potrebbe dire addirittura che i suoi effetti si estesero alla maggior parte degli uomini. Infatti, sugli avvenimenti che precedettero il conflitto e su quelli ancor più remoti era impossibile raccogliere notizie sicure e chiare, per il troppo distacco di tempo; ma sulla base dei documenti, cui l'indagine più approfondita mi consente di prestar fede, ritengo che non se ne siano verificati di considerevoli, né sotto il profilo militare, né per altri rispetti.
2. E risulta infatti evidente che la terra chiamata ai nostri giorni Grecia non era in tempi antichi abitata stabilmente, ma in principio vi si succedevano migrazioni e le singole genti, premute da popoli di volta in volta più numerosi, abbandonavano con facilità le loro sedi. Non vi era commercio; né esistevano relazioni reciproche sicure per terra o attraverso il mare. Ciascuno lavorava il proprio podere quant'era necessario a ricavarne il vitto: senz'accumulo di capitale e senza coltivare piantagioni, nel dubbio che una volta o l'altra qualche nuovo venuto li depredasse con improvvisa aggressione, poiché, tra l'altro, non si fortificavano con mura. Inoltre, convinti di poter ottenere dovunque il cibo di volta in volta sufficiente per un giorno, mutavano residenza senza difficoltà. Perciò non possedevano la potenza costituita dalle città grandi e dagli altri dispositivi militari. In particolare erano i territori migliori di questo paese a subire l'avvicendarsi continuo degli abitanti: la regione che ora ha nome Tessaglia, la Beozia e gran parte del Peloponneso, tranne l'Arcadia; del resto, quelle terre che erano più fertili. Infatti, l'accrescersi in alcune genti della loro potenza, in virtù del suolo eccellente, era motivo al loro interno di discordie che ne causavano naturalmente la rovina. Al tempo stesso, erano esposti agli attacchi anche più insidiosi delle popolazioni straniere. L'Attica, ad esempio, per la povertà del suolo fu abitata per lunghissimo tempo sempre dal medesimo popolo. Ed ecco la prova più determinante a sostegno del mio ragionamento, che proprio per le migrazioni le altre genti greche non sono pervenute a un pari progresso: dai diversi luoghi della Grecia, esuli per un conflitto o per una sedizione intestina, gli uomini più ragguardevoli ricorrevano agli Ateniesi, certi di godervi un saldo rifugio. Fatti membri della città, fino dagli antichi tempi contribuirono a renderla via via maggiore per numero d'uomini: cosicché in seguito, non bastando più il territorio dell'Attica, Atene mandò fino nella Ionia le sue colonie.
3. A parer mio, dimostra la debolezza degli antichi stati anche la considerazione seguente, certissima: prima dei fatti di Troia, è evidente che la Grecia non ha saputo mai riunire le proprie forze e dirigerle a un'impresa comune. Mi pare anzi che neppure tutta possedesse ancora il nome attuale e che nell'epoca precedente ad Elleno, figlio di Deucalione, tale appellativo non esistesse nemmeno. Furono invece singole genti, sembra, e soprattutto i Pelasgi a fornire di volta in volta il proprio nome a tratti sempre più ampi del paese. Quando crebbe nella regione di Ftia la potenza d'Elleno e dei suoi, accadeva di frequente che gli altri stati li chiamassero, bisognosi d'aiuto. Fu allora che in ognuno di questi paesi, per effetto di tali relazioni, a mio vedere, si diffuse progressivamente il nome di Elleni; ma non poté affermarsi né a lungo né sul complesso delle stirpi greche. Lo testimonia manifestamente Omero: infatti, vissuto molto più tardi della guerra di Troia, non accomunò mai, in nessun punto della sua opera, tutti gli Elleni sotto questo nome, né lo conferì ad altri, eccettuati quelli che provennero dalla Ftiotide al seguito di Achille e che invero erano gli Elleni originari. Nei suoi versi nomina i Danai gli Argivi e gli Achei. In effetti non ha mai neppure espresso il nome di barbari in quanto, a mio
4. Minosse fu il più antico, tra quanti conosciamo per tradizione orale, a procurarsi una flotta e a dominare la parte più estesa del mare detto attualmente greco. Resse le isole Cicladi e ne colonizzò per primo il maggior numero, dopo averne espulsi i Cari e avervi preposto come governatori i suoi figli. Naturalmente cercava, per quanto era in suo potere di spazzar via dalle rotte marittime la pirateria per agevolare l'afflusso dei suoi tributi.
5. Infatti i Greci antichi e i barbari, che sul continente vivevano in località costiere, o abitavano le isole, dopo che presero con più stabilità e frequenza a trafficare tra loro per nave tendevano all'esercizio della pirateria. Li capeggiavano le personalità più in vista, per lucro privato e per reperire il cibo necessario agli individui più deboli del loro popolo. Assalivano centri sforniti di mura difensive, costituiti di villaggi sparsi e li mettevano a sacco: le loro risorse vitali provenivano essenzialmente da questa attività, che mentre non aveva ancora in sé nulla di indecoroso, costituiva piuttosto il mezzo per procurarsi una discreta rinomanza. Ne fanno fede alcune popolazioni del continente, che ancora ai nostri tempi si onorano di praticare con successo questa professione e i poeti antichi, che mettono invariabilmente in bocca ai loro eroi, in qualsiasi approdo sbarchino, la domanda: "siete pirati?"; e gli interrogati non suscitano affatto l'impressione di disprezzare un'attività simile, né pare che la giudichino indegna quelli che esigono una risposta. Anche sulla terraferma praticavano un brigantaggio reciproco. E ancora oggi, in molte terre di Grecia, la vita si svolge con queste antiquate consuetudini: nel paese dei Locri Ozoli, ad esempio, degli Etoli e degli Acarnani e nei territori circostanti. In particolare dall'antico uso della pirateria s'è inveterato in questi abitatori del continente il costume d'indossare sempre le armi.
6. Poiché era abitudine un tempo in Grecia che tutti circolassero armati: le abitazioni non fortificate, i reciproci rapporti irti di rischi avevano imposto l'abitudine di passare la vita in armi, al modo dei barbari. Queste terre greche, dove ancora oggi si vive con il sistema antico, sono indizio di costumanze simili in vigore un tempo e generalmente estese. Primi gli Ateniesi deposero l'uso di camminare armati: con modi di vita sciolti dal rigido tenore antico, divennero meno austeri, più delicati. Per questa preziosa raffinatezza, non è molto da che i rappresentanti più anziani delle classi facoltose hanno smesso d'indossare lunghi chitoni in lino e d'intrecciare alla sommità del capo con cicale d'oro il nodo dei capelli. Pertanto anche tra gli Ioni i più vecchi per la loro parentela con gli Ateniesi, mantennero a lungo questa moda. Furono i primi gli Spartani ad adottare un sistema di vestire misurato e semplice, moderno: anche per quanto concerne gli altri aspetti della vita i più abbienti generalmente si mantennero allo stesso livello del popolo. Gli Spartani furono anche i primi a spogliarsi e, mostrandosi nudi in pubblico, a spalmarsi con abbondanza d'olio in occasione degli esercizi ginnici. In antico invece, anche alle Olimpiadi, gli atleti gareggiavano con una cintura sui fianchi, e non è gran tempo che quest'uso si è estinto. Ancora oggi vige presso alcune genti barbare, specie in Asia, la pratica di istituire gare di pugilato e di lotta in cui gli atleti si affrontano muniti di cintura. Si potrebbe provare che anticamente in Grecia si adottava, sotto molti e svariati aspetti, un regime di vita analogo a quello dei barbari del nostro tempo.
7. I centri in cui gli abitanti, ormai molto sicuri nelle comunicazioni marittime, si insediarono più di recente, dotati di più consistenti risorse economiche, venivano fondati per lo più lungo i litorali e fortificati con mura. Si cercava inoltre di occupare gli istmi per praticare agevolmente i propri traffici e contrapporsi di potenza ai rispettivi confinanti. Le città antiche, per contro, timorose della pirateria, fiorita per lungo tempo, si edificavano piuttosto lontano dal mare, sia quelle isolane, che le continentali. (Poiché i pirati compivano incursioni reciproche, rivolgendole anche contro quelli che pur non praticando il mare erano rivieraschi). Ancor oggi questi centri si trovano all'interno.
8. Particolarmente dediti alla pirateria erano gli isolani, vale a dire Cari e Fenici. Costoro possedevano la maggior parte delle isole. Eccone la prova: quando Delo fu sottoposta dagli Ateniesi, nel corso di questa guerra, alla purificazione rituale e furono asportate le tombe di quanti erano deceduti sull'isola, apparve chiaro che per più della metà si trattava di Cari. Si riconobbero dalla fattura delle armi sepolte con i cadaveri e dal sistema di inumazione, in vigore ancor oggi. Affermatasi la forza navale di Minosse, i rapporti per mare si infittirono: i pirati delle isole ne furono espulsi, mentre egli veniva colonizzandone la maggior parte. Gli abitatori delle regioni litoranee, già più decisi ad accrescere i loro capitali, sempre più consolidavano le proprie sedi: alcuni poi, accortisi di diventar via via più facoltosi, si cingevano di mura. Per desiderio di lucro i più deboli si assoggettavano al servizio dei più forti, mentre i più potenti, ricchi a profusione, si annettevano le città minori. Progredivano già da qualche tempo in tale regola di vita quando, più tardi, i Greci si accinsero alla campagna di Troia.
9. A mio vedere, Agamennone riuscì a raccogliere il corpo di spedizione perché eccelleva in potenza tra i contemporanei, non certo sollecitando i pretendenti di Elena con il giuramento che li vincolava a Tindaro. Quelli che hanno accolto, tramandate oralmente dai loro antichi, le notizie più certe sulle vicende del Peloponneso, affermano che Pelope dapprima ottenne una notevole potenza politica, mettendo a frutto le enormi somme di denaro che recò con sé trasferendosi dall'Asia in un paese abitato da uomini indigenti, e riuscì inoltre a imporre, sebbene forestiero il proprio nome su quella terra. In seguito, i suoi discendenti si sarebbero impossessati di una potenza anche più rilevante, quando Euristeo perì in Attica, per mano degli Eraclidi. Euristeo, per il tempo che fosse durata la sua spedizione, aveva affidato ad Atreo, che gli era zio materno e quindi parente, Micene e il regno Atreo si trovava ad esser profugo, temendo il padre a causa dell'assassinio di Crisippo). Sostengono che siccome Euristeo non fece mai più ritorno, Atreo ottenne la successione al regno su volere degli stessi Micenei, in ansia per un'eventuale rappresaglia degli Eraclidi, e poiché s'era creato fama di uomo capace, conquistando le simpatie di quel popolo e degli altri già soggetti ad Euristeo. Così i Pelopidi riuscirono più potenti dei Perseidi. Sono convinto che Agamennone, ricevuto in eredità il regno e più potente sul mare di tutti gli altri, abbia effettuato la spedizione raccogliendone i componenti piuttosto con il severo rispetto che sapeva imporre che in virtù d'una affettuosa benevolenza. È indubitabile infatti che egli partì per Troia con un numero di navi superiore agli altri, e che ne fornì agli Arcadi: lo ha dimostrato Omero, se la sua testimonianza ha valore. Inoltre, narrando la "trasmissione dello scettro" ha lasciato detto che Agamennone su isole molte signoreggiava e su Argo tutta. Senza dubbio, vivendo sul continente, non avrebbe potuto tenere soggette le isole, oltre a quelle prossime alla costa, che non sarebbero molte, se non avesse disposto di una flotta discretamente forte. Anche da questa spedizione si deve dedurre l'entità di quelle che la precedettero.
10. La circostanza che Micene fosse un piccolo nucleo urbano, o se qualche altro centro dei tempi antichi destasse attualmente l'impressione d'essere stato insignificante, non costituirebbe una prova decisiva per chi nutrisse dubbi sull'importanza della spedizione, quale l'hanno magnificata i poeti e la tradizione ancora la celebra. Poiché se la città degli Spartani restasse deserta e rimanessero i templi e le fondamenta degli edifici, penso che dopo molto tempo sorgerebbe nei posteri un'incredulità forte che la potenza spartana fosse adeguata alla sua fama; (eppure occupano i due quinti del Peloponneso, detengono l'egemonia su di esso e su numerosi alleati esterni: tuttavia raccogliendosi la città intorno ad un unico nucleo privo di templi e costruzioni sontuose, con la sua caratteristica struttura in villaggi sparsi, secondo l'antico costume greco, parrebbe una mediocre potenza). Se gli Ateniesi invece subissero la stessa sorte, la loro importanza, a dedurla dai resti visibili della città, si supporrebbe, credo, doppia di quella reale. Non conviene dunque dubitare, né attribuire maggiore rilievo all'esame degli aspetti esteriori delle città che della loro effettiva potenza; ci si deve convincere che quella spedizione fu la più importante tra quante la precedettero, ma inferiore alle attuali, se pure da questo lato dobbiamo prestar fede all'ispirazione poetica di Omero, che da poeta appunto, com'è naturale, l'ha esaltata e abbellita; tuttavia, anche così, è evidente che fu inferiore. Infatti, di milleduecento navi, il poeta ha descritto quelle dei Beoti come fornite di centoventi uomini d'equipaggio ciascuna, quelle al comando di Filottete di cinquanta, volendo indicare, a mio
11. Era causa di ciò non tanto il ristretto numero d'uomini, quanto la scarsità di denaro. In effetti, il problema dei rifornimenti li indusse a mobilitare un contingente di spedizione ridotto: nei limiti di quanti calcolavano che avrebbero ricavato laggiù con l'attività di guerra i mezzi per vivere. Arrivati nella regione di Troia, riuscirono vincitori in un primo scontro (è sicuro, in quanto non avrebbero potuto, in caso diverso, rafforzare con il vallo il loro attendamento): pure è noto che neppur là, nella piana di Troia, abbiano utilizzato al completo i loro effettivi. Urgeva la necessità di vettovaglie, quindi si dettero all'agricoltura nel Chersoneso, e a praticar la pirateria. Onde, per il frazionamento delle forze nemiche, i Troiani resistettero ancor più validamente per quei dieci celebri anni, disponendo sempre di truppe numericamente pari a quelle greche che, di volta in volta, rimanevano ad affrontarli sul campo. Di contro, se i Greci fossero giunti già forniti di riserve alimentari adeguate, quindi in blocco, senza disperdersi chi facendo il predone, chi l'agricoltore, avessero protratto senza interruzione il loro sforzo bellico superiori com'erano negli scontri in campo, avrebbero conquistato la città agevolmente: essi che, senza mai fronteggiarlo compatti, erano sempre in grado di contrastare il nemico con la parte di truppe ch'era di volta in volta presente e che, serrando Troia di continuo assedio, l'avrebbero presa in tempo più breve e con minori fatiche. Al contrario, per esiguità di risorse economiche, non solo risultavano irrilevanti le imprese anteriori, ma queste stesse gesta, le più celebri tra quelle condotte prima, appaiono in realtà impari alla fama che ne nacque e alla memoria che fra noi sopravvive ancora, per il canto dei poeti.
12. E infatti, anche dopo l'impresa troiana, la Grecia andava soggetta a continui movimenti migratori e di colonizzazione, sicché mancante di una pacifica stabilità, non progredì in potenza. Infatti, il ritorno dei principi da Troia avvenuto così tardivo, introdusse molti mutamenti, mentre nelle città soprattutto fiammeggiavano sedizioni e rivolte, con la conseguenza che i profughi ne uscivano fondando nuovi centri di abitazione. In tal modo, gli attuali Beoti, nel sessantesimo anno dalla conquista di Troia, scalzati da Arne per opera dei Tessali si stanziarono nella moderna Beozia, denominata in antico "Paese di Cadmo" (in questa terra, in tempi lontani, viveva già un loro nucleo, e di là avevano mandato un loro reparto a combattere sotto le mura di Troia): analogamente i Dori, nell'ottantesimo anno, occuparono il Peloponneso, guidati dagli Eraclidi. Faticosamente e dopo gran tempo in Grecia si stabilì una situazione di pace sicura, senza interne scosse migratorie: si cominciarono a mandar gruppi di coloni. Gli Ateniesi colonizzarono la Ionia e il maggior numero di isole; quelli del Peloponneso le parti più estese della Sicilia e dell'Italia, insieme ad alcune località della restante Grecia. Queste fondazioni si effettuarono tutte dopo le vicende di Troia.
13. Aumentando in progressione la potenza dei Greci che si impegnavano con sforzo ancor più sollecito di prima ad accumulare le loro rendite, presero piede in numerosi stati, in relazione alla crescita della loro ricchezza, le tirannidi (anteriormente invece vigevano monarchie ereditarie, limitate da certe prerogative): i Greci inoltre armavano flotte ed esercitavano più decisamente la marineria. Corre fama che siano stati i Corinzi a introdurre migliorie tecniche nella fabbricazione delle navi, avvicinandole di molto al livello moderno, e che le prime triremi, in Grecia, uscissero appunto dai cantieri di Corinto. Pare anzi accertato che Aminocle di Corinto, un costruttore navale, abbia fabbricato quattro navi per quelli di Samo. Saranno circa trecento anni alla fine di questa guerra, da che Aminocle giunse a Samo. Il più antico scontro sul mare di cui siamo al corrente è quello tra Corinzi e Corciresi: a computare fino alla medesima data, saranno all'incirca duecentosettanta anni. Dunque i Corinzi con la loro città situata proprio sull'istmo, costituirono sempre, fin da epoche remote, uno scalo commerciale: poiché i Greci antichi all'interno del Peloponneso e quelli esterni trafficavano tra loro per terra più che per mare, percorrendo di necessità il loro istmo; così i Corinzi erano diventati una potenza economica, come mostrano anche gli antichi poeti: attribuirono infatti alla località l'epiteto di "doviziosa". In seguito, quando i Greci incrementarono i negozi marittimi, quelli di Corinto, allestite parecchie navi, si volsero a sterminare i pirati e potendo offrire per mare e per terra un punto di smistamento al traffico commerciale, fecero poderosa l'economia del loro stato con l'afflusso di rendite. Anche gli Ioni dispongono in seguito di una flotta consistente, all'epoca di Ciro, primo sovrano dei Persiani, e del figlio Cambise; in lotta con Ciro dominarono per qualche tempo il tratto di mare che è loro antistante. Pure Policrate, tiranno di Samo al tempo di Cambise, forte di una buona flotta, non solo ridusse in suo potere le altre isole, ma consacrò anche Reneia, dopo la sua conquista, ad Apollo di Delo. I Focesi poi, durante la fondazione della loro colonia Marsiglia, misero in rotta in uno scontro navale i Cartaginesi.
14. Le flotte più poderose erano dunque queste. Risulta però che, per quanto di molte generazioni più recenti rispetto alla guerra di Troia, utilizzassero anch'esse poche triremi e avessero in organico, come quelle arcaiche, essenzialmente scafi a cinquanta remi e navigli lunghi. Poco avanti le guerre persiane e la morte di Dario, che regnò in Persia dopo Cambise, i tiranni di Sicilia, ebbero a disposizione un numero considerevole di triremi, come i Corciresi; e infatti queste furono le ultime flotte degne di ricordo in Grecia, prima dell'assalto di Serse. Gli abitanti di Egina infatti e gli Ateniesi, con altri pochi, erano in possesso di scarse flottiglie, in massima parte composte di navi a cinquanta rematori. Solo più tardi, quando gli Ateniesi erano in guerra contro gli Egineti, Temistocle riuscì a convincerli, anche nel timore che fosse imminente l'aggressione del popolo persiano, ad allestire triremi, con le quali poi effettivamente avrebbero combattuto: ma anche queste erano sfornite di ponti, a proteggere intera la lunghezza dello scafo.
15. Tale si presentava l'entità delle potenze navali greche: le più antiche e quelle sorte in epoche più recenti. Comunque, chi poteva esercitare la marineria, si creò una considerevole potenza, non solo in entrate economiche, ma anche in supremazia sugli altri. Spostandosi con la flotta, sottomettevano a tributo le isole, che costituivano uno sbocco particolarmente ricercato da quelli che non possedevano territorio sufficiente. Conflitti terrestri invece, da cui potesse nascere qualche rispettabile potenza, non se ne effettuarono: si trattava in complesso, quante se ne verificavano, di guerricciole impegnate con i propri vicini di confine; ma vere e proprie campagne. militari, molto lontane dal proprio paese e a scopo di dominio, i Greci non usavano organizzare. Perché non esistevano città che si fossero affiancate in soggezione a stati più potenti: nemmeno pensavano di sostenere, a condizioni di parità, spedizioni comuni; pertanto le singole genti preferivano guerreggiare coi propri vicini. In occasione tuttavia di un antico conflitto esploso tra Calcidesi e quelli di Eretria, anche le altre popolazioni greche si trovarono divise, alleandosi chi con l'uno chi con l'altro belligerante.
16. In vari paesi di Grecia intervennero diversi fattori negativi, che ne interruppero il progresso. Anche presso gli Ioni, per addurre un esempio: la loro potenza era già discretamente avanzata, quando Ciro con il regno di Persia, dopo aver abbattuto Creso e assoggettato il paese che si stende tra il fiume Alis e il mare, mosse loro guerra e soggiogò le città sul continente. Inoltre Dario, tempo dopo, forte della flotta fenicia, asservì le isole.
17. I tiranni, quanti v'erano nelle città greche, con lo sguardo egoisticamente teso al personale interesse, all'incolumità fisica oltre che al crescente prestigio della propria casata, preferivano dedicarsi, fin tanto ch'era loro possibile e per evidenti ragioni di sicurezza, alle questioni di politica interna, ciascuno nel chiuso delle proprie città: nessuna impresa pertanto fu da loro diretta, che fosse degna di memoria eccettuata forse qualche incursione a spese delle genti limitrofe. Non certo i tiranni di Sicilia, che invece conquistarono una grande potenza. In tal modo, da ogni parte e per lungo tempo, la Grecia si trovò praticamente preclusa la via a qualunque impresa veramente apprezzabile, poiché le città, singolarmente prese, mancavano di spirito d'iniziativa.
18. I tiranni d'Atene e quelli delle altre parti di Grecia, soggetta anche prima di Atene e in varie località alle tirannidi, furono abbattuti finalmente, per la maggior parte, eccetto quelli in Sicilia, dagli Spartani. (Poiché Sparta, dopo la sua fondazione ad opera di quei Dori che attualmente l'abitano, pur sconvolta da interni fermenti per il periodo di tempo più esteso di cui s'abbia storicamente memoria, pure fin dall'antichità godette per la concordia delle sue componenti politiche una temperata costituzione e in seguito fu sciolta sempre dalla tirannide: son corsi quattrocent'anni circa e poco più fino alla conclusione di questo conflitto, da quando gli Spartani adottano, immutato, quell'ordinamento politico. Fatti possenti da questa salda coesione interna stabilivano anche le forme di governo nelle altre città). Dopo l'espulsione dei tiranni dalla Grecia, dicevamo, trascorsi non molti anni si combatté a Maratona tra Persiani e Ateniesi. Passan dieci anni, e una seconda volta lo straniero cala in Grecia con quell'esercito sconfinato, deciso a soggiogarla. Il pericolo immineva gravissimo: gli Spartani, che eccellevano per potenza militare, si assunsero il comando dei Greci, serrati in alleanza a respingere il nemico. Per parte loro gli Ateniesi, mentre avanzava l'aggressione persiana. decisero di abbandonare del tutto la città raccolsero i loro beni di fortuna e si imbarcarono sulle navi da guerra: si fecero così esperti del mare. Respinto lo straniero con sforzo concorde, non passò molto che il fronte comune dei Greci, di quelli che si erano emancipati dal Gran Re e di quelli che ne avevano retto l'assalto, si spezzò in contrapposti blocchi, polarizzandosi l'uno intorno ad Atene l'altro a Sparta. Questi due stati disponevano evidentemente delle potenze maggiori: gli uni sulla terra, gli altri con la flotta. L'intesa fra loro non fu duratura. Presto i rapporti s'incrinarono. Spartani e Ateniesi entrarono in uno stato di guerra, con al fianco i rispettivi collegati. Gli altri Greci poi, se insorgevano contrasti, si inserivano nell'orbita dell'una o dell'altra potenza. Di conseguenza il periodo tra il conflitto persiano e questa guerra fu tutto un avvicendarsi continuo di tregue e di atti di ostilità reciproci o sferrati contro i propri alleati dissidenti: così i Greci raffinarono la tecnica delle azioni militari e, costretti all'esercizio ininterrotto tra effettivi pericoli, ne approfondirono la competenza.
19. Gli Spartani, esercitavano l'egemonia sugli alleati senza costringerli alla soggezione del tributo attenti solo a che i loro sistemi politici si conformassero ai precetti dell'oligarchia e riuscissero sostanzialmente di vantaggio solo alla loro città, Sparta. All'opposto, gli Ateniesi non solo requisivano via via le flotte dei paesi collegati, all'infuori di quelle di Chio e di Lesbo, ma imposero, in generale, il versamento di determinate quote. In effetti, le risorse e gli armamenti di cui disponevano preparandosi ad entrare in guerra superavano in potenza quelli del tempo in cui erano al fiorire del loro splendore e la loro coalizione non s'era ancora spezzata.
20. È questo il frutto delle indagini e dello studio, cui ho sottoposto i fatti antichi: materia difficile ad accertarsi, scrutando ogni singolo indizio e testimonianza man mano che si presentava. Poiché gli uomini in genere accolgono e tramandano fra loro, senza vagliarle criticamente anche se concernono vicende della propria terra, le memorie del passato. Ad esempio, la gente in Atene è convinta che Ipparco sia stato assassinato da Armodio e Aristogitone, mentre reggeva la tirannide e non è al corrente che era Ippia, primogenito dei figli di Pisistrato, a dominare e che Ipparco e Tessalo erano suoi fratelli. In quel giorno, e mentre proprio si accingevano all'azione, Armodio e Aristogitone furono colti dal sospetto che qualcuno del complotto li avesse denunciati ad Ippia. Si tennero quindi lontani da lui, convinti che fosse preavvertito. Ma pure desideravano, prima della cattura, por mano a qualche gesto esemplare, esporsi a qualche memorabile pericolo e imbattutisi in Ipparco che ordinava la processione Panatenaica nella località detta Leocorio, lo ammazzarono. Ma su numerosi altri particolari di vicende contemporanee, non ancora offuscati dal tempo, gli altri Greci non posseggono cognizioni chiare ed esatte. Sono persuasi, ad esempio, che i re Spartani dispongano ciascuno non di un voto, ma di due, e che presso di loro vi sia la schiera denominata Pitane, che in realtà non è mai esistita. Così intraprendono molti, con troppa leggerezza, la ricerca della verità, e preferiscono arrestarsi agli elementi immediati, che non esigono applicazione e studio.
21. Gli argomenti invece e gli indizi da me addotti assicurano la possibilità d'interpretare i fatti storici, quali io stesso ho passato in rassegna, con una certezza che non si discosta essenzialmente dal vero. Per questo, non ci si affidi piuttosto ai poeti, che nell'esaltazione del canto ampliano ogni particolare e lo fanno prezioso; insicure anche le opere dei logografi, composte più a diletto dell'ascolto, che a severa indagine della verità. Poiché si tratta di un campo di ricerca in cui la verifica è estremamente ardua: l'antichità stessa di questi casi ne ha velato i contorni di un favoloso, mitico alone. Si converrà che il prodotto delle mie ricerche, elaborato dall'analisi degli elementi di prova più sicuri e perspicui, raggiunge la sufficienza, se si considera la distanza di tempo che ci separa dagli eventi discussi. Questa guerra, sebbene di norma gli uomini valutino più grave il conflitto in cui sono di volta in volta impegnati, per poi, rivolgere, appena l'attuale è spento, la loro ammirazione ai fatti d'armi più antichi, risulterà sempre, a chi esamini la realtà con dati concreti, la più importante di tutte.
22. Per quanto concerne i discorsi pronunciati da ciascun oratore, quando la guerra era imminente o già infuriava, era impresa critica riprodurne a memoria, con precisione e completezza, i rispettivi contenuti; per me, di quanti avevo personalmente udito, e per gli altri che da luoghi diversi me ne riferivano. Questo metodo ho seguito riscrivendo i discorsi: riprodurre il linguaggio con cui i singoli personaggi, a parer mio avrebbero espresso nelle contingenze che via via si susseguivano i provvedimenti ritenuti ogni volta più opportuni. Ho impiegato il massimo scrupolo nel mantenermi il più possibile aderente al senso complessivo dei discorsi effettivamente declamati. Ho ritenuto mio dovere descrivere le azioni compiute in questa guerra non sulla base di elementi d'informazione ricevuti dal primo che incontrassi per via; né come paresse a me, con un'approssimazione arbitraria, ma analizzando con infinita cura e precisione, naturalmente nei confini del possibile, ogni particolare dei fatti cui avessi di persona assistito, o che altri mi avessero riportato. La boriosa e complessa indagine: poiché le memorie di quanti intervennero in una stessa azione, non coincidono mai sulle medesime circostanze e sfumature di quella. Da qui resoconti diversi, a seconda della individuale capacità di ricordo o delle soggettive propensioni. Il tono severo della mia storia, mai indulgente al fiabesco, suonerà forse scabro all'orecchio: basterà che stimino la mia opera feconda quanti vogliono scrutare e penetrare la verità delle vicende passate e di quelle che nel tempo futuro, per le leggi immanenti al mondo umano, s'attueranno di simili, o perfino d'identiche. Possesso per l'eternità è la mia storia, non composta per la lode, immediata e subito spenta, espressa dall'ascolto pubblico.
23. Delle antecedenti imprese, la più importante fu la guerra persiana: eppure si risolse rapidamente con due soli scontri navali e di fanterie. Questa guerra s'è trascinata invece a lungo, generando dolori e patimenti in Grecia, quali mai, in tale tratto di tempo, s'erano avuti. Mai tante città, travolte nel conflitto, languirono spopolate. Fu opera dei barbari per alcune, per altre degli stessi contendenti (non mancano esempi di città espugnate che mutarono i propri abitanti). Mai tanti profughi e tanto sangue, versato combattendo negli infiniti episodi di guerra o nelle lotte civili. Molti casi straordinari, trasmessi prima per tradizione orale, ma raramente verificati alla prova dei fatti, confermarono la loro indubbia esistenza: terremoti ad esempio, che sconvolsero zone molto ampie, intensificandosi con inusitata violenza. Eclissi solari che intervennero più frequenti di quelle accadute, a memoria d'uomo, nelle epoche andate. Certe siccità interminabili flagellavano talune contrade, onde carestie imperversanti, e quell'epidemia che tanta desolazione e lutto seminò per la Grecia: tutte sventure esplose parallele al decorso di questa guerra. La fecero scoppiare Ateniesi e Peloponnesi, abrogando i patti trentennali che avevano stipulato dopo l'occupazione dell'Eubea. Espongo dapprima le cause e gli attriti che produssero quest'atto d'abrogazione, perché nessuno debba più, in seguito, indagare le origini di questa guerra. Sono convinto che la motivazione più autentica, quella però che meno traspariva dai discorsi ufficiali, fosse la formidabile potenza conseguita da Atene e l'apprensione che ne derivava per Sparta: e la guerra fu inevitabile. Le ragioni invece, addotte nelle rispettive dichiarazioni rilasciate dai belligeranti, per la rottura dei patti e lo scoppio delle ostilità, erano le seguenti.
24. La città di Epidamno è situata alla destra di chi entri navigando nel golfo Ionio. Nei suoi dintorni hanno dimora i Taulanti, barbari di stirpe illirica. Questa località fu colonizzata dai Corciresi: ne fu fondatore e capo Falio, nato da Eratoclide, di schiatta Corinzia, dei discendenti da Eracle. Fu invitato a recarsi colà dalla madrepatria, in osservanza dell'antico costume. Presero parte alla colonizzazione anche alcuni tra i Corinzi e del resto delle genti doriche. Con il trascorrere del tempo, Epidamno si fece una città potente e popolosa. Dopo parecchi anni di lotte civili, come è fama, furono ridotti in rovina da una guerra sostenuta contro popolazioni barbare confinanti e la loro potenza declinò notevolmente. Negli ultimi tempi prima di questa guerra, la parte democratica aveva scacciato da Epidamno gli oligarchi, i quali, fiancheggiati dai barbari, fecero ritorno depredando quelli che erano rimasti in città, per terra e sul mare. Gli Epidamni che si trovavano in città, oppressi dalle continue violenze, spediscono una legazione a Corcira, come loro madrepatria: supplicano che non si assista inerti al loro massacro, che si cerchi di rimettere pace tra loro e gli esiliati, che si faccia cessare l'ostilità dei barbari. Queste le richieste avanzate dagli ambasciatori, postisi in atto di supplici davanti al tempio di Era. Il governo di Corcira non accolse la loro preghiera, rimandandoli senza aver rilasciato nessuna promessa concreta.
25. Quando gli Epidamni appresero che Corcira non avrebbe stanziato nessun aiuto per loro, non erano in grado di trovare un qualsiasi sbocco alle difficoltà presenti. Così mandarono dei legati a Delfi a consultare l'oracolo di Apollo, se dovessero consegnare la città ai Corinzi, come fondatori della colonia e tentare di ottener da loro una difesa. Il responso fu di affidarsi ai Corinzi, sottomettendosi fiduciosi alle loro direttive. Gli Epidamni si recarono dunque a Corinto secondo la volontà dell'oracolo e consegnarono la colonia avvalendosi del fatto che il loro fondatore era originario di Corinto e notificando il testo dell'oracolo: li pregavano di non tollerare senza far nulla il loro massacro, che accorressero a difenderli. I Corinzi si assunsero il compito della loro tutela, in parte per sentimenti di giustizia, riflettendo che la colonia in fondo apparteneva a loro non meno che ai Corciresi, ma più accesi di rancore nei confronti di quelli che, sebbene ne fossero coloni, non li rispettavano come si conveniva. Poiché in occasione delle grandi adunanze festive comuni non attribuivano loro i privilegi rituali e non offrivano la prima e scelta parte di ogni vittima sacrificale a un cittadino di Corinto, com'era regola per le altre colonie. Li trattavano inoltre con irriguardosa sufficienza, dacché in quel tempo disponevano di un potere economico pari alle città più ricche di Grecia, e militarmente, erano addirittura più preparati e forti. Quanto alla flotta, in qualche occasione si gloriavano d'esser superiori di molto, in relazione anche al fatto che i Feaci così celebri per la loro arte nautica, avevano avuto sede in Corcira (onde con tanto più impegno armavano la flotta e, in realtà, erano davvero potenti: al principio della guerra i Corciresi potevano contare su centoventi triremi).
26. Bruciando dunque di risentimento per le suddette ragioni i Corinzi furono lieti di inviare il contingente di soccorso ad Epidamno, incitando a recarvisi come coloro chiunque volesse, scortati da truppe di Ambracia, di Leucade e di Corinto stessa. I Corciresi quando conobbero che ad Epidamno affluivano coloni e scorte armate e che la colonia era stata consegnata ai Corinzi, s'irritarono. Posta rapidamente in mare una squadra di venticinque unità e poi un contingente ulteriore imponevano minacciosi agli Epidamni di riaccogliere gli esuli (i profughi di Epidamno si erano recati infatti a Corcira e, additando i sepolcri dei loro progenitori e con il ricordo dell'antica consanguineità, li avevano supplicati di ricondurli in patria). C'era l'ordine inoltre di licenziare le guarnigioni e i coloni mandati da Corinto. Gli Epidamni non prestarono orecchio a nessuna di tali richieste. I Corciresi allora con quaranta navi muovono contro di loro, coi profughi, decisi a restituirli in patria, e forti d'un corpo d'Illiri. Si attendarono davanti alla città proclamando che ne uscissero incolumi gli stranieri e chi volesse degli Epidamni; in caso contrario, li avrebbero tenuti per nemici. Nessun segno di risposta: i Corciresi si disposero ad assediare la città, collocata su un istmo.
27. I Corinzi, dal canto loro, quando li raggiunsero dei messaggeri da Epidamno con la notizia ch'erano stretti d'assedio, allestivano una spedizione e insieme facevano bandire una colonia ad Epidamno, promettendo uguaglianza di condizioni e di diritti a chiunque volesse recarvisi. Se poi uno lì sul momento non si trovava disposto alla partenza, ma desiderava prender parte alla colonia, restasse pure a casa, impegnando come cauzione cinquanta dracme corinzie. Così furono in molti a partire, e molti a depositare il denaro. Chiesero a quelli di Megara di scortarli con le loro navi temendo d'esser bloccati in mare dai Corciresi: e quelli si preparavano a seguirli con otto navi, e i Paleesi di Cefallenia con quattro. Ne richiesero anche agli Epidauri, ché ne fornirono cinque; gli Ermoniesi una e i Trezeni due; quelli di Leucade dieci e gli Ambracioti otto. Ai Tebani e ai Fliasi chiesero denaro, agli Elei denaro e navi senza ciurma. Le navi armate dai Corinzi erano trenta e i loro opliti tremila.
28. Giunta notizia di tali preparativi, i Corciresi si recarono a Corinto, accompagnati dagli ambasciatori spartani e di Sicione che avevano preso con sé e intimarono ai Corinzi di richiamare indietro le guarnigioni da Epidamno e i loro coloni, poiché Epidamno non era terra che li riguardasse. Se però i Corinzi ritenevano di poter avanzar qualche pretesa, erano disposti ad accogliere le decisioni di un arbitrato nel Peloponneso, presso la città su cui i contendenti si trovassero concordi. Riuscirebbe vincitrice quella delle due parti cui si decidesse di assegnare la colonia. Erano anche disposti a sottoporre la controversia all'oracolo di Apollo a Delfi. Erano decisi a non permettere la guerra: in caso diverso, si sarebbero visti costretti, dicevano, per la loro violenta condotta, a cercar di collegarsi con genti diverse dalle attuali alleate, e che a loro non piacevano, per ragioni di profitto. I Corinzi ribatterono: scenderebbero a trattati e solo a patto che fossero ritirati da Epidamno le navi e i contingenti barbari. Ma, in primo luogo, non era onorevole che gli uni subissero un assedio, e loro stessero a far discussioni. I Corciresi ripresero che solo se i Corinzi avessero richiamato da Epidamno i loro avrebbero accolto le proposte avanzate: erano anche pronti a questo, che le due parti rimanessero nelle posizioni occupate, si stilasse una tregua e si attendesse l'esito dell'arbitrato.
29. I Corinzi non accolsero nessuna delle proposte fatte, ma dopo che le loro navi furono fornite di equipaggi ed erano giunti gli alleati, mandarono subito avanti un araldo, con la dichiarazione di guerra ai Corciresi salpando con settantacinque navi e duemila opliti fecero rotta su Epidamno, per attaccare i Corciresi: erano strateghi della flotta Aristeo figlio di Pellico, Callicrate figlio di Callia e Timanore figlio di Timante, e dell'esercito Archetimo figlio di Euritimo e Isarchida figlio di Isarco. Quando quelli furono all'altezza di Azio nella regione Anattoria, dove è sito il santuario di Apollo, all'imboccatura del golfo di Ambracia, i Corciresi mandarono loro incontro su una scialuppa un araldo, intimando di non proseguire la navigazione contro di loro. Intanto però equipaggiavano le navi, riparando le vecchie, che erano in grado di tenere il mare, e altre che avevano allestite. Come l'araldo tornò a riferire che dai Corinzi non si aspettassero alcun segno di pace, e le loro navi furono pronte in numero di ottanta (quaranta infatti partecipavano all'assedio di Epidamno), si portarono a ridosso del nemico, e messisi in formazione, diedero battaglia. Vinsero nettamente i Corciresi: affondarono quindici navi nemiche. Quel giorno stesso si verificò un ulteriore vantaggio per loro: quelli che assediavano Epidamno avevano costretto la città alla resa con le condizioni seguenti: gli stranieri venduti schiavi, i Corinzi prigionieri in catene, fino a che intervenisse una decisione diversa.
30. Dopo lo scontro sul mare i Corciresi elevarono a Leucimma, che è un promontorio di Corcira, un trofeo; passarono per le armi tutti gli altri prigionieri catturati; i Corinzi invece furon posti in catene. In seguito, dopo che i Corinzi e gli alleati, sconfitti sul mare, tornarono ai loro paesi, i Corciresi restavano dominatori di quello specchio di mare, e messa la prua su Leucade, colonia di Corinto, ne devastarono il territorio e diedero fuoco a Cillene, porto militare degli Elei, in quanto avevano posto navi e denaro a disposizione dei Corinzi. Per quasi l'intero periodo che seguì lo scontro, i Corciresi ebbero la supremazia del mare e con la flotta da guerra infliggevano seri danni agli alleati dei Corinzi. Finché costoro l'estate successiva, mobilitando una flotta e un esercito, poiché i loro alleati si trovavano a mal partito, si attendarono ad Azio e presso Chimerio, un luogo della Tesprotide, per vigilare su Leucade e gli altri centri loro amici. Di contro anche i Corciresi posero il campo a Leucimma, con le navi e le truppe. Nessuna delle due parti prendeva l'iniziativa di un attacco: restarono accampati l'uno contro l'altro per tutta quell'estate e solo al sopraggiungere dell'inverno si ritirarono entrambi nei loro paesi.
31. Per l'intero anno che seguì lo scontro navale e per il successivo, i Corinzi, ardendo di rancore per l'esito del conflitto con Corcira, erano impegnati ad allestire navi e venivano armando una flotta che fosse forte il più possibile: per questo attiravano rematori, oltre che dal Peloponneso, dal resto della Grecia, promettendo una lauta paga. Le informazioni sui preparativi nemici suscitarono in Corcira uno stato d'allarme. Poiché non erano alleati con nessuna popolazione greca e non avevano aderito né alla coalizione ateniese né a quella spartana, presero consiglio di rivolgersi ad Atene, divenirne alleati, e tentare di ottenere di là una qualche forma di aiuto. I Corinzi informati di questa manovra, vennero anche loro ad Atene, in ambasceria, per vedere se fosse possibile impedire che alla flotta di Corcira si affiancasse anche quella ateniese, creando ostacoli alla conclusione della guerra, com'essi la desideravano. Di fronte all'assemblea convocata, posero a confronto le loro ragioni e i Corciresi, per primi, in tal modo le espressero.
32. "È cosa giusta, cittadini d'Atene, che chi ricorre al vicino con una preghiera di soccorso, come noi in questo momento, e non gode il credito di un importante beneficio reso da tempo o d'un patto d'alleanza precedentemente stretto, cerchi in primo luogo e soprattutto di chiarire a fondo che quanto richiede è anche di vantaggio agli interlocutori, in altro caso, almeno che non è loro di danno; poi, che la propria riconoscenza rimarrà incrollabile. Se non saprà porre nella più limpida luce questi assunti, non si sdegni poi del sicuro insuccesso. Quelli di Corcira ci hanno mandato a voi con la richiesta d'alleanza e intimamente persuasi di potervi garantire, in futuro, questi punti. In effetti, è risultato che il nostro tipo di atteggiamento politico non solo viene ora rivelando nei vostri confronti tutta la sua incongruenza rispetto alla richiesta che vi proponiamo, ma anche quanto sia di svantaggio a noi stessi, in questo particolare momento. Poiché noi, che fino ad ora non abbiamo mai gradito e accettato l'alleanza di nessuno, veniamo adesso da altri, proprio a richiederla. Non solo: nella presente guerra contro i Corinzi la nostra condotta ci ha fatti trovare isolati. Quel che prima giudicavamo prudenza, cioè il non sottoporci, alleandoci con genti estranee, ai loro medesimi rischi eseguendo i piani elaborati da un vicino, si chiarisce ora come dissennatezza e impotenza. Certo, nel precedente scontro navale abbiamo soverchiato i Corinzi con le nostre sole forze. Ma ora muovono contro di noi dal.Peloponneso e dal resto della Grecia con una potenza bellica ben più considerevole, da cui noi vediamo che non ci è possibile scampare, se restiamo isolati, con le nostre uniche risorse. Inoltre, è ben grave il pericolo per noi se cadremo in loro potere: perciò è indispensabile che noi chiediamo l'aiuto vostro o di chiunque altro. Ci si comprenda, se troviamo ora il coraggio di intraprendere un corso politico nuovo rispetto al precedente immobilismo, non per bassezza d'animo, ma nella coscienza che si è trattato di un errore di valutazione.
33. "Se vi lascerete persuadere, l'occasione della nostra richiesta vi sarà di vantaggio sotto molteplici riguardi. Principalmente, fornirete mezzi di soccorso a gente che subisce un'ingiustizia, non che la perpetra in danno altrui; in secondo luogo, accettandoci come alleati mentre ci troviamo in un rischio di gravità estrema, vi conquisterete la nostra assoluta riconoscenza con una testimonianza perenne. Da ultimo, noi possediamo la flotta più cospicua dopo la vostra. Riflettete ora: quale più rara occasione di fortuna per voi, o di danno per i vostri nemici, di questa. Se cioè quella potenza che voi, chissà a quale prezzo d'oro e di favori stimereste degno annettervi alleata, essa è qui spontanea, che vi si dà, senza rischi e senza costarvi nulla. Vi procura anzi, di fronte al mondo, fama di magnanimi, riconoscenza da parte di un popolo che difendete e, al vostro paese, un'accresciuta potenza: vantaggiose occasioni, che a ben pochi in ogni tempo si sono presentate tutte insieme, come ben pochi, cercando un'alleanza, possono offrire a chi interpellano sicurezza e decoro non inferiori a quelli che sperano di ricevere. Se alcuno di voi è convinto che non scoppierà la guerra, in cui potremmo esservi utili, commette un grossolano errore. Non s'avvede che gli Spartani desiderano la guerra per timore di voi; ché i Corinzi godono notevole ascendente su di loro e vi sono ostili; che tentano di sottometter prima noi e poi attaccarvi. Essi temono che il nostro comune odio ci colleghi strettamente contro di loro e di veder quindi sfumare uno dei due scopi che si propongono: danneggiare noi o acquistar loro in forza. Sia comune impresa dunque prevenirli: noi offrendo, voi accettando l'alleanza. Si preferisca attaccarli prima di dovercene difendere.
34. "Se poi i Corinzi diranno ingiusto il fatto che voi accettiate in alleanza i loro coloni, sappiano che ogni colonia se è trattata con benevolenza ha riguardo per la madrepatria, ma se subisce torti si volge altrove: lo scopo dei coloni, emigrando, è d'esser pari in diritti ai concittadini, non schiavi. L'ingiustizia è palese, poiché quando li invitammo ad Epidamno per un arbitrato preferirono cercare di sciogliere la questione con la guerra, che con procedimenti legali. Vi serva di prova la loro linea d'azione verso di noi, consanguinei: sicché non vi lasciate fuorviare dal loro inganno, né ottemperate con un aiuto pratico e immediato alle loro richieste, quando ve le porgeranno. Giacché è più sicura l'esistenza di colui che si procura motivi il più possibile scarsi di pentimento per aver favorito i propri avversari.
35. "Non infrangerete la tregua con gli Spartani, accettandoci nella vostra lega, in quanto non siamo alleati di nessuno dei due. Si proclama infatti nei trattati che a qualunque delle città greche, non comprese nelle coalizioni, si consente di cercare appoggio da chi meglio ritiene. Sarebbe un terribile controsenso politico se costoro potessero equipaggiare le navi con forze attirate dai paesi del patto e per giunta dal resto della Grecia, anzi perfino dalle città a voi soggette, e riuscissero poi ad escluderci dall'alleanza ora in discussione e da ogni altra possibilità di soccorso, considerando un iniquo colpo vibrato a loro la vostra eventuale adesione alla nostra istanza. Potremo avanzare noi, invece, rimostranze assai più gravi, se non riusciremo a convincervi. Respingerete infatti noi, in estremo pericolo e che pur non vi siano nemici, senza curarvi di apporre un valido freno all'ostilità aggressiva di costoro, anzi assisterete inerti allo spettacolo di Corinto che incrementa il proprio potenziale bellico con leve tratte dal vostro impero. Ebbene, non è giusto! sarebbe dover vostro d'impedir con la forza a quelli di assoldare mercenari dai vostri paesi e d'inviarci invece quel soccorso a cui vi lascerete persuadere: sarebbe più conveniente che ci accordaste aperta protezione, nella vostra lega. Molti lati vantaggiosi siamo in grado di mostrare, come anticipammo aprendo il nostro intervento: il più interessante è che ci opporremo agli stessi nemici, garanzia che è la più certa, e per giunta nemici niente affatto da sottovalutare, ma che dispongono di forze bastevoli a punire chiunque tenti la defezione. Poiché la nostra è profferta d'alleanza marinara e non terrestre, certo sarà per voi ben differente se la rivolgessimo ad altri: badate infatti, se potete, a non lasciare che un'altra nazione acquisti una flotta, altrimenti cercate l'unione con quella che si dimostri più forte sui mari.
36. "Chiunque è convinto dentro di sé dei sopraddetti vantaggi e tuttavia - può accadere - teme che la sua eventuale adesione costituisca una rottura dei patti rifletta che il suo timore, congiunto alla forza, indurrà piuttosto i suoi nemici a un prudente rispetto; l'eccessiva fiducia, qualora declini la nostra offerta d'alleanza, non fondata su un potenziamento concreto, preoccuperà debolmente dei nemici realmente forti. Tenga conto che ora si discute su Corcira ma ancor più su Atene, i cui affari non amministra con la preveggenza più accorta se, in vista di un futuro conflitto per poco non già effettivo, attento solo agli interessi presenti, esita ad aggregarsi le forze di un popolo con cui intrattenere rapporti di pace o di guerra è del massimo peso. Non solo Corcira è situata proprio sulla rotta per l'Italia e la Sicilia, onde può agevolmente bloccare una flotta che di là accorra ai Peloponnesi in appoggio, come favorirne una in transito da Atene a quelle terre, ma anche per altro è utilissima. Dunque riassumendo in breve la questione nel suo insieme e nei particolari, dovrebbe persuadervi a non respingerci la riflessione seguente: sono tre le forze navali considerevoli, in Grecia: la nostra, la vostra e quella corinzia. Se consentirete a due d'esse di congiungersi, e i Corinzi metteranno le mani su di noi, avrete contro sui mari le flotte di Corcira e del Peloponneso. Se ci accettate invece, potrete scendere in lotta contro di loro mobilitando in più anche le nostre navi." Tali gli argomenti espressi dagli uomini di Corcira. I Corinzi ribatterono come segue.
37. "È necessario, poiché i qui presenti Corciresi non hanno voluto limitare l'intervento alla loro alleanza e alla vostra eventuale adesione, ma vengono a sostenere che li vessiamo con una guerra illegittima, che similmente anche noi ci soffermiamo su questi due punti, esaurendo in seguito i successivi aspetti della questione, affinché disponiate in precedenza di una cognizione netta e sicura sulla volontà nostra e decliniate, a ragion veduta, la richiesta di costoro. Dicono di non essere entrati prima in lega con nessuno per prudenza: hanno intrapreso invece questa linea politica perché sono delinquenti, non per rettitudine. Non erano disposti ad allearsi con complici dei loro soprusi, né ad aver testimoni da reclamare poi a discolpa, con somma vergogna. La loro città, dalla posizione così indipendente, permette loro di essere giudici delle loro sopraffazioni, più che spingerli alle alleanze: è raro infatti che si rechino per nave in terre straniere, mentre spessissimo accade che ricevano gli altri Greci, cui è indispensabile l'approdo alle loro coste. Così questa decorosa facciata di un isolamento internazionale l'hanno eretta a ricovero non di una mancata complicità con altri, ma delle loro azioni illegali, commesse in perfetta solitudine; per disporre con la violenza di quanto riescono ad avere in pugno, per incrementare indisturbati i loro criminali guadagni, per predare quanto si può con tranquilla sfrontatezza. Che se fossero stati, come sostengono, uomini probi, quanto più erano inattaccabili dai vicini, tanto più sarebbe stato loro possibile far mostra di integrità, sottostando alle regole dei trattati in vigore.
38. "Non furono tali mai, né con altri, né con noi: sono nostri coloni, e si comportano da sempre con la più assoluta indipendenza, anzi ora ci attaccano, adducendo a pretesto che la patria non li avrebbe inviati laggiù per peggiorare la loro posizione. Siamo noi ora a reclamare che non abbiamo dedotto quella colonia per essere oltraggiati da costoro, ma per affermare la nostra supremazia e riscuoterne il doveroso tributo di rispetto. Certo presso le altre colonie ci circonda un profondo prestigio, per non dire un'affettuosa devozione. Indubbiamente, se siamo graditi ai più, la loro singolare malevolenza non potrebbe che risultare immotivata, né ci saremmo impegnati in questa spedizione fuori dell'ordinario, senza aver ricevuto un oltraggio veramente brutale. Se pure fossimo noi in colpa, sarebbe stato un atto decoroso per questi uomini piegarsi al nostro risentimento, per noi invece una vergogna sforzare la loro mansuetudine. Si sono esaltati invece, per le loro disponibilità finanziarie, e hanno preso a infliggerci torti l'uno dopo l'altro, finché da ultimo conquistarono a forza Epidamno, nostra colonia, e non la cedono, ora che siamo accorsi in suo aiuto, mentre non pretesero affatto di occuparsene quando versava in pessime acque.
39. "Sostengono d'esser stati prima disposti a un giudizio, in cui però, sia ben chiaro, un dibattito corretto e valido s'imposta non arroccati su un proprio vantaggio e provocando l'arbitrato da posizione inattaccabile, ma stabilendo preliminarmente una perfetta coerenza tra parole e fatti quindi affrontandosi pure nella disputa. Per contro, questi han tratto fuori quel bell'argomento del giudizio non prima di assediare Epidamno, ma dopo essersi convinti che non avremmo tollerato un atto simile. Ora si presentano, non soddisfatti dei crimini commessi laggiù, stimando di potervi convincere ad un'alleanza, che invero è una complicità, e sperando che li accogliate, in quanto voi e noi apparteniamo a blocchi politici opposti. Allora bisognava che essi si facessero avanti, quando erano completamente al sicuro; non ora che noi siamo oltraggiati e loro in pericolo. E voi, che non utilizzaste un tempo le loro forze armate, li metterete a parte della vostra protezione. Pur innocenti delle loro colpe, ne subirete, ai nostri occhi, un pari carico di responsabilità: solo se voi aveste già goduto l'appoggio, in antico, di una loro alleanza militare, dovreste ora sopportare con loro le conseguenze di una politica avventata.
40. "Che le nostre recriminazioni siano ben fondate e che costoro siano dei brutali prevaricatori, è ormai un punto saldo: passiamo ora a dimostrare che sarebbe illegittima la vostra adesione alle loro richieste. È vero: è pattuito nei trattati che a qualunque città autonoma sia lecito rivolgersi all'una o all'altra delle coalizioni: la clausola però non contempla chi s'iscrive per recar danno ad altri, ma chi, senza sottrarsi a precedenti impegni, è in cerca di un aiuto sicuro e non procurerà guerra invece che pace a coloro che lo accoglieranno, se hanno del buon senso. È quanto invece vi accadrà, se non ci date ascolto. Poiché non solo diverrete alleati in difesa di costoro, ma nemici nostri, e decadrà il valore dei patti. Inevitabilmente, se li appoggiate ora, dovrete collaborare alla loro difesa. La vostra neutralità invece sarebbe cosa più giusta: al più, il vostro impegno offensivo dalla nostra parte contro costoro. Poiché voi siete vincolati a un patto con Corinto. Con Corcira non stipulaste mai nemmeno una tregua. È opportuno che voi non erigiate a regola l'accogliere chi si ribella agli altri. Neppur noi infatti, quando si verificò la rivolta dei Sami, deponemmo un voto a voi contrario. Il resto dei Peloponnesi s'era invece trovato diviso nel voto sulle necessità di soccorrerli: allora in polemica con loro sostenemmo la tesi che ciascun popolo deve adottare autonome misure punitive nei confronti dei propri alleati. Attenti: il vostro appoggio a popoli che hanno compiuto azioni illegali nei nostri riguardi provocherà evidentemente una defezione di portata non inferiore di vostri soggetti dalla nostra parte. E avrete stabilito una norma più dannosa alla vostra città che a noi.
41. "Tali dunque i motivi di giustizia a sostegno della nostra causa, nei vostri confronti, validi secondo le leggi vigenti nel mondo greco: ma rechiamo anche l'invito e la pretesa di un atto di benevolenza che, poiché non siamo tanto nemici da compiere azioni d'aperta ostilità né tanto amici da sentirci autorizzati a chieder certi favori, pure riteniamo doveroso da parte vostra in questo momento, a titolo di riconoscenza. Nel tempo in cui eravate afflitti dalla scarsità di navi da combattimento, durante la guerra eginetica, prima dell'invasione persiana, riceveste dai Corinzi venti navi. Questo favore, e quello prestatovi in occasione dell'affare dei Sami (fu per intervento nostro che i Peloponnesi non li aiutarono) vi consentì di sopraffare gli Egineti e di punire i Sami. E ciò accadde in quei momenti particolari in cui gli uomini, totalmente assorti nello sforzo contro il nemico, non si preoccupano più di nulla, al di fuori della vittoria. Poiché accolgono come un amico chi li sostiene, anche se prima era nemico, e avversario chi li abbandona, anche se le loro precedenti relazioni potevano essere di amicizia. E lasciano cadere in rovina anche i propri interessi, nella brama d'una vittoria immediata.
42. "Riflettete su queste ragioni e chi è troppo giovane ne interroghi i più anziani tra voi, si convinca ch'è doveroso ricambiarci. Non ritenga che queste parole sian sì giuste ad udirle, ma, in caso di conflitto, l'utile stia da tutt'altra parte. Poiché la condotta più vantaggiosa consiste nel commettere un numero minimo d'errori e mentre il futuro di questa guerra, di cui tanto temono i Corciresi da spingervi alla loro complicità, è ancora del tutto ipotetico, considerate che per nulla incerta, anzi immediata vi attirereste l'ostilità di Corinto, se vi lasciate trascinare da quella paura. Sarebbe piuttosto prudente dissipare il sospetto che s'istaurò tra noi dall'affare di Megara. (Poiché un atto di favore, pure un po' in ritardo, e d'entità inferiore, è in grado di cancellare un capo d'accusa.) Non appoggiatevi con troppa fiducia alla prospettiva di quella grande alleanza navale che vi offrono: infatti, una politica di relazioni assolutamente corrette con potenze eguali costituisce, per un paese, una forza più salda che conquistarsi, nell'eccitazione provocata da momentanee e fallaci apparenze, un vantaggio a prezzo d'infiniti pericoli.
43. "Siamo noi ora a ricadere nella situazione cui si riferiva la nostra proposta avanzata a Sparta, che ciascuno si occupi da sé delle punizioni da infliggere ai propri alleati. Ora vi richiediamo di ricambiarci con lo stesso atteggiamento politico. Vi fu utile il nostro voto; non danneggiateci ora col vostro. Ripagateci con un pari favore, nella convinzione che proprio la presente è una delle occasioni nelle quali chi appoggia è amico, e chi si schiera contro è nemico. Non accettate questi uomini di Corcira come alleati contro il volere nostro. Non soccorrete la loro iniquità. Ispirate da questi principi, le vostre azioni saranno legali e avrete deliberato, anche per quanto concerne i vostri interessi, il meglio."
44. Tale fu il tenore del discorso pronunciato dai Corinzi. Gli Ateniesi udirono le parti e convocarono l'assemblea in due sedute. Nella prima accolsero i motivi addotti dai Corinzi con pari favore di quelli esposti da Corcira. Ma nella successiva mutarono opinione in questo senso: stringevano con Corcira non un'alleanza che prevedesse per le due potenze attacco o difesa contro gli stessi paesi (se i Corciresi infatti avessero loro imposto di partecipare a un assalto alla flotta di Corinto, Atene si sarebbe vista sciolta dai patti di tregua stipulati con i Peloponnesi); ma concordarono un'intesa militare di reciproco soccorso, nell'eventualità di un'aggressione a Corcira, ad Atene o ai loro alleati. Anche gli Ateniesi presentivano distintamente che sarebbe esplosa la guerra contro i Peloponnesi e non erano disposti a lasciare in mani corinzie Corcira, così potentemente armata sul mare. Cercavano perciò di esasperare al massimo il contrasto politico tra i due stati: nell'eventualità che un conflitto divenisse inevitabile, avrebbero avuto di fronte un nemico comunque più debole, si trattasse dei Corinzi o di altri con a disposizione una flotta da guerra. Da ultimo l'isola era sita in un punto molto opportuno, se ne avvedevano bene, sulla rotta per la Sicilia e l'Italia.
45. Fondandosi su queste considerazioni gli Ateniesi accolsero le richieste dei Corciresi e quando i Corinzi partirono, non molto dopo, inviarono a loro soccorso dieci navi al comando di Lacedemonio figlio di Cimone, Diotimo figlio di Strombico, e Protea figlio di Epicle. Ricevettero queste istruzioni: non impegnare le proprie navi in battaglia coi Corinzi, se questi non dirigevano su Corcira, o non mostravano l'intenzione di effettuare uno sbarco laggiù o in qualche località che appartenesse a Corcira. Solo in questo caso dovevano opporsi con ogni forza. Erano indispensabili tali avvisi per non provocare la rottura dei patti.
46. Così la flotta salpò per Corcira. Anche i Corinzi, quand'ebbero concluso i loro preparativi, si diressero verso l'isola con centocinquanta navi. Ve ne erano dieci di Elei, dodici dei Megaresi e dieci di Leucade, ventisette degli Ambracioti e una degli Anattori. Quelle di Corinto erano novanta: dalle singole città provenivano anche i loro comandanti; da Corinto Senocleide figlio di Euticle, con altri quattro. Salpati da Leucade si portarono nelle vicinanze della costa antistante Corcira. Porsero le navi all'ancora a Chimerio, nella Tesprotide. Si tratta di un porto: sorge su esso, un po' lontana dal mare, la città di Efira nel territorio eleatico della Tesprotide. Lì presso sbocca in mare il lago Acheronte. Bagnando la Tesprotide, il fiume Acheronte sfocia nel lago e gli dà il nome. Vi scorre anche il fiume Tiami, che segna il confine tra la Tesprotide e la Cestrine. Tra i due fiumi è situato il promontorio Chimerio. Proprio in questa località del continente i Corinzi gettarono l'ancora e si attendarono.
47. I Corciresi, come seppero che il nemico era in acque vicine, equipaggiarono centodieci navi, affidandole al comando di Miciade, Esenide e Euribato: posero il loro campo in una delle isole che hanno nome Sibota. Erano presenti anche le dieci navi attiche. Sulla punta di Leucimma era dislocata la fanteria dei Corciresi e i mille opliti che erano accorsi da Zacinto, in appoggio. Ma anche i Corinzi, sul continente, trovarono numerosi reparti di barbari, pronti all'aiuto. Infatti, gli abitanti di questa zona del continente erano sempre stati in rapporti di buona amicizia con loro.
48. Armate ed equipaggiate le navi, i Corinzi, presi con sé viveri per tre giorni, salparono di notte dal Chimerio, decisi alla battaglia sul mare. All'alba avvistarono in navigazione la flotta dei Corciresi: si trovava al largo e dirigeva su di loro. Si scorsero e rapidamente si contrapposero in formazione da battaglia: sul lato destro dello schieramento corcirese si notavano le navi attiche, il resto lo occupavano i Corciresi stessi, dopo aver formato tre squadre di navi, con al comando di ciascuna uno dei tre strateghi. Tale fu l'ordine dei Corciresi. L'ala destra del fronte Corinzio era tenuta dalle navi di Megara e di Ambracia. Al centro gli altri alleati, ciascuno al loro posto. All'ala sinistra si dislocarono i Corinzi, a contrastare gli Ateniesi, e l'ala destra degli avversari, con le navi che meglio tenevano il mare.
49. Da entrambe le linee si levò il segnale, vi fu lo scontro e la battaglia divampò. Disponevano di molti opliti sui ponti, di arcieri e lanciatori di giavellotti, in quanto le due parti, all'uso antico, possedevano scarsa esperienza tecnica d'armamento navale. La mischia durò violentissima: ma non fu notevole per la destrezza dei marinai combattenti, anzi in tutto paragonabile a uno scontro terrestre. Dopo ogni urto, non riusciva agevole alle navi districarsi l'una dall'altra, per l'addensarsi fitto e disordinato degli scafi. Si battevano, convinti che le possibilità di vittoria fossero in mano agli opliti sui ponti delle navi: e quelli combattevano saldi e dritti sulle tolde delle navi, immobili. Non attuavano manovre di rottura delle linee nemiche: d'impeto lottavano e d'appassionata violenza, più che con abilità consapevole. Lo specchio di mare in cui si scontravano le navi ferveva tutto di clamore e di scompiglio immenso. Intanto, le navi attiche si presentavano ad appoggiare i Corciresi, se in qualche punto minacciavano di cedere, e incutevano timore agli avversari. Ma non entravano mai nel vivo della battaglia, poiché i comandanti ricordavano bene il divieto d'Atene. L'ala destra dei Corinzi subiva la rotta più grave: con venti navi il nemico li costrinse a ripiegare, li disperse inseguendoli fino alla costa. Spinse le navi fino in prossimità del campo corinzio, sbarcò e arse le tende saccheggiandone i beni. Da questa parte dunque i Corinzi e i loro alleati avevano la peggio e i Corciresi dominavano. Ma dove combattevano i soli Corinzi, all'ala sinistra, stavano riportando una vittoria netta, perché ai Corciresi, già inferiori per numero di navi, mancavano anche quelle impegnate nello 'inseguimento. Gli Ateniesi, vedendo che i Corciresi ripiegavano, li sostenevano ormai senza più nessuna coperta esitazione, mentre prima si sottraevano a ogni urto diretto. Ma dopo che la disfatta dei Corciresi apparve in tutta la sua gravità e i Corinzi li premevano, allora ognuno entrò nella mischia in una confusione divenuta generale: la situazione, già intricata, degenerò inevitabilmente a tal segno che Corinzi e Ateniesi presero a battersi.
50. Travolto il nemico, i Corinzi tralasciavano di legare a rimorchio gli scafi delle navi avversarie poste fuori combattimento: ne uccidevano sistematicamente gli equipaggi, passando da una nave all'altra. Non catturavano prigionieri vivi. Massacravano ignari anche i loro stessi alleati: non si erano avveduti che quelli dell'ala destra ripiegavano. Operavano moltissime navi su entrambi i fronti e occupavano un'ampia distesa di mare; nel complesso groviglio della mischia, era difficoltoso per gli stessi combattenti riconoscere chi vincesse e chi fosse sopraffatto. Questa battaglia navale tra Greci risultò, per numero di navi impiegate, la più importante tra quelle combattute fino a quel tempo. Dopo che i Corinzi incalzarono i Corciresi fino alla loro terra, si volsero a raccogliere i relitti delle proprie navi e i cadaveri dei loro caduti. Se ne impossessarono della maggior parte e ne effettuarono il trasporto alle Sibota. Colà si era raggruppato il contingente dei loro ausiliari barbari. Le Sibota sono un porto deserto della Tesprotide. Dopo queste operazioni, serrarono ancora le file e presero il mare alla volta dei Corciresi. Anche costoro, con le navi ancora manovrabili e quante rimanevano, spalleggiati dalle navi attiche, si preparavano a contrastarli, nel timore che tentassero uno sbarco nella loro terra. Era ormai tardi: già era stato elevato il peana, preludio alla mischia, quando i Corinzi, d'un tratto, presero a far sforzo all'indietro sui remi. Avevano avvistato 20 navi ateniesi dirette contro di loro: gli Ateniesi le avevano fatte partire in seguito, per soccorrere le prime 10, nel dubbio, poi confermato dai fatti, che i Corciresi subissero un rovescio e le loro 10 navi non costituissero una copertura sufficiente.
51. I Corinzi manovravano per ripiegare: le avevano scorte da lontano e sospettavano che provenissero da Atene, e che fossero un numero maggiore di quante riuscivano ad avvistarne. Ai Corciresi non era possibile vederle (quelle si avvicinavano ma erano ancora fuori della loro portata visiva) e si stupivano che i Corinzi remassero indietro, finché alcuni, quando le videro, gridarono che da quella parte sopraggiungevano delle navi. Anch'essi allora stavano ritirandosi: calava già la sera e i Corinzi, volte le prue, posero fine alla battaglia. Così si separarono e lo scontro si concluse all'arrivo della notte. I Corciresi si attendarono a Leucimma. Quelle 20 navi ateniesi al comando di Glaucone figlio di Leagro e di Andocide figlio di Leogora, aprendosi la strada tra cadaveri e frantumi di chiglie, approdarono presso l'accampamento: non era molto da che erano state viste. I Corciresi (era notte) temettero dapprima un assalto, poi le riconobbero: e quelle si ormeggiarono.
52. L'alba successiva, le 30 navi attiche con quelle corciresi in grado di tenere il mare, navigarono fino al porto delle Sibota, in cui erano all'ancora i Corinzi. Era loro intenzione di sincerarsi se avrebbero accettato un nuovo scontro. Quelli, allontanate le navi dalla costa, le disponevano al largo, in formazione da combattimento e attendevano. Non avevano in mente d'essere loro a dare inizio alla battaglia. Vedevano in perfetta efficienza le navi ateniesi che s'erano aggiunte alla flotta nemica; inoltre varie difficoltà si eran loro presentate: la mancanza di attrezzature per riparare gli scafi in avaria, laggiù in un porto fuori mano. Inoltre, li tormentava l'apprensione per il ritorno in patria: era incerto per dove avrebbero potuto passare e temevano che gli Ateniesi, ormai convinti che la tregua fosse interrotta, dato che avevano combattuto, non li lasciassero partire.
53. Decisero dunque d'imbarcare alcuni dei loro su una scialuppa e di mandarli, sprovvisti di caduceo a scrutarne i disegni. Il messaggio inviato fu il seguente: "È ingiusto da parte vostra, Ateniesi, aprire le ostilità e rompere la tregua: noi procediamo alla punizione dei nostri nemici e voi ci create ostacoli con le armi. Se il vostro piano è d'impedirci l'accesso a Corcira, o a qualunque altro luogo scegliamo per la nostra rotta e considerate sospesa la tregua, eccoci per primi; trattateci da nemici". Tali le loro parole: tutti i Corciresi, che dalla loro posizione li avevano potuti udire urlarono di prenderli senza indugio e ucciderli, ma gli Ateniesi replicarono: "Uomini del Peloponneso, noi non violiamo i patti: solo veniamo in aiuto a Corcira, ch'è nostra alleata. In qualunque altro luogo preferiate dirigervi, non l'impediamo: ma se tenterete lo sbarco a Corcira o a qualcuna delle sue terre, non lo permetteremo, con tutte le nostre forze."
54. In seguito a questa risposta ateniese i Corinzi preparavano il ritorno a casa ed elevarono un trofeo nelle Sibota del continente. I Corciresi raccolsero i morti e i relitti che la corrente e la brezza avevano trascinato dalla loro parte ed eressero anche loro un trofeo nell'isola Sibota convinti d'aver avuto in pugno la vittoria. Entrambi si arrogavano il successo con tali ragionamenti: i Corinzi perché avevano dominato lo scontro fino a notte, potendo recuperare la maggior parte dei relitti e delle salme. Inoltre tenevano in catene non meno di 1000 uomini e avevano affondato circa 70 navi. Per questo innalzarono il trofeo. I Corciresi avevano distrutto circa 30 navi e dopo l'arrivo dei rinforzi ateniesi erano riusciti a raccogliere frantumi e salme, che erano dalla loro parte; e infine, il giorno prima i Corinzi, alla vista delle navi attiche, avevano remato indietro ripiegando di fronte a loro. Dopo il sopraggiungere degli Ateniesi non si erano più fatti incontro dal porto delle Sibota. Perciò eressero il trofeo. Così entrambi erano convinti della propria vittoria.
55. I Corinzi sulla rotta verso la patria, presero con l'inganno Anattorio, che è situata all'imbocco del golfo di Ambracia (apparteneva in comune a loro e ai Corciresi) e dopo avervi distaccata una colonia di Corinzi, fecero ritorno a casa. Dei prigionieri corciresi 800, tutti servi e personale di bordo, li vendettero, 256 li tenevano come prigionieri, ma con grandissime attenzioni, nella speranza che, al ritorno a Corcira, si adoperassero per ottener loro la riconciliazione. Si dava il caso che tra costoro vi fossero anche alcuni tra i più influenti della città. Con questo felice e agevole successo Corcira superò il conflitto con i Corinzi. Le navi Ateniesi si posero sulla rotta per rientrare in patria. Ma fu questa la causa prima della guerra tra Corinto e Atene, la circostanza cioè che gli Ateniesi, pur legati ai Corinzi da un trattato, li avevano combattuti sul mare per soccorrere Corcira.
56. Ben presto, dopo questi fatti, intervennero tra Ateniesi e Peloponnesi anche i seguenti motivi d'attrito, che li indussero alla guerra. Poiché i Corinzi brigavano meditando assiduamente una vendetta e gli Ateniesi ne temevano con sospetto l'odio, questi ultimi ingiunsero agli abitanti di Potidea, colonia di Corinto, alleata di Atene soggetta a tributo, situata sull'istmo di Pallene, di demolire il muro verso Pallene e consegnare ostaggi; dovevano allontanare poi gli attuali epidemiurghi e rifiutarsi di accogliere quelli che in futuro, ogni anno, sarebbero stati inviati dai Corinzi. Temeva Atene che quelli di Potidea defezionassero, subornati da Perdicca e dai Corinzi e convincessero a una rivolta generale anche gli altri alleati di Tracia.
57. Gli Ateniesi avevano deciso questi provvedimenti contro i Potideati, a scopo cautelativo, subito dopo lo scontro nel mare di Corcira: i Corinzi infatti mostravano ormai aperta tutta la loro ostilità. Anche Perdicca, figlio di Alessandro re dei Macedoni, s'era fatto ostile, da alleato ed amico. Motivo dell'avversione fu che gli Ateniesi avevano stretto un'alleanza con suo fratello Filippo e con Derda, che gli si erano coalizzati contro. Temendoli, da una parte tramava inviando messi a Sparta per far insorgere una guerra tra Atene e i Peloponnesi, dall'altra tentava di addurre i Corinzi dalla propria parte per agevolare la rivolta a Potidea. Intratteneva contatti con i Calcidesi sulla costa della Tracia e con i Bottiei per farli ribellare. Calcolava, che con l'appoggio e l'alleanza di queste terre di confine, gli sarebbe stato più facile condurre la guerra. Ma gli Ateniesi furono informati di queste relazioni e intenzionati a prevenire la rivolta nelle città (infatti avevano già pensato di inviare trenta navi con mille opliti nel paese di Perdicca, agli ordini di Archestrato figlio di Licomede con altri nove strateghi) inviarono ai comandanti la squadra navale l'ordine di prendere ostaggi dai Potideati e far demolire il muro: tenessero inoltre sotto sorveglianza le città circostanti, per impedirne la rivolta.
58. Gli abitanti di Potidea, pur mandando messi anche agli Ateniesi per tentare di convincerli a non adottare misure ostili nei loro confronti, si recarono in ambasceria a Sparta, accompagnati dai Corinzi, e là cercavano il modo d'ottenere un aiuto, nel caso che se ne presentasse il bisogno. Infatti, nonostante tutto il loro impegno, ad Atene non ricavavano nulla di promettente. Poiché le navi dirette in Macedonia facevano vela egualmente contro di loro e le autorità spartane avevano promesso, in caso di attacco ateniese contro Potidea, di invadere l'Attica, colsero questa occasione per insorgere, collegati da un patto con i Calcidesi e i Bottiei. Perdicca intanto persuase i Calcidesi ad abbandonare i centri della costa dopo averli rasi al suolo, per trasferirsi ad Olinto fortificando quest'unica città. A questi, che lasciavano la patria, distribuì da coltivare una parte dei suoi possedimenti in Migdonia intorno al lago Bolbe, finché durasse lo stato di guerra contro Atene. E quelli si andavano a stabilire nell'interno del paese, demolite le loro città, e insieme si preparavano al conflitto.
59. Le trenta navi attiche giunsero in Tracia e trovarono che Potidea e le altre località erano insorte. Gli strateghi, considerando che era impossibile con le sole forze a disposizione condurre la guerra contro Perdicca e la lega delle città in rivolta, si rivolsero contro la Macedonia, che in effetti era la prima meta della loro spedizione e, stabilitisi laggiù, intraprendevano azioni militari in collegamento con Filippo e i fratelli di Derda, che dall'interno del paese avevano fatto impeto con un esercito.
60. Nello stesso tempo i Corinzi, poiché Potidea aveva defezionato e le navi attiche incrociavano davanti alle coste della Macedonia, in ansia per la sorte di quei paesi e con la netta sensazione che il pericolo incombesse egualmente su loro stessi, inviano laggiù volontari propri e uomini assoldati dagli altri centri peloponnesiaci: in tutto 1600 opliti e 400 di armatura leggera. Erano al comando di Aristeo figlio di Adimanto. La maggior parte dei volontari corinzi lo seguì per il profondo senso d'amicizia che li legava a lui. Aveva sempre avuto con quelli di Potidea rapporti molto amichevoli. Giunsero in Tracia il quarantesimo giorno dalla ribellione di Potidea.
61. Ben presto arrivò ad Atene la notizia che quelle città erano insorte e, quando giunse successiva l'informazione che anche quelli al comando di Aristeo s'eran posti in marcia, gli Ateniesi inviarono 2000 dei loro opliti e 40 navi contro le città ribelli, e come stratego Callia figlio di Calliade, con altri 4 colleghi. Pervenuti in Macedonia, constatarono subito che i mille opliti inviati in precedenza avevano da poco conquistato Terme ed erano impegnati nell'assedio di Pidna. Stabilitovi anch'essi il campo assediarono Pidna, ma in seguito, accordatisi con Perdicca e avendo stretto con lui un'alleanza ormai inevitabile, poiché li urgeva l'ansia delle vicende di Potidea e del sopraggiungere laggiù di Aristeo, si levarono dalla Macedonia, giunsero a Beroia e di là a Strepsia. Fu vano il tentativo di occupare quella fortezza: desistettero mettendosi in marcia per via di terra verso Potidea, con 300 opliti dei loro oltre a numerosi alleati e ai 600 cavalieri macedoni al seguito di Filippo e Pausania: contemporaneamente 70 navi li accompagnavano costeggiando. Avanzando a brevi tappe, il terzo giorno toccarono Gigono e lì posero le tende.
62. Quelli di Potidea e i Peloponnesi agli ordini di Aristeo, attendendo gli Ateniesi, si erano accampati sull'istmo, nei pressi di Olinto e avevano costituito un mercato fuori le mura. Gli alleati elessero a stratego dell'intero esercito Aristeo, e capo della cavalleria Perdicca: infatti, costui aveva ben presto abbandonato la parte ateniese e combatteva con Potidea, dopo aver sostituito in Macedonia il suo comando con quello di Iolao. Il piano di Aristeo si configurava così: trattenere con sé sull'istmo il suo esercito, a vigilare sugli Ateniesi, se mai tentassero l'avanzata; i Calcidesi, gli alleati esterni all'istmo e i 200 cavalieri agli ordini di Perdicca dovevano acquartierarsi invece in Olinto, e qualora gli Ateniesi muovessero contro Aristeo e i suoi, con un assalto alle spalle, avrebbero serrato il nemico nel cerchio dei due schieramenti. Per parte sua Callia, stratego ateniese, e i suoi colleghi di comando inviano ad Olinto la cavalleria macedone e un ristretto contingente alleato, per bloccare l'eventuale soccorso al nemico da quella direzione. Il resto di loro invece, levato il campo, si diresse a Potidea. Quando furono prossimi dell'istmo e avvistarono i nemici schierati e pronti alla battaglia, si contrapposero anch'essi in ordine e in breve divampò la mischia. L'ala personalmente diretta da Aristeo e le truppe scelte dei Corinzi e di altri collegati che operavano in quel settore travolsero i loro immediati avversari e li incalzarono in fuga per gran tratto; ma l'altra ala dell'esercito dove combattevano le milizie di Potidea e degli altri Peloponnesi, cedette sotto l'urto degli Ateniesi e trovò rifugio nelle mura.
63. Ripiegava Aristeo dall'inseguimento, e s'avvide che il resto delle truppe era in rotta. Non seppe al momento decidere in quale direzione scatenare la battaglia, per aprirsi una ritirata: se verso Olinto o Potidea: ritenne preferibile serrare i suoi in un gruppo il più possibile compatto e tentare di corsa un varco in direzione di Potidea. E vi riuscì, percorrendo un molo sul mare, sotto una tempesta di colpi nemici e a gran fatica. Perse pochi uomini: gli altri, il maggior numero, furono condotti in salvo. Le truppe attestate in Olinto, in attesa di soccorrere Potidea (la distanza tra le due località è di 60 stadi circa e il terreno è scoperto) al principio della battaglia, quando si levarono le insegne, avanzarono di poco, mostrando l'intenzione di soccorrere: ma la cavalleria macedone sbarrò subito il passo, in ordine di battaglia. Poiché gli Ateniesi conseguirono una vittoria così fulminea, le insegne furono nuovamente abbassate: e quelli si convinsero a ripiegare verso le mura, mentre i Macedoni retrocedevano per ricongiungersi con gli Ateniesi. Le opposte cavallerie non si erano gettate nel fuoco della mischia. Dopo la battaglia, gli Ateniesi elevarono un trofeo e permisero a quelli di Potidea, sotto la garanzia di una tregua, il recupero dei caduti. Sul campo giacevano poco meno di trecento uomini di Potidea e dei suoi alleati; centocinquanta Ateniesi e lo stratega Callia.
64. Gli Ateniesi eressero in fretta, opposto alle mura di Potidea, sull'istmo, un baluardo per tagliarle fuori, e vi stallarono postazioni di guardia. La cinta di mura verso Pallene rimaneva invece sguarnita. Calcolavano di non aver truppe bastevoli al presidio dell'istmo e, nello stesso tempo, per effettuare il passaggio di una parte degli uomini dalla parte di Pallene per costruire anche di là un muro di sbarramento: temevano che, quando avessero divise le forze per attuare quel piano, quelli di Potidea e gli alleati li aggredissero. Quando gli Ateniesi rimasti in città appresero che Pallene non era ancora bloccata da fortificazioni murarie, dopo un certo periodo inviano 1600 dei loro opliti, sotto gli ordini dello stratego Formione figlio di Asopio. Costui, giunto a Pallene e muovendo dalla base di Afitia faceva avvicinare il suo esercito a Potidea avanzando a brevi tappe e desolando intanto la regione. Nessuno si presentava a contrastarli. Tagliò fuori con un baluardo le mura di Potidea rivolte a Pallene. In tal modo da entrambi i lati la città era cinta da un assedio poderoso, e bloccata dal mare per le navi lì presso ormeggiate.
65. Aristeo comprese che la circostanza era critica: la città isolata dalle muraglie nemiche, e nessuna speranza di salvezza, se non nel caso di qualche soccorso proveniente dal Peloponneso o qualche altra insospettabile fortuna. Consigliò che, tranne cinquecento uomini, tutti gli altri aspettassero il vento opportuno e tentassero di allontanarsi per nave, per far in modo che le scorte di viveri durassero più a lungo: si dichiarava disposto a condividere la sorte di quanti restavano. Poiché non riusciva a persuaderli ed era deciso sia a porre riparo alle presenti difficoltà sia a procurare che la situazione all'esterno si evolvesse in modo più favorevole, compì per mare una sortita, elusa la guardia ateniese. Attendandosi nella Calcidica, partecipò ad alcune azioni militari tra cui un agguato presso la città dei Sermili, cui inflisse pesanti perdite. Frattanto manteneva contatti con i Peloponnesi, per ricavarne una qualche forma di aiuto. Dopo il blocco di Potidea, Formione, coi suoi milleseicento soldati, devastava i territori calcidesi e bottiei, conquistando anche alcuni fortilizi.
66. S'erano dunque creati, prima del conflitto, nei rapporti tra Atene e i popoli del Peloponneso, questi nuovi motivi di recriminazione: per i Corinzi, il fatto che gli Ateniesi cingessero di assedio Potidea, loro colonia, e i soldati corinzi e peloponnesi chiusi dentro, per gli Ateniesi invece, nei riguardi dei Peloponnesi, il fatto che essi avevano fomentato la rivolta in una città soggetta all'alleanza e al tributo d'Atene e che, venuti apertamente in loro soccorso, si battevano a fianco di quelli di Potidea. E invero la guerra non era ancora divampata, ma vigeva sempre una tregua d'armi, in quanto i Corinzi avevano agito su iniziativa puramente privata.
67. Eppure costoro, mentre Potidea era stretta dall'assedio, non si potevano tenere inattivi, non solo perché vi erano rimasti bloccati loro concittadini, ma temendo anche per il futuro di quella fortezza. Convocarono subito gli alleati a Sparta e recativisi anch'essi scagliavano veementi accuse contro gli Ateniesi, che avevano infranti i patti rendendosi colpevoli contro gli stati del Peloponneso. Anche gli Egineti, pur evitando di scoprirsi mandando delegazioni ufficiali, perché temevano Atene, soffiavano di nascosto sul fuoco della guerra, diffondendo la voce che non erano indipendenti come dovevano garantire i trattati. Dopo aver invitati anche quanti della loro lega sostenevano di aver subito torti dagli Ateniesi, gli Spartani adunarono la consueta assemblea ed esortarono ad esporre ciascuno le proprie rimostranze. Così fecero, presentandosi a turno, e tra gli altri anche quelli di Megara che esposero numerosi motivi di dissenso con Atene, soffermandosi sulla circostanza che, contro i trattati, si vietava loro l'accesso ai porti del dominio ateniese e venivano esclusi dagli scambi commerciali con l'Attica. Intervenuti ultimi i Corinzi, dopo aver lasciato che gli altri esacerbassero lo sdegno spartano, così si espressero:
68. "La fiducia, uomini di Sparta, che nella vostra comunità impronta i rapporti pubblici e i personali contatti, vi ispira una esagerata diffidenza se talvolta muoviamo una critica alla condotta altrui: qualità che vi conferisce una misurata prudenza, ma per cui siete affetti, nelle vostre relazioni con gli altri stati, da un'acuta miopia politica. Poiché, sebbene in varie occasioni vi avessimo preavvertito degli attacchi che ci avrebbe inferto Atene, voi non vi davate la pena di chiarire e interpretare le informazioni che vi venivamo, di volta in volta, porgendo, ma preferivate accogliere i nostri sfoghi con il consueto sospetto, fra voi persuasi, in fondo, che ci si presentasse a perorare per motivi di contrasto essenzialmente particolari e privati. Onde, non prima di patire qualche ingiuria, ma quando già ne subiamo praticamente l'esperienza, raccoglieste a concilio gli alleati qui presenti, tra i quali spetta a noi reclamare più forte, in quanto più pesanti risultano i capi d'accusa che abbiamo in serbo oltraggiati dagli Ateniesi e offesi dalla vostra noncuranza. Se usassero macchinare nell'ombra le loro illegalità ai danni dei Greci, allora vi si converrebbe far luce, come a gente che ignora: ma ora, c'è necessità di prolissi discorsi? Vedete chiaro: essi già tengono soggiogati alcuni, mentre insidiano la libertà d'altri, non ultimi anche alcuni tra i nostri alleati; con notevolissimo anticipo stanno effettuando la loro preparazione militare, calcolando l'eventualità di un conflitto. Non avrebbero potuto, altrimenti, non solo annettersi Corcira con la frode, contro il nostro volere, ma nemmeno tenere Potidea assediata: località di cui l'una è piazzaforte di primaria importanza per il successo delle operazioni belliche sulla costa della Tracia, mentre l'altra avrebbe dotato le forze dei Peloponnesi di una flotta molto considerevole.
69. "La responsabilità dell'attuale situazione è nettamente vostra: in primo luogo, avete loro consentito di far potente la città, dopo le guerre persiane, e in seguito di erigere le lunghe mura, defraudando così fino ad ora sistematicamente della loro indipendenza non solo quanti già servono sotto il loro giogo, ma perfino genti che sono vostre alleate: poiché non tanto chi effettua un asservimento quanto chi pur potendo cancellarlo, ne assiste inerte allo spettacolo, è il suo più autentico esecutore. Soprattutto se reca in sé il vanto e la considerazione di valoroso e di liberatore della Grecia. Appena ora ci riuniamo nel presente consesso, ma neppure in questa occasione con propositi lucidamente definiti. Occorre che si esamini ora non se subiamo oltraggio, ma la nostra futura linea difensiva: poiché gli uomini veramente d'azione sono quelli che portano con fulminea energia il loro attacco dopo che hanno ponderato il loro piano in ogni particolare contro gente che non ha ancora deciso e valutato a fondo la situazione. E noi conosciamo i procedimenti degli Ateniesi e come guadagnino spazio a poco a poco a danno dei limitrofi. Pensando di eludere inosservati la vostra apatica indifferenza, limitando per ora il loro ardimento, ma quando s'avvedranno che voi siete al corrente e pure li lasciate liberi d'agire, incalzeranno con più impavido vigore. Poiché voi soli di tutti i Greci, uomini di Sparta, restate immobili anteponendo una difesa fondata sull'indugio a una che faccia ricorso all'azione, voi soli a proporvi di demolire la potenza nemica in espansione, non quand'è al suo inizio, ma quand'è doppia di forze. Eppure si diceva che foste un popolo pieno di sicurezza: ma certamente questa voce era superiore alla realtà. Noi stessi sappiamo infatti che il Persiano ebbe tutto l'agio di venire dai confini del mondo fin nel Peloponneso prima che da parte vostra si muovesse un'opposizione armata degna d'esser considerata tale. Ora consentite libertà d'azione agli Ateniesi che non sono, come quello, remoti, ma prossimi, e invece d'esser voi a scatenare l'assalto preferite dover difendervi da loro, porvi nel rischio di una lotta contro un avversario molto superiore in potenza. Sapete che i barbari determinarono la loro stessa disfatta con la propria imprevidenza e che anche contro gli Ateniesi molti dei nostri successi furono dovuti più ai loro errori che a un aiuto proveniente da voi: poiché proprio le speranze in voi riposte hanno causato in molte occasioni la rovina di quanti si lasciarono cogliere sprovveduti, forti solo della fiducia in un vostro soccorso. Ma in nessuno tra voi queste critiche suscitino il pensiero di una ostilità da parte nostra: di una recriminazione piuttosto. Il rimproverare è usuale con uomini amici che siano in errore, l'accusare con nemici che siano in colpa.
70. "Al tempo stesso, noi ci sentiamo in diritto, forse come nessuno, di muovere rimproveri agli altri, soprattutto in quanto si tratta per noi di questioni vitalmente importanti e in relazione alle quali non ci pare proprio che usaste mai un certo discernimento, né che abbiate mai calcolato attentamente quali siano gli Ateniesi, con cui verrete a prova, e quanto, e come in tutto differisca il loro ingegno dal vostro. Sono innovatori essi, acuti e mobilissimi nei progetti, dinamici a convertirli in realizzazioni pratiche: e voi, sempre a cercar di conservare appena quanto possedete; mai un disegno ardito, uno slancio mentale, perfino nella pratica vi limitate al disbrigo del minimo necessario, e spesso anche in quello mancate. Ancora: accesi quelli d'audacia oltre il loro potere, temerari al di là di ogni logica, forti sempre delle loro speranze in ogni cimento: e a voi compete d'ottener invece, di regola, risultati scadenti in rapporto all'impegno che avreste potuto profondere; sfiduciati anche quando la riflessione v'assicura che le circostanze sono favorevoli saldamente; bravi solo a pensare in ogni frangente che non ne riuscirete mai indenni. E invero essi son sciolti da ogni impaccio o esitazione rispetto a voi, perennemente torpidi: vibranti al fascino delle terre lontane, come voi siete radicati alle pareti domestiche. Poiché quelli fidano di trar guadagno dal loro viaggiare, voi invece di mettere a rischio il vostro avere col muovere un passo fuori di casa. Vittoriosi sul nemico, avanzano più che possono; sconfitti ripiegano e cedono al minimo. E aggiungete che quelli, a servir lo stato, non curan di gettare energie e vita, come cose le più estranee; ma dell'intelligenza propria son gelosi, come della più adatta al progresso della città. Quanti progetti poi, per un caso o l'altro, non concludono, ritengono d'esser frodati di possessi loro per diritto; ma quando perseguendo alcunché l'ottengono, lo giudicano mediocre guadagno rispetto a quelli ch'essi s'aspettano futuri. Se talvolta, come accade, falliscono una prova, accesi di nuove e migliori speranze, infallibilmente colmano la momentanea perdita. Solo per loro sperare e possedere sono una cosa, ogni volta che si pongono in animo un traguardo; poiché son soliti tradurre celermente in opera ogni loro progetto. E sono i frutti questi d'un impegno strenuo, durato l'arco intero della vita, tra fatiche e pericoli; godono pochissimo i propri averi presenti, per la loro perenne tensione all'acquisto, e non considerano altra festa all'infuori che operare il proprio dovere ed è per loro più struggente sciagura sia un'inerzia improduttiva, che una attività aspra di fatica. Cosicché se alcuno volesse definire in breve la loro indole, direbbe giusto ch'essi sono venuti nel mondo per non goder mai loro stessi pace, né per lasciarla avere al resto degli uomini.
71. "Sebbene sia tale, uomini di Sparta, la città che vi si dispone contro, prendete tempo e non vi mostrate convinti che la pace sia per lo più possesso di quanti vivono in armi, senza commettere soprusi, ma lasciando trasparir chiaro dal loro atteggiamento morale che, se subiscono un'offesa, son fermi a non tollerarla. Voi invece interpretate l'equità come non recar danni altrui, per non dovere voi stessi sostenere il doloroso onere di un impegno difensivo. Otterreste a stento un simile risultato se aveste dimora presso una città eguale alla vostra: ma ora, come vi abbiamo da poco chiarito, i vostri intendimenti son troppo all'antica rispetto ai loro. È inevitabile, come nel campo dell'arte, che anche in politica abbia la supremazia chi di volta in volta avanza e si rinnova: quando uno stato è in pace, è preferibile certo che le istituzioni non mutino, ma se si è costretti ad affrontare diverse e fluide situazioni, occorre mobile ingegno, sempre pronto all'inventiva. Per questo, la capacità politica degli Ateniesi, scaltrita da molte e varie esperienze, è immensamente all'avanguardia, rispetto a voi. Ma il vostro torpore non oltrepassi questo limite: fornite ora, a quelli di Potidea e agli altri, quell'aiuto che avevate promesso, invadendo al più presto l'Attica, per non abbandonare agli avversari più accaniti uomini che vi sono amici e consanguinei. Non vogliate spingere noi pure a legarci, presi dallo sconforto, a un'alleanza diversa dalla vostra, Se tale fosse la nostra mossa futura non commetteremmo nulla d'ingiusto, ne al cospetto degli dei che tutelano i giuramenti, né degli uomini di senno. Scioglie i patti non chi, per esser stato abbandonato, si rivolge ad altri ma coloro che non Prestano il dovuto soccorso a quelli cui sono vincolati da un giuramento. Se voi intendete mostrare una decisa fierezza, resteremo: poiché non agiremmo secondo la santità dei patti né potremmo incontrare altri alleati più congeniali di voi. Prendete con senno la vostra decisione su questi fatti: badate che il vostro dominio non s'eserciti su un Peloponneso più angusto di quello che vi hanno lasciato i padri."
72. Questo fu il tenore dell'intervento corinzio. Si trovava già presente prima, per un caso, a Sparta, un'ambasceria ateniese, per questioni diverse: ma come ebbero udite le parole dei Corinzi, ritennero doveroso presentarsi agli Spartani, senza voler architettare una difesa alle imputazioni che le città avevano via via intentato, ma per chiarire da una prospettiva più generale come fosse conveniente a Sparta non decidere di fretta, ma solo dopo matura riflessione. E.volevano al tempo stesso far comprendere quale fosse in potenza la propria città e non solo rinverdire la memoria nei più anziani tra loro di quanto sapevano, ma anche esporre ai giovani le cose di cui non avevano esperienza, convinti che dal proprio racconto sarebbero stati esortati più alla pace che alla guerra. Presentatisi dunque agli Spartani, dichiararono di aver anch'essi desiderio di parlare davanti alla loro assemblea, se non s'interponeva qualche ostacolo. Quelli li invitarono a presentarsi pure e, davanti al consesso di Sparta e alleato, gli Ateniesi pronunciarono il seguente discorso:
73. "La nostra ambasceria non aveva lo scopo di sostenere un dibattimento con i vostri alleati, ma di trattare i punti per cui Atene ci ha inviato in missione. Ma, apprendendo che invettive non lievi sono scagliate contro di noi, ci presentiamo non per controbattere le imputazioni delle città vostre alleate (non siete voi i giudici infatti al cui cospetto dovrebbero pronunciarsi i discorsi nostri e di questi messi), ma perché non accada che voi, forse troppo facilmente persuasi dai vostri alleati su questioni politiche d'estrema gravità, scegliate il partito più nocivo. Inoltre siamo decisi a spiegare, in relazione al complesso delle voci e delle opinioni che sul nostro conto si sono ormai stabilite, che il frutto delle nostre conquiste non irragionevolmente ci appartiene e che la città nostra è degna di considerazione. È indispensabile ripercorrer fatti remoti nel tempo, di cui l'unica prova sono i racconti sorti dalla tradizione, non la testimonianza visiva di chi si disporrà ad udirli? Eppure le gesta contro il Persiano e quante appartengono anche alla vostra esperienza, se pur ne derivi annoiato fastidio verso chi di continuo le propone, vanno commemorate. Poiché quando agivamo si correva pericolo per la utilità collettiva, dei cui pratici frutti godete ora una parte, e della cui gloria quindi, se pur può giovarci a qualcosa, non vogliate del tutto privarci. Si parlerà ora qui non per ottenere una discolpa, ma per testificare e chiarire la natura della città contro cui sosterrete il vostro sforzo di guerra, nel caso di una deliberazione sconsiderata. Dichiariamo infatti che fummo soli a Maratona, quando ci esponemmo all'urto del barbaro; anche quando calò un'altra volta, non avendo milizie sufficienti a una difesa terrestre, imbarcati tutti sulle navi, combattemmo serrati sul mare a Salamina: con l'effetto che i Persiani non furono più in grado di devastare il Peloponneso assalendo per mare una città dopo l'altra. Centri cioè che non avrebbero potuto, contro una flotta numerosa, recarsi vicendevole soccorso. Il barbaro stesso ne forni la prova più convincente: sconfitto sul mare, non disponendo più di una potenza pari a quella nemica, si ritirò in patria con il grosso delle milizie.
74. "Risultò dunque decisivo il peso di quell'avvenimento e si fece ormai chiaro che la salvezza della Grecia era consistita nelle navi: a ciò fornimmo noi i tre fattori di più fondamentale rilevanza: il numero maggiore di navi, lo stratego più abile, l'animo più impavido. Infatti, di circa quattrocento navi, i due terzi appartenevano a noi, come era nostro stratego Temistocle, autore principale del piano che prevedeva lo scontro in quell'angusto specchio d'acqua. Circostanza che fuor di dubbio ci salvò. Per questo merito appunto lo gratificaste di un onore più grande che qualsiasi altro straniero giunto in visita da voi. Il nostro slancio sorpassò in audacia qualunque altro; noi che, poiché nessuno ci sovveniva per terra, e tutti i popoli circostanti erano già servi, stimammo di abbandonare la città e i nostri averi alla rovina, non per tradire la comune causa degli alleati superstiti né per disperderci, ormai inetti alla loro difesa, ma per salire sulle navi da guerra e dar battaglia, senza rancori per voi, per il vostro mancato soccorso. Sicché possiamo dichiarare d'esservi stati autori d'un aiuto non inferiore a quello che da voi ricevemmo. Voi infatti dalle vostre città, in cui ancora abitavate e al fine di potere ancor viverci in futuro, dopo che foste in preda al panico per la loro sorte, non già per noi, accorreste allora (nel tempo infatti in cui eravamo incolumi, non compariste mai); noi invece, muovendo da una città che ormai non esisteva più e tentando la fortuna delle armi in sua difesa, mentre il suo futuro era sospeso a una fievole speranza, salvammo insieme una parte di voi e noi stessi. Se fossimo subito passati dalla parte del Persiano, come gli altri o, convinti in partenza d'essere perduti, non avessimo avuto in seguito l'audacia d'imbarcarci sulle navi, non ci sarebbe più stata necessità per voi, che non avevate navi a sufficienza, di combatter sul mare in tutta tranquillità il nemico avrebbe conseguito gli obiettivi desiderati".
75. "Non siamo degni cittadini di Sparta per i nostri trascorsi atti di valore, e per la perspicacia dei nostri intendimenti di esercitare sui Greci l'attuale supremazia senza attirarci un'invidia e un odio così pesanti? Eppure noi l'assumemmo non con la violenza, ma poiché voi non eravate disposti ad affrontare il resto delle truppe barbare. Da noi invece si presentarono gli alleati con la spontanea preghiera di porci alla loro guida. La forza insita nei fatti ci indusse in un primo tempo a ampliare fino a questo segno il nostro dominio, soprattutto per il timore ispirato dallo straniero, in seguito per il nostro decoro, solo più tardi in vista nel nostro utile. Tenevamo ormai per poco sicuro, essendo invisi alla maggior parte degli alleati, di sottoporci al rischio di lasciarli indipendenti (avrebbero defezionato dalla parte vostra). Alcuni, dopo un tentativo di rivolta, erano già stati ridotti in condizione di sudditi, mentre voi non ci ricambiavate di pari amicizia, ma ci trattavate con sospetto e ostilità. Si concede a tutti, senza animosità, di stabilire al meglio, quando versa nei più gravi pericoli, la propria situazione.
76. "Per esempio voi, uomini di Sparta, esercitate la signoria sulle città del Peloponneso dopo averne confermati gli ordinamenti politici al vostro interesse: se, in quel tempo, perseguendo la guerra contro il barbaro fino alla sua conclusione, vi foste attirati, nel vostro dominio, un odio pari a quello che ora ci circonda, sappiamo bene che non avreste adottato meno rigide misure con gli alleati e vi sareste visti costretti o a governare con sistemi ferrei, o a rischiare voi stessi di perder l'impero. Così noi non ci siamo comportati in modo assolutamente straordinario: non ci pare estraneo alla mentalità umana, se accettammo una signoria che c'era offerta, non rinunciandovi più, sotto la spinta di tre potenti fattori: il decoro, il timore e l'utile. Non fummo noi i primi a porre in vigore questa legge, ma è universale e perenne norma che il più debole sia suddito del più forte. In aggiunta, noi ci stimiamo meritevoli del nostro dominio e tali anche a voi siamo sempre sembrati. Finché, per calcolo d'utilità ora sbandierate il concetto di giustizia. Ma chi realmente preferisce applicarlo, quando si offra l'occasione di realizzare con la forza un acquisto? Tutti procurano piuttosto d'incrementare i loro interessi. Meritano lode quanti, pur aderendo all'istinto proprio dell'uomo di dominare sugli altri si comportano con maggior giustizia rispetto alla potenza di cui dispongono. Pensiamo che se altri fossero entrati in possesso del nostro impero darebbero più chiaro risalto alla nostra moderazione, mentre dalla nostra equità è scaturito, del tutto fuori luogo, biasimo più che plauso.
77. "Sebbene infatti ci troviamo in condizioni di svantaggio rispetto agli alleati quando si discutono in casa loro processi relativi a trattati commerciali, mentre nei tribunali ateniesi vengono applicate norme del tutto imparziali, pure abbiamo fama di litigiosi. Ma nessuno esamina com'avviene che quanti posseggono in altre parti del mondo un dominio e con minor comprensione della nostra lo fanno valere sui loro alleati, non ne ricavino un tale biasimo. Chi ha licenza infatti d'usar la forza, non ha alcun bisogno di procedimenti giudiziari. I nostri alleati, per la consuetudine di intrattenere con noi rapporti d'assoluta parità, se in qualche sentenza patiscono un inaspettato rovescio o per una nostra decisione legale o per l'esercizio del nostro potere imperiale o per motivi diversi, non ci tributano gratitudine per aver conservato il più dei loro beni, ma si sdegnano per quanto vien loro sottratto, più profondamente che se noi, avendo fin dall'inizio cancellato ogni parvenza di legalità, esercitassimo sistematiche e inoppugnabili sopraffazioni. Allora neppur essi avrebbero negato la necessità che il debole sia soggetto al più forte. Quando subiscono un torto, com'è naturale, gli uomini si gonfiano di rancore più di quando sottostanno a una violenza: nel primo caso si ha l'impressione d'esser soverchiati da chi è eguale, nel secondo, di soggiacere a uno più forte. Per esempio, sottoposti dai Persiani a privazioni ben più dolorose di queste le tolleravano, ma la nostra signoria par troppo grave, è naturale; poiché la situazione presente è la più insopportabile per chi è soggetto. Se voi ci toglieste di mezzo e governaste al posto nostro, vedreste in breve tramontare il favore che ora godete, conseguenza diretta della paura che mai ispiriamo, qualora adottaste metodi uguali a quelli che lasciaste indovinare nel breve periodo di egemonia prima del conflitto persiano. Le usanze in vigore presso di voi sono incompatibili con quelle degli altri paesi e, per giunta, ognuno di voi, uscendo dalla propria città non si uniforma più ad esse, né a quelle in uso nel resto della Grecia.
78. "Ponderate la vostra decisione, che non è su questioni di piccolo momento: non vi lasciate indurre da sentimenti e recriminazioni altrui ad assumere un carico che sarebbe poi interamente vostro. Cercate di riflettere in anticipo alla dose d'imprevisto insita in una guerra, prima d'impegnarvi: una guerra, quando si prolunga, degenera di solito in un puro gioco della sorte, su cui nessuno dei due belligeranti, pari sotto questo rispetto, può esercitare un controllo, e il suo esito è sempre ignoto. Quando gli uomini entrano in guerra, si danno a precipizio all'azione: cosa che dovrebbero fare solo in un secondo momento. Solo quando subiscono le prime disfatte, si mettono a ragionare. Non abbiamo mai commesso questo errore, e vediamo che voi pure ne siete immuni. Perciò vi diciamo, fintanto che dipende ancora da entrambi la scelta di una decisione assennata, non sciogliete i patti e non trasgredite i giuramenti, risolvete le controversie secondo le convenzioni. In altro caso, ci siano testimoni gli dei che proteggono i giuramenti, se scatenerete la guerra vi respingeremo con ogni forza e coi mezzi che voi stessi ci avrete indicato."
79. Fu tale il contenuto delle parole ateniesi. Dopo aver dato ascolto alle accuse che gli alleati intentavano agli Ateniesi e all'intervento di questi ultimi, gli Spartani fecero allontanare tutti per tener consiglio, tra di loro, sullo sviluppo della situazione. I pareri dei più concordavano su un punto: il comportamento ateniese era illegale e bisognava scendere in guerra in gran fretta: ma si presenta Archidamo il loro re, considerato uomo capace e prudente, ed espone le sue osservazioni:
80. "Anch'io, o Spartani, ho esperienza di numerose guerre: come quanti vedo tra voi della mia stessa età. Quindi nessuno può desiderare la guerra per inesperienza, come a molti potrebbe accadere, né ritenerla utile e priva d'incognite. Se ponderaste saggiamente e a fondo questa guerra di cui ora si discute, trovereste che non è delle meno importanti. In confronto agli stati del Peloponneso e ai vicini, il nostro potenziale offensivo è pari, e sarebbe possibile scatenare un attacco in qualsiasi direzione, nel giro di pochissimi giorni. Ma ora la lotta è contro uomini che abitano una regione lontana e per di più espertissimi del mare; la loro preparazione militare è ottima e completa. Dispongono di possibilità finanziarie private e pubbliche, di flotte, cavalieri, armamenti, riserve d'uomini quante non esistono in nessun altro stato di Grecia, singolarmente considerato. Possono contare su un numero enorme di alleati soggetti a tributo. Come sollevare una guerra, così, alla leggera contro uomini simili? E su quali elementi fidarsi, per scaternarla a precipizio, senza adeguata preparazione? Sulla flotta? Siamo inferiori sul mare. Dovremo attendere per completare a nostra volta i preparativi bellici: ci vuol tempo. Sul denaro? Qui il nostro distacco è ancora più netto: la cassa pubblica ne è vuota e non possiamo esigerne sollecitamente dai privati.
81. "Qualcuno potrebbe alimentare i suoi propositi bellicosi con l'idea che li superiamo per armamenti e numero di soldati, e pensa che potremmo devastare il loro paese con ripetute irruzioni. Ma le terre su cui si stende il loro dominio sono molte e si riforniranno via mare di quanto mancano. Se poi cercheremo di far sollevare i loro alleati, bisognerà appoggiare i loro tentativi con le flotte, perché la maggior parte abita le isole. Che tipo di guerra condurremo dunque? Se infatti non li batteremo sul mare e non taglieremo loro l'afflusso di tributi con cui mantengono la loro forza navale, subiremo una completa disfatta. Non sarà allora decoroso per noi in queste condizioni riappacificarci, specialmente se prevarrà l'opinione che siamo stati noi i primi a sollevare la contesa. Non esaltiamoci neanche a quell'altra speranza che la guerra finirà in breve, se guastiamo il loro paese, temo piuttosto che la lasceremo in eredità ai nostri figli. Non è verosimile che gli Ateniesi, con la loro fierezza, si leghino schiavi alla propria terra né che, con la loro esperienza, si lascino piegare dalla guerra.
82. "Neppure comando di restare insensibili, e permettere che gli Ateniesi danneggino i nostri alleati, o di starli semplicemente a guardare mentre intessono le loro trame. Non agitiamo per il momento le armi. Inviamo ambasciatori ad Atene, presentiamo le nostre rimostranze: senza dichiarare troppo apertamente la nostra volontà di guerra, ma mostrando d'essere inflessibili. Nel frattempo badiamo a rafforzarci e a prepararci, procuriamoci alleati, tra i Greci e tra i barbari. Occorre che ci costituiamo una potenza navale e finanziaria (non è motivo di biasimo per quanti come noi, sono esposti agli attacchi di Atene, cercar l'appoggio non solo dei Greci, ma anche dei barbari, per salvarsi): frattanto sfruttiamo anche le nostre risorse. Se presteranno orecchio alle nostre missioni diplomatiche, tanto di guadagnato: in caso contrario nel giro di due o tre anni, se saremo ancora dell'avviso li attaccheremo forti di un allestimento militare più efficiente. Consideriamo inoltre che forse vedendo l'ampiezza dei nostri preparativi e confrontandola con il corrispondente tono delle nostre ambascerie saranno più invogliati a mostrarsi remissivi, mentre il loro paese sarà ancora incolume e le loro deliberazioni verteranno su fortune ancora intatte. Sappiate che per voi la loro terra è come un ostaggio, tanto più importante quanto meglio è coltivata: bisogna astenerci il più possibile dal rovinarla, per evitare che, spinti dalla disperazione, si difendano con più furiosa energia. Se, pressati dalla richiesta e dalle accuse degli alleati, ci risolveremo a devastare il loro paese, senza prepararci prima, guardate che non si abbattano sul Peloponneso, come coerente risultato, disonore e miseria. Le controversie tra gli stati e gli individui si possono sempre in qualche modo risolvere: ma se scoppia per motivi d'interessi particolari, una guerra comune, ché non è dato sapere come andrà a finire, non è facile uscirne con un pretesto onorevole.
83. "A nessuno sembri viltà la nostra esitazione, pur essendo in molti alleati, ad aggredire una città sola. Dispongono anch'essi di alleati non meno numerosi, che procurano loro fondi: la guerra non si combatte per lo più con le armi ma con il denaro, su cui si appoggiano le armi, soprattutto se è guerra di continentali contro gente di mare. Vediamo di procurarcene prima e molto: non lasciamoci trascinare in anticipo dalle proposte degli alleati. Poiché, qualunque sia l'esito della guerra, saremo noi a sopportarne le più gravi conseguenze, bisogna che le esaminiamo e le discutiamo con calma e in un certo tempo.
84. "La vostra lentezza e il vostro prender tempo, difetti che gli altri per lo più ci rimproverano, non vi siano motivo di vergogna. Agendo affrettatamente, terminereste l'impresa assai più tardi, per avervi posto mano senza i necessari preparativi. Eppure abitiamo una città libera e stimata da sempre. Dopo tutto, questo particolare del nostro carattere può ben essere interpretato come assennata prudenza. Per esso infatti noi soli non ci inebriamo nell'esaltazione dei successi e meno degli altri ci abbattiamo nelle sventure. Non può nulla su di noi il fascino dell'adulazione, se qualcuno intende eccitarci ad avventure rischiose oltre il limite che consideriamo ragionevole. Se altri ci pungola con i rimproveri, non per questo ci lasciamo indurre a una pronta adesione. Affondano nell'interiore equilibrio le radici della nostra virtù guerriera e della temperata saggezza. Eccelliamo nella prima perché essenzialmente dalla prudenza promana il senso dell'onore, il cui culto ispira il coraggio l'esser savi nelle nostre deliberazioni dipende strettamente dal sistema educativo cui siamo avvezzi, troppo essenziale e schietto per istillare nelle nostre menti l'irriverente sufficienza verso l'ordine legale, e troppo rigidamente severo per consentircene la trasgressione o il disprezzo. Senza dissipare la nostra intelligenza in vane e lambiccate sofisticherie senza spregiare gli armamenti del nemico con adorne parole tanto diverse dall'effettiva inerzia in cui, di solito, si risolvono, noi riteniamo che i disegni ostili non siano in sagacia inferiori ai nostri, perfettamente convinti che le impennate del caso non si possano imbrigliare e definire con la dialettica dei discorsi. In ogni circostanza la nostra preparazione militare obbedisce a un'idea fissa: che le forze nemiche sono altrettanto abili e preparate. Le nostre speranze di vittoria non si basano sulla convinzione che, prima o poi, l'avversario commetterà un errore: ma nella consapevolezza preventiva ed esatta dei nostri mezzi. Non differisce molto l'uomo dall'uomo: ma sempre è superiore colui che è stato educato alla più rigorosa disciplina.
85. "Non trascuriamo dunque questi fondamenti di vita, trasmessi dai padri, che abbiamo da sempre praticato con nostro vantaggio. Non decidiamo in fretta, nel giro di poche ore: si tratta di molte vite umane, della sorte di stati e di averi, del nostro prestigio. Ponderiamo bene: a noi è concesso, data la nostra potenza. Mandate messi ad Atene, che sollevino la discussione su Potidea, sui soprusi che gli alleati sostengono di subire, soprattutto ora che si dichiarano pronti a render ragioni: non è legale attaccare chi ha in sé questa disposizione, prima di chi commette un'aperta sopraffazione. Ma insieme preparate la guerra. Saran queste le decisioni più utili per voi, e più temibili per il nemico." Fu questo il contenuto del suo intervento. Si presenta da ultimo Stenelada, che era eforo in quel tempo, con queste parole rivolte agli Spartani:
86. "Non so che vogliano dire gli Ateniesi, con tutti quei loro bei discorsi: si son rivolti grandi lodi, è vero. Ma sul fatto che soverchiano illegalmente i nostri alleati che cosa han saputo ribattere? Se pure furono valorosi un tempo contro i Persiani, e con noi agiscono da scellerati, meritano un castigo doppio, perché il loro valore è degenerato in bassezza. Noi siamo immutati, adesso come allora; e se è vero che siamo prudenti non lasceremo nei guai i nostri alleati né indugeremo a soccorrerli: loro non hanno aspettato troppo a lungo la sventura. Gli altri si tengano pure i loro denari, le navi e i cavalli: a noi bastano bravi alleati, che non dobbiamo lasciare in mano agli Ateniesi. Né bisogna dirimere la questione con arbitrati e chiacchiere, dato che le loro aggressioni non avvengono certo a forza di chiacchiere. Corriamo in aiuto subito e con ogni mezzo. Nessuno ci venga a dire che dobbiamo riflettere, mentre subiamo un torto. Chi sta per commetterlo invece, conviene che ci pensi su a lungo. Votate dunque Spartani, in modo degno di Sparta: la guerra. Non consentite agli Ateniesi di farsi più potenti. Non lasciamo alla loro discrezione gli alleati; puniamo, col favore degli dei, chi li tormenta."
87. Dopo un tale discorso, mise egli stesso ai voti la questione, davanti all'assemblea spartana. Ma diceva di non poter distinguere quale acclamazione risuonasse più forte (votano infatti per acclamazione, non con il sassolino). Desiderando che col manifestare in modo più tangibile la loro opinione si eccitassero alla guerra, propose: "Chi di voi, Spartani, pensa che i patti siano rotti e la colpa ricada su Atene, si collochi da questa parte", e mostrava un settore dell'assemblea. "Chi è d'idea contraria da quest'altra". Alzatisi, si divisero e furono molti di più quelli che ritenevano interrotta la tregua. Fatti venire gli alleati rivelarono il responso dell'assemblea: gli Ateniesi erano colpevoli. Desideravano però invitare al voto tutti gli appartenenti alla lega, affinché, se la decisione fosse stata in questo senso, sollevassero una guerra comune. Acquisito questo risultato, gli alleati tornarono in patria e la missione ateniese si trattenne fino a espletare gli affari per cui era stata inviata. Questa deliberazione dell'assemblea, che cioè i patti dovevano considerarsi sciolti, è avvenuta nel quattordicesimo anno del trattato trentennale, stipulato dopo i fatti dell'Eubea.
88. La votazione spartana sui patti da considerarsi sciolti e sulla guerra da intraprendere, non è scaturita dall'opera di convinzione degli alleati, quanto dall'apprensione suscitata dalla potenza ateniese, in costante sviluppo. Vedevano infatti che Atene aveva le mani sulla maggior parte della Grecia.
89. Esporrò ora le circostanze che hanno preceduto e favorito l'avvento della potenza ateniese. Disfatti sul mare e nelle battaglie di fanteria, i Persiani si erano ritirati dalla Grecia; quanti di loro avevano cercato la salvezza dirigendo con la flotta a Micale, erano stati distrutti. Leotichida, re Spartano, che a Micale aveva avuto il comando sui Greci, fece ritorno in patria con gli alleati del Peloponneso. Gli Ateniesi invece e gli alleati della Ionia, e dell'Ellesponto che s'erano già ribellati al Re, proseguivano la lotta con l'assedio di Sesto, ancora in mano persiana. Svernarono laggiù e presero la città quando lo straniero l'abbandonò loro, facendo vela immediatamente dopo ciascuno verso le proprie sedi. Gli abitanti di Atene, dopo che l'invasore ebbe lasciato finalmente libero il loro paese, si dedicavano subito a ricondurvi i figli e le donne, dal luogo in cui li avevano posti in salvo, e a trasportarvi le suppellettili sottratte alla rovina. E si preparavano a far risorgere la città con le sue mura, la cui cerchia restava ancora in piedi per tratti brevissimi. Le case erano rase al suolo, quasi tutte: poche erano intatte, quelle in cui si erano sistemati i notabili persiani.
90. Gli Spartani, avuto sentore di ciò che gli Ateniesi avevano in animo di fare, inviarono messi. Vedevano di buon occhio che né Atene né alcun'altra città possedesse mura a difesa; gli alleati poi li incitavano in questo senso, temendo la potenza navale degli ateniesi, che in effetti prima non esisteva, e lo slancio guerresco di cui avevano fornito prova nella guerra persiana. Da Sparta si esigeva che Atene non elevasse mura: anzi, che collaborasse a demolire quelle che ancora cingevano le città esterne al Peloponneso. Naturalmente, i diplomatici spartani non svelavano agli Ateniesi il reale desiderio, misto a una sospettosa diffidenza, che il loro piano celava. Il pretesto era di sottrarre al barbaro, nel caso di un nuovo assalto, la possibilità di occupare teste di ponte fortificate, da cui muovere: come proprio di recente era accaduto, con Tebe. La giustificazione era che il Peloponneso costituiva un'area difensiva abbastanza ampia per tutti, e una base sufficiente per le operazioni di guerra. Ma gli Ateniesi, consigliati da Temistocle, licenziarono in gran fretta i messi spartani con le loro proposte, ribattendo che avrebbero inviato loro un'ambasceria a trattare della questione. Temistocle propose d'inviar lui, al più presto: scegliessero con calma gli altri componenti la missione e non li facessero partire subito. Era preferibile trattenerli fin quando il muro in costruzione si fosse elevato fino all'altezza necessaria per una difesa accettabile. Dovevano collaborare tutti senza distinzione, donne e fanciulli, alla fabbrica, ricavando da qualsiasi edificio, fosse privato o pubblico, senza riguardi, i materiali che risultassero utili all'opera, anche se si rendesse indispensabile demolire la città intera. Dopo aver disposto queste istruzioni, aggiunse che al resto avrebbe pensato da sé, e si mise in cammino. A Sparta prendeva tempo, non si presentava alle autorità, interponeva pretesti e giustificazioni. Quando qualche notabile spartano gli faceva chiedere perché tanto ritardo nel presentarsi, la sua risposta era che stava attendendo i colleghi di missione, probabilmente trattenuti ad Atene da qualche affare improvviso, ma ch'era certo della loro venuta, ormai imminente: si stupiva anzi che non fossero ancora arrivati.
91. Lo ascoltavano e gli davano credito, per il sentimento d'amicizia che ispirava loro. Ma quando incominciarono a venir altri da Atene, a denunciare senz'ombra di dubbio che la città si fortificava di mura ed i lavori erano già a buon segno, non era più possibile nutrire incertezze. Le voci approdano anche a Temistocle, che li esorta a non dar troppo credito alle chiacchiere: mandino invece ad Atene uomini loro, fidati, che vedano pure con i propri occhi, e tornino a riferire notizie finalmente chiare. Così fanno: ma intanto, in gran segreto, Temistocle spedisce ad Atene un suo uomo, con l'ordine di trattenerli il più a lungo possibile senza darne l'aria, e di non rilasciarli fino al loro ritorno (lo avevano raggiunto a Sparta i colleghi, Abronico figlio di Lisicle e Aristeide, figlio di Lisimaco, con la notizia che il muro era già a un livello rispettabile). Una vaga inquietudine lo molestava, che gli Spartani non avrebbero permesso loro di rimpatriare, quando fossero stati perfettamente certi di come si evolvevano le cose. Come Temistocle aveva consigliato, gli Ateniesi trattenevano gli ambasciatori: egli, recatosi dai magistrati di Sparta, rivelava ora senza reticenze che la sua città era protetta da una cerchia di mura, sufficiente alla difesa di tutti gli abitanti. Se gli Spartani o gli alleati volevano mandar loro ambasciatori, tenessero conto che avrebbero trattato con gente ben decisa a riconoscer distinti in futuro gli interessi propri da quelli comuni dei Greci. Quando s'eran risolti ad abbandonar la città e ad imbarcarsi, la decisione era sorta spontanea, e non ci fu nessun bisogno del consiglio spartano per osare. Inoltre, in ogni deliberazione concepita in accordo con loro, non erano mai risultati meno valenti in accortezza politica. In questo momento, ritenevano più sicuro per la propria città possedere una cinta murale, che più avanti avrebbe certo mostrato la propria utilità non solo per i cittadini d'Atene ma per tutti i loro alleati. Non era concepibile infatti di risolversi in futuro a qualche impresa comune, cui tutti partecipassero in condizioni di assoluta parità, se non si disponeva, fin dal principio, di potenziali bellici equivalenti. O entravano nell'ordine di idee che tutti gli alleati fossero sguarniti di difese murali, o accettavano di buon animo la nuova situazione, convinti della sua giustezza.
92. Gli Spartani stanno a sentire questo discorso senza dimostrare un'aperta animosità verso gli Ateniesi (scopo ufficiale delle loro ambascerie non era infatti di frapporre ostacoli alla costruzione delle mura, ma di consigliarli in amicizia dichiaravano, soprattutto allora che i loro rapporti erano ottimi, in virtù della decisione con cui Atene aveva fronteggiato lo straniero). Ma copertamente erano gonfi di livore per aver fallito nel loro disegno. Senza ulteriori proteste le due missioni tornarono in patria.
93. In questo modo gli Ateniesi si erano fortificati di mura in brevissimo tempo. È ancor oggi evidente che la costruzione è stata condotta in gran fretta. Le fondamenta infatti e le parti inferiori poggiano su strati di pietre grezze, di ogni forma talvolta neppure levigate per adattarle, ma disposte l'una accanto all'altra, come via via le venivano gettando. Sono state giustapposte perfino stele tombali e lastre, già lavorate per destinazioni diverse. Il perimetro della cerchia è stato ampliato ovunque oltre i confini precedenti della città e perciò devono aver ammassato ogni specie di materiale, nella febbre di concludere in fretta. Fu Temistocle ad esortarli a completare anche le opere difensive del Pireo (vi s'era posto mano già prima, nell'anno del suo arcontato). Riteneva adatta quella località, che disponeva di tre ripari naturali, ed era convinto che lo sviluppo d'Atene sul mare sarebbe stato di fondamentale importanza per la crescita della sua potenza politica (fu sua infatti l'originale audacia di proporre il mare come campo d'espansione per il futuro d'Atene) e collaborò subito a gettarne le fondamenta. Seguendo il suo piano, sorsero le mura, di cui ancor oggi è dato rilevare la larghezza, intorno al Pireo: due carri potevano trasportarvi il loro carico di massi, incrociandosi per poi procedere in direzioni opposte. L'interno non consisteva di ghiaia o di argilla, ma di enormi pietre squadrate e regolarmente giustapposte, connesse salde da ganci di ferro all'esterno e da piombo fuso nelle fessure. L'altezza fu elevata fino a metà dell'originario progetto. Era desiderio di Temistocle di contrapporre agli eventuali attacchi del nemico l'altezza imponente e lo spessore del baluardo. Riteneva che sarebbe così bastata la guardia di un gruppo ristretto d'uomini, i meno validi. Gli altri avrebbero preso posto sulle navi. Il suo pensiero era costantemente incentrato sulla flotta: era convinto, a mio parere, che un'eventuale armata del Re avrebbe più facilmente aggredito dal mare che da terra. Perciò considerava il Pireo più utile e sicuro della città alta e andava spesso proponendo ai suoi concittadini questo consiglio; nel caso di un attacco dal continente, si trasferissero giù nel Pireo e contrastassero qualunque nemico con la flotta. Così Atene si armò di fortificazioni e mise a punto gli altri dispositivi di difesa, dopo la ritirata dei Persiani.
94. Pausania, figlio di Cleombroto, era partito da Sparta per assumere il comando delle forze greche con venti navi del Peloponneso. Le affiancavano trenta navi ateniesi e un numero consistente di alleati. La spedizione era rivolta contro Cipro e gran parte dell'isola fu sottomessa. Si diressero poi verso Bisanzio, ancora possesso persiano, e vi posero l'assedio, agli ordini di Pausania.
95. La condotta prepotente di quest'uomo aveva già suscitato non lieve malumore negli altri Greci ma soprattutto negli Ioni e in quelli che si erano da poco affrancati dal dominio del Re. Presero quindi ad insistere con gli Ateniesi, affinché assumessero loro il comando, per i vincoli di stirpe che li univano, e non permettessero a Pausania di accanirsi in quel modo su di loro. Gli Ateniesi si mostrarono ben disposti a dar loro soddisfazione, lasciando intendere che non avrebbero tollerato nessun atteggiamento prevaricatore. Quanto al resto, avrebbero disposto nel senso a loro più vantaggioso. Quand'ecco, gli Spartani richiamano Pausania per interrogarlo sui fatti di cui è giunta voce. Sono molte e pesanti le critiche sollevate dai Greci che di tanto in tanto giungono a Sparta, sui suoi arbitri e illegalità. L'esercizio del suo comando ha piuttosto l'aria di modellarsi sulla tirannide. La citazione in tribunale lo raggiunge proprio nel momento in cui gli alleati, tranne le truppe del Peloponneso, passano agli Ateniesi, per l'odiosità che ispirava. A Sparta, fu ritenuto colpevole di certe irregolarità a danno di privati, ma sciolto dalle più gravi accuse: era principalmente imputato di sospetta inclinazione verso la Persia e, pareva, senza ombra di dubbio. Comunque, non è più proposto capo delle spedizioni armate. Sparta manda Dorchis, e altri colleghi di carica, con un ristretto contingente. Ma neppure a costoro gli alleati commisero più il supremo comando. Intuito il clima che li circondava, tornarono a Sparta, che in seguito non inviò più altri comandanti, nel dubbio che, fuori del suo controllo, degenerassero, come insegnava l'esperienza patita con Pausania. Gli Spartani volevano anche chiudere con la guerra persiana: riconoscevano agli Ateniesi, legati in quel momento da rapporti d'amicizia con loro, le doti di comando atte a perfezionare l'impresa.
96. Accettato in tal modo il comando che le forze alleate, avverse a Pausania, avevano loro spontaneamente offerto gli Ateniesi disposero l'entità delle quote in denari o armamenti navali, con cui ogni città doveva singolarmente contribuire alla comune lotta contro lo straniero. Fine dichiarato era quello di dar corpo a una lega che, devastando i paesi del Re, vendicasse le sofferenze patite. S'istituì per la prima volta allora, con sede in Atene, la carica di Ellenotami, con l'ufficio di esigere il "contributo" (si definì così il versamento contributivo in denaro, cui erano tenuti gli alleati). Il primo "contributo" fu fissato in quattrocentosessanta talenti. La tesoreria della lega era situata a Delo e le assemblee si radunavano nel sacro recinto.
97. Egemoni di una lega alleata, in cui vigeva dapprima l'indipendenza dei singoli membri, e l'uso di deliberare in assemblee plenarie, gli Ateniesi conseguirono una serie di progressivi successi militari, diplomatici e, più ampiamente, politici, nell'intervallo di tempo tra questa guerra e quella persiana, impegnati nella lotta contro il barbaro, contro gli alleati che manifestassero disegni di defezione e contro le città del Peloponneso che, di volta in volta, trovassero come ostacolo sulla loro strada. Ho descritto queste imprese aprendo una digressione nell'esporre la mia storia, in quanto tutti coloro che prima di me si sono occupati di opere storiche hanno trascurato questo spazio di tempo, concentrandosi o sull'epoca anteriore alla guerra persiana o propriamente su quest'ultima. Solo Ellanico, nella sua "Storia dell'Attica" ha toccato di scorcio l'argomento, ma troppo in breve e senza esattezza cronologica. Nello stesso tempo, si avrà dimostrazione di come si sia venuta costituendo la signoria d'Atene.
98. Come prima impresa, gli Ateniesi agli ordini di Cimone figlio di Milziade, occuparono e ridussero in servitù Eione, un possesso persiano sullo Strimone. In seguito assoggettarono Sciro, isola dell'Egeo dimora dei Dolopi e vi collocarono una loro colonia. Intrapresero poi una guerra contro i Caristi da soli, senza l'intervento delle altre città dell'Eubea e dopo un certo tempo vennero a un accordo. Organizzarono una campagna contro i Nassi, che erano in rivolta, e li piegarono con un assedio, primo esempio di una città alleata asservita contro i trattati in vigore nella lega, seguita poi via via da altre, in tempi e circostanze diverse.
99. Tra i numerosi motivi di defezione, primeggiavano il mancato versamento del "contributo", il rifiuto di consegnare le navi e la renitenza al servizio armato, quando toccava. Gli Ateniesi procedevano con inflessibilità; perciò le loro pretese pesavano intollerabili su gente che, non avvezza e meno disposta a durar fatiche, si vedeva costretta da un'energia ferrea a subire le privazioni e le miserie di una guerra continua. Anche per altri e diversi motivi gli Ateniesi esercitavano il comando non più circondati dal consueto favore. Non partecipavano infatti in parità di condizioni alle campagne: per loro era immensamente più facile piegare i ribelli. Ma di questo stato di cose si rendevano responsabili gli alleati stessi: per la loro renitenza al servizio armato, la maggior parte di essi, per poter restare a casa, si lasciava imporre il pagamento di una somma pari in valore alle navi non corrisposte. In tal modo cresceva la potenza navale degli Ateniesi, che vi impegnavano i fondi derivati dalle varie contribuzioni, e gli alleati quando accennavano a un tentativo di rivolta, si trovavano in guerra senza preparazione né esperienza.
100. Si è svolto, dopo tali avvenimenti, lo scontro di fanteria e di navi sull'Eurimedonte, fiume della Pamfilia, di Ateniesi e alleati contro i Persiani, con la vittoria ateniese ottenuta nello stesso giorno su entrambi i fronti, sotto gli ordini di Cimone, figlio di Milziade. Catturarono e distrussero circa 200 triremi fenicie. In un tempo successivo si verificò la rivolta dei Tasi, causata da controversie attinenti certi empori commerciali dislocati sulla costa della Tracia, loro antistante, e alla miniera che possedevano. Gli Ateniesi fan vela a Taso, danno battaglia con le navi e dopo il successo effettuano uno sbarco sul territorio nemico. Circa in quel tempo inviarono sullo Strimone diecimila coloni dei loro e alleati con l'intento di colonizzare la località detta allora Nove Vie, ora Anfipoli. Occuparono Nove Vie prima possesso degli Edoni; ma avanzati in terra di Tracia furono distrutti a Drabesco Dodonica dalle forze collegate dei Traci, che interpretavano la fondazione di una colonia in quel luogo, Nove Vie, come atto di scoperta ostilità.
101. I Tasi, sbaragliati sul campo e cinti d'assedio, invocarono il soccorso spartano, pretendendo che Sparta, per provvedere alla loro difesa e vendetta invadesse l'Attica. Quelli rispondevano con promesse, segrete agli Ateniesi, ma il loro effettivo intervento fu impedito da un terremoto, in occasione del quale esplose anche la rivolta degli Iloti dei Perieci di Turia e degli Etei, che si rifugiarono a Itome. La maggior parte degli Iloti discendeva dagli antichi Messeni, ridotti schiavi in tempi lontani: perciò avevano tutti il nome di Messeni. Sparta dovette così sostenere una guerra contro quelli che si erano asserragliati in Itome, con la conseguenza che i Tasi dopo tre anni d'assedio, si arresero agli Ateniesi a condizione di demolire le loro mura e consegnare le navi. Versarono immediatamente la dovuta imposta, con l'impegno di contribuire in modo regolare per il futuro. Persero i possessi del continente e la miniera.
102. La guerra contro i rivoltosi chiusi in Itone si trascinava per le lunghe, finché Sparta decise di chiedere man forte agli alleati tra cui agli Ateniesi, che si presentarono con un esercito numeroso, agli ordini di Cimone. Il loro aiuto era il più richiesto, poiché avevano fama di esperti ed abilissimi nelle operazioni di assedio, ma essendosi questo, intorno a Itome, protratto già a lungo, il loro vanto parve impari alle effettive qualità militari: altrimenti avrebbero conquistato la rocca d'impeto. Emerse drammaticamente per la prima volta in occasione di questa campagna l'attrito tra Spartani e Ateniesi. La tenacia della piazzaforte, imprendibile di slancio e la molesta diffidenza istillata dalla sciolta audacia del carattere degli Ateniesi e dalla loro sovversiva inclinazione alle novità (mista al netto sentimento di appartenere a stirpi diverse) suscitavano non lieve inquietudine negli Spartani. Li tormentava il timore che protraendo l'assedio, il contatto con i ribelli di Itome ispirasse agli Ateniesi chissà che eversiva e rivoluzionaria macchinazione. Perciò idearono di rinunciare al loro aiuto, e di contare su tutti gli altri alleati. Naturalmente non rivelarono il sospetto che li agitava, limitandosi ad osservare che il loro appoggio era divenuto superfluo. Gli Ateniesi intuirono immediatamente che quello era un puro pretesto, neppure il più abile, per allontanarli. Certo doveva esser sorto qualche diverso e non dichiarato motivo di diffidenza nei propri riguardi: ne concepirono una sdegnata amarezza, convinti nell'intimo di non meritare una offesa tanto bruciante da quelli di Sparta. Al loro ritorno in Atene seguì l'immediato scioglimento del patto difensivo attuato con Sparta contro i Persiani, e la creazione di una nuova sfera d'intese politico militari con gli Argivi, i nemici più accaniti di Sparta, e contemporaneamente con i Tessali: un blocco di alleanze sancito da giuramenti comuni.
103. In Itome si resisteva da dieci anni, finché, non potendo più reggere lo sforzo della difesa, i ribelli scesero a trattare con gli Spartani, ottenendo di partire, sotto garanzia d'incolumità, dal Peloponneso, a patto di non tentarvi mai più il ritorno. Chi di loro fosse sorpreso in quella terra, sarebbe stato schiavo di chi l'avesse arrestato. Ancor prima della guerra un vaticinio di Apollo Pizio aveva ingiunto agli Spartani che presso di loro fosse sempre lasciato andare chi si fosse appellato supplice a Zeus di Itome. Uscirono dunque dalla fortezza e da quel paese con i figli e le donne: furono accolti dagli Ateniesi che, pieni di rancore contro gli Spartani, li collocarono come coloni a Naupatto, un'isola che avevano recentemente occupato, un antico possesso dei Locri Ozoli. Anche quelli di Megara cercarono l'appoggio dell'alleanza ateniese, dopo essersi staccati da Sparta, in quanto i Corinzi li tenevano impegnati in una lunga guerra per questioni di confine. Così gli Ateniesi s'impossessarono di Megara e di Peghe, elevarono in difesa dei Megaresi le lunghe mura che collegano la città al porto di Nisea, guarnendole con proprie scorte armate. L'accanita avversione che divise poi sempre Ateniesi e Corinzi, deve essenzialmente a questo fatto la sua prima origine.
104. In quel tempo Inaro figlio di Psammetico, di razza libica, signore dei Libici che confinano con l'Egitto, partendo da Marea, la città soprastante Faro, istigò la maggior parte dei centri d'Egitto a sollevarsi contro il re Artaserse, e divenuto lui stesso re sollecitò l'appoggio degli Ateniesi. Costoro (si trovavano sulla rotta per Cipro, con duecento navi da guerra, tra le loro e quelle degli alleati) accorsero, trascurando l'impresa di Cipro. Entrarono con la flotta nel Nilo, lo risalirono e ne sottoposero a controllo il corso, occuparono i due terzi della città di Menfi e sferrarono un attacco a quell'ultimo settore urbano che ha nome Mura Bianche, dove si erano ritirati i Medi e i Persiani che avevano trovato salvezza nella fuga e quanti tra gli Egizi non avevano aderito all'insurrezione.
105. Intanto un gruppo di soldati ateniesi, sbarcato ad Alie, si scontrò con Corinzi ed Epidauri, uscendone disfatto. Tempo dopo gli Ateniesi attaccarono una squadra di navi del Peloponneso nelle acque di Cecrifalea e la sconfissero. Esplose poi una guerra tra Egina ed Atene ed ebbe luogo un ingente scontro navale nel mare di Egina. I belligeranti erano affiancati dai rispettivi alleati. La vittoria fu degli Ateniesi con la cattura di settanta navi. Segui uno sbarco in territorio nemico e un assedio, condotto da Leocrate figlio di Strebo. Poco tempo intercorse e i Peloponnesi, impegnatisi alla vendetta e alla difesa di Egina, mobilitarono trecento opliti, già truppe ausiliarie dei Corinzi e degli Epidauri, trasportandoli sull'isola. Nel frattempo i Corinzi con gli alleati avevano occupato la catena montagnosa di Gerania e di lì erano calati nella Megaride, calcolando che sarebbe riuscito impossibile agii Ateniesi accorrere alla difesa di Megara, poiché molte delle loro milizie erano dislocate parte ad Egina, parte in Egitto. La loro speranza era anche che, quand'anche spedissero forze in soccorso, dovessero togliersi da Egina. Ma gli Ateniesi non spostarono il contingente stanziato ad Egina: furono i più anziani e i più giovani, cioè quelli rimasti in città, a partire per Megara, sotto gli ordini di Mironide. La mischia con i Corinzi si risolse con un esito sostanzialmente equilibrato; i due eserciti si separarono, persuasi entrambi di non aver riportato la sconfitta in campo. Furono gli Ateniesi che, a dire il vero, avevano conseguito un nuovo vantaggio) a elevare un trofeo dato l'allontanamento delle truppe corinzie, mentre questi ultimi, tacciati di codardia dai più anziani rimasti in città, e dopo essersi riorganizzati, trascorsi circa dodici giorni, ritornarono a contrapporre a quello ateniese anche un proprio trofeo, per significare che il successo era toccato a loro. Frattanto gli Ateniesi irrompono da Megara e annientano l'esiguo gruppo di quelli che si occupavano del trofeo da erigere; si scontrano anche con gli altri, sconfiggendoli.
106. I Corinzi battuti ripiegavano. Un gruppo piuttosto consistente, cedendo alla pressione nemica, si precipita in rotta in direzione sbagliata e piomba in un terreno di proprietà privata, delimitato intorno da un fossato fondo e ampio, privo di vie d'uscita. Gli Ateniesi non tardarono a intuirlo: lo bloccarono di fronte con gli opliti e schierati intorno al fosso, a cerchio, quelli di armatura leggera, fecero lapidare fino all'ultimo i nemici incappati in quella trappola. Fu un disastro gravissimo per Corinto. Il nerbo dell'esercito riuscì tuttavia a tornare a casa.
107. Fu circa a quell'epoca, che gli Ateniesi posero mano alla costruzione delle lunghe mura, collegando la città al mare, da una parte fino al Falero, dall'altra al Pireo. Apprendendo che i Focesi avevano invaso la Doride, madrepatria degli Spartani, con obbiettivo Beo, Citinio ed Erineo, cittadine di cui avevano già occupato la prima, Sparta inviò truppe di soccorso a quelli di Doride, agli ordini di Nicodemo figlio di Cleombroto, che sostituiva il re Pausania, figlio di Plistoanatte, ancor troppo giovane: si mossero millecinquecento opliti dei loro e diecimila alleati. Costrinsero in breve i Focesi alla resa e alla restituzione della città. Concluse le operazioni decisero il rientro in patria. Non era facile: la flotta ateniese, che aveva effettuato il periplo del Peloponneso, stazionava nel golfo Criseo, pronta a bloccarli se avessero tentato la traversata in quel tratto di mare. Anche il ritorno via terra, attraverso le alture Geranie, non pareva cammino esente da rischi, con gli Ateniesi che presidiavano Megara e Peghe. Era tra l'altro una strada dirupata, quasi impraticabile, guardata in permanenza da postazioni ateniesi, e s'era sparsa la notizia che anche per quella parte gli Ateniesi si preparavano a ostacolarli. Non rimaneva pertanto che temporeggiare in Beozia, vagliando accuratamente le prospettive di ritorno che presentassero meno gravi pericoli. Non mancarono perfino uomini d'Atene che, con trattative segretissime, li incitavano a dirigersi da loro: avevano speranze di soffocare il partito democratico e far sospendere l'erezione delle lunghe mura. Si presentarono ad affrontarli a un tratto gli Ateniesi al completo, con mille Argivi e con i singoli effettivi provenienti da ciascun paese della lega: si ritrovarono in campo quattordicimila uomini. Li animava la certezza che il nemico si dibattesse in gravi difficoltà, non avendo via d'uscita: per questo, e per la diffusa impressione che qualche complotto si stesse tramando per rovesciare la democrazia scatenarono l'attacco. Si posero a disposizione degli Ateniesi anche i cavalieri Tessali, secondo il testo dell'alleanza, ma passarono al nemico appena s'accese lo scontro.
108. La battaglia divampò in località Tanagra, in Beozia: la vittoria tocca a Sparta e ai suoi, ma le perdite sono ingenti sui due fronti. Gli Spartani si misero subito in marcia per la Megaride, ne raggiunsero e devastarono il territorio, rientrarono in patria per le alture della Gerania e attraverso l'istmo. A sessantadue giorni dalla battaglia, gli Ateniesi con lo stratego Mironide aggredirono i Beoti e sconfittili presso Enofita dilagarono per la Beozia e la Focide, fecero demolire le muraglie a difesa di Tanagra, intimarono ai Locri Opunzi l'immediata consegna di cento ostaggi scelti tra i concittadini più facoltosi. Perfezionarono in quel tempo la fabbrica delle lunghe mura. Non molto dopo questi fatti anche quelli di Egina cedettero agli Ateniesi: subirono l'abbattimento del loro muro, la consegna delle navi, l'imposizione di un tributo da versare in seguito per sempre. Compivano frattanto gli Ateniesi il periplo del Peloponneso, sotto il comando di Tolmide, figlio di Tolmeo. Riuscirono a incendiare l'arsenale spartano, a occupare Calcide, un centro corinzio, a piegare i Sicioni in uno scontro, seguito a uno sbarco sulla loro terra.
109. Gli Ateniesi e gli altri della lega, impegnati in Egitto, vi si trattenevano già da gran tempo protagonisti di alterne vicende di guerra. In una prima fase, gli Ateniesi erano riusciti a impadronirsi dell'intera estensione dell'Egitto, quando il re mandò a Sparta un persiano, tale Megabazo, fornendolo di risorse finanziarie ingenti con l'intento di indurre i Peloponnesi a invadere l'Attica, e la conseguente speranza che gli Ateniesi fossero costretti a sgomberare dall'Egitto. Missione improduttiva la sua, con il denaro che s'involava per vie traverse, senza effetto: sicché Megabazo, con l'oro che gli restava, rimpatriò. Al posto suo e dell'oro, il re spedisce Megabizo, figlio di Zopiro, e un esercito potente. Al suo arrivo costui annientò gli Egizi e gli alleati in una battaglia terrestre: strappò da Menfi i Greci e li incalzò fino a bloccarli sull'isola Prosopitide, e ve li tenne assediati per un anno e sei mesi. Alla fine, prosciugando il canale con la deviazione delle sue acque, ridusse in secca le navi ateniesi e, congiunta al continente la maggior parte dell'isola, vi condusse le sue milizie e la prese.
110. Dopo sei anni di lotta le forze greche patirono quella rovinosa disfatta: furono pochi, dei molti ch'erano partiti, a trovare salvezza a Cirene, attraverso la Libia. I più erano caduti. L'intero Egitto tornò sotto il dominio del re, tranne Amirteo, che signoreggiava ancora sulle paludi, intorno al corso inferiore del Nilo. Le milizie del re, non erano in grado di occupare questa che è la zona più ampia del paese e che ospita gli abitanti della palude, i più accaniti combattenti d'Egitto. Il signore di Libia, Inaro, autore del complesso moto insurrezionale in Egitto, catturato con il tradimento, fu ucciso con il supplizio del palo. Intanto, cinquanta triremi ateniesi e di altri alleati, che recavano truppe fresche in Egitto, approdarono alla foce di Mendes, completamente ignare degli ultimi sviluppi. Da terra si scagliarono su di loro le fanterie nemiche, dal mare un contingente di Fenici distrusse la maggior parte della flotta; il resto, un minimo numero di navi, si volse in fuga, a precipizio, sulla via del ritorno. Fu questa la conclusione dell'imponente sforzo bellico che gli Ateniesi e i loro alleati avevano prodotto in terra egizia.
111. Oreste, figlio del re tessalo Echecrate, tentò d'indurre Atene a rimpatriarlo. Mobilitate le milizie beote e focesi, allora alleate, gli Ateniesi marciarono su Farsalo, città tessala. Presero a occupare il territorio, senza tuttavia allontanarsi troppo dall'accampamento, poiché i cavalieri tessali lo impedivano. Ma non riuscirono a conquistare la città, né a conseguire qualcuno degli obiettivi in vista dei quali avevano organizzato la spedizione. Dovettero rimpatriare, con Oreste e a mani vuote. Non passò molto tempo e mille ateniesi, equipaggiate le navi all'ancora presso Peghe, (la base era ancora in mano agli Ateniesi), sfilarono lungo la costa, fino a Sicione, al comando di Pericle, figlio di Santippo..Effettuarono uno sbarco e quelli di Sicione, che tentavano di opporsi, furono battuti in uno scontro. Mobilitarono in fretta, subito dopo, gli Achei e attraversato con loro il braccio di mare che li separa dall'Acarnania si diressero a Eniade, la assediarono, ma senza successo. Seguì subito il rientro in patria.
112. Trascorrono tre anni da questi fatti d'armi, e tra Ateniesi e Peloponnesi si stipula un patto quinquennale. L'asse degli interessi militari ateniesi si spostò quindi dalla Grecia, orientandosi su Cipro. Cimone, con una flotta di duecento navi ateniesi e alleate, assunse il comando della nuova impresa. Sessanta navi furono però dirottate in Egitto, su richiesta di Amirteo, che regnava ancora sulle paludi; le altre si accingevano al blocco di Cizio. La morte di Cimone e l'imperversare di una carestia li indussero a ripiegare da Cizio. Incrociando nelle acque di Salamina Cipria, vennero a contatto con forze fenicie ciprie e cilicie, impegnandole in mare e in uno scontro terrestre. Vinsero sui due fronti e ripresero la rotta verso la patria: erano con loro anche le navi reduci dalla diversione in Egitto. Nel periodo successivo a questo gli Spartani intrapresero la guerra cosiddetta sacra. Si impadronirono del santuario di Delfi e lo riconsegnarono agli abitanti del paese. Non impiegarono gran tempo gli Ateniesi, dopo la loro partenza, a comparire con un esercito, riprendere il santuario e riconsegnarlo ai Focesi.
113. Poco dopo gli ultimi avvenimenti narrati i fuoriusciti Beoti che tenevano Orcomeno, Cheronea, e qualche altra piazzaforte della regione, subirono l'urto di mille opliti ateniesi con il rinforzo di singoli reparti alleati, agli ordini di Tolmide, figlio di Tolmeo. La conquista di Cheronea e l'asservimento dei suoi abitanti segnò l'esito di quest'impresa: in Beozia rimasero guarnigioni ateniesi. Mentre gli altri, poco fuori Cheronea, sono in marcia per rientrare, si vedono piombare addosso i profughi beoti di Orcomeno spalleggiati dai Locri, dagli esuli eubei e da quanti partecipavano con loro della stessa fede politica. L'assalto ebbe successo: il contingente ateniese fu annientato, pochi i prigionieri vivi. Gli Ateniesi lasciarono libero tutto il territorio beota, concludendo un trattato che consentiva il recupero dei loro uomini, prigionieri o caduti. I fuoriusciti beoti rimpatriarono e con tutti gli altri riacquistano l'indipendenza.
114. Non intercorse molto tempo da questi ultimi avvenimenti alla ribellione esplosa in Eubea. Pericle era già passato nell'isola con un corpo di spedizione ateniese, quando la raggiunsero preoccupanti notizie, che cioè anche Megara si era sollevata, che i Peloponnesi preparavano un'invasione in Attica, che le guarnigioni ateniesi erano state annientate da quelli di Megara, tranne i pochi che erano riusciti a trovar scampo a Nisea. I ribelli di Megara avevano sollecitato rinforzi da Corinto, Sicione, Epidauro. Pericle procedeva allora all'immediato rientro del suo esercito d'Eubea. Quasi contemporanea scattò l'invasione dell'Attica da parte dei Peloponnesi, che agli ordini di Pausania, re spartano, penetrarono fino a Eleusi e a Trio, devastando il paese. L'avanzata non si spinse oltre; rientrarono così alle basi di partenza. La circostanza si offrì propizia ad Atene per effettuare un secondo sbarco in Eubea. Con Pericle stratego l'assoggettarono intera, sistemando conformi ai loro interessi gli ordinamenti politici dei vari centri isolani, mediante trattati: solo gli Estiei furono espulsi e costretti a cedere la loro terra.
115. Dopo il rimpatrio delle forze ateniesi che avevano operato in Eubea, furono sanciti con Sparta e i suoi alleati) patti di pace trentennali, tra cui si contemplava la riconsegna di Nisea, Peghe, Trezene e l'Acaia, tutte località peloponnesiache ancora in possesso di Atene. Trascorsi cinque anni, scoppiò tra quelli di Samo e i Milesi una guerra per Priene: la sconfitta patita in campo militare dai Milesi li indusse a spedire una missione ad Atene, che esprimesse con forza le loro rimostranze contro i Sami. Vi si aggregavano anche cittadini di Samo stessa, desiderosi di rivolgimenti politici in patria. Gli Ateniesi, convinti, comparvero a Samo con quaranta navi, vi istituirono una costituzione democratica, garantendosi con cinquanta giovani presi in ostaggio e altrettanti uomini, trasportati al sicuro nell'isola di Lemno. Stabilitavi una guarnigione, gli altri rientrarono. Alcuni di Samo però, incapaci di tollerare oltre quel clima politico, esularono nel continente. Ottenuto il sostegno dei personaggi in quel momento al vertice della vita politica cittadina e l'alleanza militare di Pissutne, figlio di Istaspe, signore in quell'epoca di Sardi, raccolto un corpo di circa settecento ausiliari, una notte passarono a Samo. L'attacco al partito democratico fu la loro prima azione, con l'immediato arresto dei personaggi più considerevoli: procedettero subito dopo alla liberazione dei loro ostaggi, rinchiusi in Lemno, e alla ribellione aperta contro Atene, consegnando a Pissutne i componenti le guarnigioni e le autorità ateniesi che soggiornavano a Samo. Infine, si accingevano a una rapida preparazione della campagna contro Mileto. Si sollevarono anche quelli di Bisanzio, sul loro esempio.
116. Alla notizia, gli Ateniesi misero sulla rotta per Samo sessanta navi da guerra, tra cui però sedici fecero vela parte verso la Caria, per sorvegliare le mosse della flotta fenicia, il resto verso Chio e Lesbo, per presentare una richiesta d'aiuto. Con le altre quarantaquattro, Pericle con altri nove strateghi, impegnò in una mischia, nelle acque di Traghia, settanta navi dei Sami, tra cui venti adibite a trasporti militari (stavano tutte tornando da Mileto). La vittoria fu ateniese. Quaranta navi di rinforzo salparono subito da Atene e venticinque giunsero da Chio e da Lesbo. Dopo lo sbarco e una vittoria conseguita in uno scontro terrestre, procedevano all'assedio della città con l'erezione di mura sui tre lati di essa, e bloccando dal mare il quarto. Pericle, dalla flotta che partecipava all'assedio, prelevò sessanta navi per accorrere a tutta forza verso Cauno in Caria, da dove era giunta notizia che unità fenicie muovevano contro di loro. Infatti anche da Samo, Stesagora ed altri erano salpati con cinque navi per congiungersi con la flotta fenicia.
117. La circostanza propizia permise a quelli di Samo di operare un fulmineo assalto dal mare sulla squadra navale all'ancora, scoperta e priva di protezione. I navigli di vedetta furono subito affondati, le unità che salparono contro di loro per contrastare l'aggressione, furono travolte e vinte. Tennero quindi per quattordici giorni sotto controllo armato lo specchio di mare che si apre davanti alla loro costa permettendo così tranquillamente di esercitarvi in ogni direzione il trasporto di tutti i beni di consumo a loro necessari. Il ritorno di Pericle con la squadra ai suoi ordini permise agli Ateniesi di ripristinare un efficace blocco dal mare. Salpò poco dopo da Atene una flotta di rinforzo, costituita di quaranta navi agli ordini di Tucidide, a Agnone e Formione, venti comandate da Tlepolemo e Anticle, trenta da Chio e da Lesbo. I Sami si batterono una volta sul mare, in uno scontro di breve durata ed entità ma in nove mesi d'assedio la loro forza e la capacità di resistenza si affievolirono, finché, costretti a capitolare, accettarono le condizioni seguenti: l'abbattimento del loro muro, la consegna di ostaggi e della flotta, il risarcimento a rate delle spese belliche. Anche a quelli di Bisanzio non rimase che sottoporsi ancora al loro precedente stato di sudditi.
118. Erano trascorsi pochi anni dalle ultime vicende narrate, quando si verificarono i casi, già riferiti, di Corcira e Potidea e gli incidenti che costituirono il motivo dichiarato per lo scoppio di questa guerra. Questo complesso quadro di operazioni militari e politiche, di rapporti reciproci tra Greci e con popolazioni straniere, si estende nel periodo di cinquant'anni circa che corre tra la ritirata di Serse e l'esplosione di questa guerra. Furono anni per Atene d'intensa e fruttuosa attività espansiva con l'ampliamento e l'energica organizzazione dell'impero e un impulso vigoroso, all'interno, della sua potenza economica e militare. Gli Spartani avvertivano questa crescita pericolosa, ma non sapevano frapporvi che limiti e ostacoli di breve respiro. Preferivano in più occasioni, una politica di acquiescenza: non avevano mai avuto, neanche prima, la dote della fulmineità nel risolversi a una guerra. Occorreva in genere che vi fossero costretti, senza alternative: e in più fu un periodo difficile e inquieto per Sparta, sconvolta dalle sommosse civili. Ma alla fine la potenza d'Atene s'era imposta, rigogliosa e superba all'attenzione del mondo: perfino la sfera d'influenza e d'alleanza tradizionalmente legata a Sparta non era immune dai suoi attacchi. La situazione critica suggerì agli Spartani che la loro supina linea di condotta era ormai superata; si doveva sferrare, loro per primi, un'offensiva, gettarvi ogni energia e demolire, se fosse possibile, quella molesta e invadente potenza. Gli Spartani erano dunque giunti alla convinzione che i patti fossero stati violati e che la responsabilità ricadesse su Atene. Mandarono quindi una delegazione a Delfi, a interrogare l'oracolo, se la guerra rappresentasse per loro la scelta migliore. Corre voce che la risposta fosse concepita in questi termini: se avessero profuso nella guerra ogni sforzo, la vittoria era loro; per parte sua, il dio rivelò che li avrebbe assistiti in ogni caso, sia invocato, sia senza suppliche.
119. Ne scaturì l'ordine, per gli alleati, di una nuova convocazione: si desiderava che deponessero il loro voto sulla necessità di affrontare il conflitto. Affluirono le missioni inviate dai paesi del patto e s'adunò un consesso, in cui molti si presentarono a esporre le loro rimostranze: si trattava in genere di accuse contro Atene e di esplicite volontà di guerra. I Corinzi, dopo avere in precedenza avanzato passi non ufficiali verso le altre delegazioni per sollecitarle a votare la guerra (erano in ansia per Potidea, temevano che la situazione laggiù degenerasse, prima di una positiva conclusione dell'assemblea); alla fine, comparvero davanti a tutti e tennero questo discorso:
120. "Sarebbe ormai fuori luogo, o alleati, che noi imputassimo agli Spartani di non aver essi stessi deliberato la guerra e di averci invece qui tutti riuniti per discutere e decidere su questo problema. Ed è giusto: giacché è dovere delle potenze dominanti amministrare con particolare scrupolo e prudenza i comuni interessi dei paesi inclusi nelle loro orbite politiche, oltre naturalmente ai propri, con principi di equità. Onde si giustifica il superiore e generale prestigio di cui godono nelle altre circostanze. Chi di voi ha già sperimentato qualche rapporto con Atene non ha bisogno di particolari avvertimenti, perché ne stia in guardia. I paesi dell'entroterra piuttosto e quanti non abitano le zone costiere devono fermamente convincersi che se non collaborano alla difesa delle città marine diverrà per loro difficoltoso usufruire di comodi e sicuri nodi di smercio delle derrate agricole e dei prodotti affluenti dal mare e diretti all'interno. Non valutino le questioni qui trattate con superficialità distratta convinti che non concernano intimamente i loro interessi. Accolgano quest'idea, questa eventualità: se lasciano al loro destino i centri costieri, il pericolo potrebbe minacciare anche loro, un giorno. Nella assemblea attualmente riunita, il loro voto riguarda sé stessi, non meno che gli altri. Nessuna esitazione dunque nell'abbandonare la pace per la guerra. Gli uomini ragionevoli vivono in quiete, se nessuno fa loro un torto: ma chi è forte prende subito le armi, se offeso, pronto, all'occasione favorevole, a interrompere le ostilità e intavolare trattative. Resta immune dalla eccitazione che i successi militari ispirano. Si ribella all'oltraggio e accantona l'amabile serenità di un'esistenza in pace. Pericoloso ed effimero incanto, per chi se ne lascia sedurre e rinuncia all'azione. Se coltiva placidamente l'inerzia che tanto l'allieta e che gli fa balenare così remota la necessità di combattere rapidamente essa gli sarà strappata. Ma anche chi concepisce per qualche felice episodio di guerra un insensato ardimento, non pondera da che fragile e temeraria illusione si slancia il suo volo di speranze. Giacché spesso difettosi e deboli progetti s'imbattono in avversari ancor più sventati, e riescono compiutamente: non meno infrequenti i casi di consigli ritenuti ottimi, dimostratisi in pratica disastrosi e fonte di discredito. Concepire un disegno e proseguirne con intatta fiducia l'attuazione, è impresa impossibile. Un senso di sicurezza pervade i momenti dell'ideazione, ma nella fase esecutiva di un piano, un accorato sgomento ci coglie per via e ci frena.
121. "La nostra volontà di guerra scaturisce da un'ingiuria patita e da ragioni ben valide di risentimento. Ottenuta la punizione di Atene, cesseremo le ostilità, nel tempo opportuno. Molti elementi concorreranno alla vittoria finale, come si può prevedere. Principalmente dominiamo il nemico per numero di combattenti ed esperienza bellica; poi, la nostra azione offensiva è un disciplinato e concorde impeto, appena si riceve il comando. Quanto alla marina, considerata loro punto di forza, si provvederà attingendo in parte alle disponibilità di ciascuno e in parte ai tesori custoditi in Delfi e in Olimpia: prestito che ci consentirà ai sottrarre agli Ateniesi, con l'offerta di una mercede più sostanziosa, i loro equipaggi formati da forestieri. Il nerbo della loro flotta militare è mercenario, non cittadino. Il nostro esercito subirà in misura minore questo rischio, poiché trae la sua forza dagli uomini, non dal denaro. Una sola vittoria sul mare ci basterà: saranno perduti. Se dovessero resistere, ci eserciteremo anche noi a lungo nell'arte di combattere sulle navi. Quando avremo conseguito una eguale perizia, li schiacceremo sotto un'altra superiorità: quella del coraggio. Virtù che la natura stessa ci istilla alla nascita e che nessun insegnamento potrà loro fornire. Noi invece possiamo annullare, con l'allenamento, lo svantaggio che ci separa dal loro livello di destrezza tecnica. Procureremo noi i mezzi economici indispensabili a questo scopo. Sarebbe un'infamia se, mentre i loro alleati non ricuseranno di versare quei tributi che servono a mantenere e rafforzare i loro ceppi, noi non vorremo sostenere le spese per la vendetta sul nemico e per la nostra stessa libera sopravvivenza, e per difenderci, quando ci aggrediranno per spogliarci dei nostri beni, di cui poi disporrebbero per alimentare la guerra e per distruggerci.
122. "Ci si prospettano anche diversi metodi di guerra: far sollevare gli stati della loro lega (sarebbe il blocco più efficace delle entrate, fonte essenziale della loro potenza); piazzare fortilizi nell'Attica e altri dispositivi di lotta che sarebbe difficile qui anticipare. Il corso della guerra non si incanala in leggi immobili; per lo più possiede regole proprie, secondo le quali s'evolve, e che occorre opportunamente sfruttare, al variare delle contingenze. Principale norma è che chi vi s'accinge con fredda determinazione procede più sicuro. Il furore conduce a precipizio nelle catastrofi più rovinose. Riflettiamo: le singole divergenze che possono opporre ciascuno di noi ai suoi avversari, questioni di confini e simili, appaiono, nel loro complesso, un tollerabile fenomeno della convivenza tra stati. Ora, gli Ateniesi posseggono forze in campo bastanti non solo a contrastarci in massa, ma, evidentemente, a dominare ogni nostra città, di per sé considerata. Quindi, se non li affronteremo in un saldo blocco, nazione con nazione, città con città, forti di un deciso e unico volere, faranno leva sulla nostra, divisione e ci soggiogheranno uno per uno, senza sforzo. La sconfitta produrrà un asservimento certo e immediato: realtà dolorosa! Il cui timore, anche se solo espresso a parole, disonora il Peloponneso: che un tal numero di città sia sopraffatto da una sola! Circostanza che, se si verificasse, dimostrerebbe che la nostra ignominia è meritata, o che stiamo soggetti per codardia, indegni dei nostri padri, che procurarono alla Grecia la libertà: un valore che ormai non siamo più in grado di difendere. Permettiamo che una città affermi la sua tirannide, mentre mostriamo la volontà d'abbattere i despoti, in qualunque paese si trovino. Non sapremmo come difendere questa linea politica, dimostrarla esente dalle tre più disastrose aberrazioni: il rozzo ingegno, la fiacchezza, l'incuria. Giacché, proprio per non aver evitato questi errori vi siete ridotti a quello sdegno sprezzante del nemico che ha già amaramente punito moltissimi, e che dall'illusione ingannevole con cui persiste nell'irretire le sue innumerevoli vittime ha cangiato il suo in un nuovo e tristo nome: follia.
123. "È vano recriminare sui fatti passati, più di quanto sia utile alla situazione attuale. Occorre invece provvedere alle esigenze del presente, mirando al futuro, senza risparmio di energie e fatiche; (è una vostra virtù tradizionale d'uscire sempre più rinfrancati dai pericoli). Non rinnegate la vostra dirittura morale, se oggi potete contare su una certa superiorità di ricchezza e di mezzi; (non è giusto che dissipiate nel momento d'attuale abbondanza le fortune accumulate durante il periodo di povertà). Avete molti motivi di fiducia per approntare la guerra: il favorevole vaticinio del Dio e la sua promessa d'appoggio. Tutta la Grecia si prepara allo sforzo comune: alcuni paesi per timore altri sperando un guadagno. Non sarete voi a violare i patti per primi: il Dio stesso, con il suo monito a battervi fa intendere che li considera oltraggiati. Voi piuttosto accorrete a tutela di quei patti offesi. Il trattato è sciolto non da chi si difende, ma chi aggredisce per primo.
124. "Da ogni lato la guerra si presenta per voi sotto felici prospettive. Vi esortiamo quindi a dichiararla, con il pensiero ai comuni vantaggi: poiché è dimostrato che l'identità di interessi è la diretti va politica più sicura per gli stati e gli individui. Non ritardate l'aiuto a Potidea: è una città dorica assediata da Ioni. Accadeva il contrario nei tempi andati. Restituite l'indipendenza agli altri Greci. Non è più possibile temporeggiare: alcuni di noi già soffrono il giogo, altri non aspetteranno a lungo una sorte altrettanto indecorosa. Giacché si saprà che ci siamo adunati, ma non abbiamo l'ardire di organizzare una difesa. Pensate che la necessità incombe, alleati; riflettete: questo è il più proficuo consiglio, votate la guerra, senza pensare al rischio immediato, ma aspirando alla pace più certa e duratura che ne deriverà. Dalla guerra sorge una pace più ferma. Ma il non voler passare dalla pace alla guerra non è altrettanto privo di pericoli. Sia questo il vostro pensiero: la città che ha imposto la sua tirannide in Grecia, minaccia egualmente l'indipendenza di tutti. Su alcuni già domina, altri progetta d'asservire. Attacchiamo questa città e soggioghiamola: non solo la nostra esistenza futura scorrerà senza pericoli, ma anche renderemo liberi i Greci già servi." Con queste parole si concluse l'intervento dei Corinzi.
125. Gli Spartani completarono così l'ascolto di tutte le opinioni, e fecero votare per ordine tutti gli alleati presenti, gli stati maggiori e i minori: la maggioranza decise la guerra. Non era possibile tuttavia tradurre immediatamente in pratica la deliberazione: non erano preparati a sufficienza, perciò decisero che ogni singolo paese contribuisse alla fornitura di quanto era necessario, senza perdite di tempo. Impiegarono poco meno di un anno ad allestire i preparativi indispensabili: seguì l'invasione dell'Attica e l'inizio aperto delle ostilità. Intanto, in quell'anno, giungevano frequenti le loro ambascerie in Atene, in genere con lagnanze e critiche da notificare, con lo scopo, qualora Atene non le considerasse degne, di sferrare l'attacco con un insieme di motivazioni più nutrito e solido.
126. La prima missione spartana intimò agli Ateniesi di espellere, in espiazione, gli autori del sacrilegio contro la Dea. Il sacrilegio di cui parlavano era stato così commesso. Cilone era un cittadino ateniese, vincitore di un'Olimpiade, nobile per discendenza antica e politicamente influente. Aveva preso in moglie la figlia di Teagene, un Megarese che in quegli anni reggeva la tirannia su Megara. Un giorno, Cilone interpellò l'oracolo di Apollo a Delfi: il dio profetò che nella più fausta festività di Zeus Cilone avrebbe occupato l'acropoli d'Atene. Cilone si fece consegnare da Teagene un nerbo d'armati e persuase alcuni amici a seguirlo. Quando giunse il tempo delle feste Olimpiche, che si celebrano nel Peloponneso, occupò l'acropoli con un colpo di mano, intenzionato a stabilirvi la tirannide. Aveva interpretato quella come la solennità più importante dedicata a Zeus e vi aveva perfino intravisto una certa relazione con la sua persona, perché aveva conseguito una vittoria proprio ad Olimpia. Se però la festa in questione dovesse essere la più importante di quelle celebrate in Attica, o in qualche altra parte di Grecia, Cilone non se l'era chiesto; nemmeno dal testo del vaticinio traspariva chiaro (ad esempio in Atene esistono le feste cosiddette Dionisie, le più solenni in onore di Zeus Meilichio: vengono celebrate fuori le mura e la cittadinanza interviene al completo, porgendo in offerta non vittime di sangue, ma altri prodotti locali). Persuaso d'aver inteso esatto l'oracolo, pose mano all'impresa: al diffondersi della voce gli Ateniesi accorsero in folla dalle campagne, li circondarono sull'acropoli e si disposero all'assedio. L'affare si trascina: la fatica e la noia del lungo blocco ne distoglie quasi tutti i cittadini, che affidano, desistendo, il compito della sorveglianza ai nove arconti con pieni poteri, con la raccomandazione che dispongano tutto il necessario al miglior esito dell'impresa: era ancora il tempo in cui gli arconti espletavano la quasi totalità delle funzioni governative e politiche. L'assedio, e soprattutto la scarsità di cibo e d'acqua intaccavano pesantemente la resistenza di Cilone e dei suoi: finché Cilone e il fratello riescono a fuggire. I loro compagni, prostrati e decimati dagli stenti si trascinano supplici all'altare collocato sull'acropoli. Gli Ateniesi che vigilavano li fecero alzare, come si accorsero che stavano spirando in uno spazio consacrato, e assicurando incolumità assoluta, li trassero fuori e li giustiziarono. Giunsero ad assassinarne per via alcuni, che si erano rifugiati nel santuario delle Venerande Dee e si appigliavano ai loro altari. Queste uccisioni fecero pesare sul capo dei loro esecutori la colpa di sacrilegio e di empietà al cospetto della Dea: anche la loro famiglia condivise la colpa e l'infamia. Di conseguenza, gli Ateniesi stessi espulsero questi sacrileghi e li bandì in seguito anche Cleomene spartano, con l'appoggio d'una fazione ateniese, durante una sommossa civile. I vivi patirono l'esilio; le ossa di quelli morti nel frattempo furono dissepolte e sparse fuori del territorio attico. Ma finirono sempre col ritornare, e la loro discendenza vive ancora in città.
127. La richiesta spartana riguardava proprio l'espiazione di quell'antico sacrilegio: principalmente, diceva Sparta, per difendere la dignità santa degli dei. In realtà sapevano che Pericle, figlio di Santippo, vi era implicato per parte di madre, e prevedevano che da un eventuale bando di quell'uomo la loro politica verso Atene avrebbe avuto il corso immensamente più agevole e libero. D'altra parte non potevano certo sperare che fosse scacciato: ma un desiderio segreto li possedeva, di poterlo almeno mettere in pessima luce di fronte al pubblico credito dei suoi concittadini, istillando loro la sensazione che la guerra, in parte, sarebbe scoppiata a causa del suo stato morale d'impuro. La vita politica d'Atene aveva in quel tempo in Pericle il suo uomo di punta, il prestigioso e geniale ispiratore d'una linea d'assoluta avversione e intransigenza nei confronti di Sparta, l'esecutore di una continua pressione psicologica degli Ateniesi alla guerra.
128. In risposta, gli Ateniesi intimarono analogamente a Sparta l'espiazione del sacrilegio perpetrato nel Tenaro. Si trattava di questo: gli Spartani tempo prima, avevano invitati i supplici Iloti a togliersi dal santuario di Posidone sul Tenaro dove avevano trovato scampo. Li massacrarono sul posto appena usciti. Sono ancora convinti che il potente sisma che ha scosso Sparta sia stata la conseguenza di quel gesto nefando. Anche i responsabili del sacrilegio contro Atena Calcieca dovevano essere espulsi, secondo Atene. Ecco il fatto: Pausania, quello spartano che i concittadini avevano richiamato dall'Ellesponto, revocandogli il comando in capo di quel settore operativo, fu giudicato dai tribunali di Sparta e prosciolto. Ma non ottenne più incarichi di comando ufficiali. Si procurò privatamente una trireme di Ermione e, senza autorizzazione governativa, fece la sua comparsa sull'Ellesponto, nominalmente per appoggiare le forze greche impegnate contro la Persia, in realtà per infittire con il re quella trama di relazioni segrete che aveva già ordito all'epoca del suo comando, e tramite la quale sperava con ardore in un personale dominio sull'intera Grecia. Aveva colto l'occasione di porgere un servizio al re, principio e base di un rapporto che si sarebbe in seguito sviluppato, nella seguente circostanza. Ripiegando da Cipro, nel periodo in cui comandava le forze in Ellesponto, aveva preso Bisanzio (un possesso persiano, in cui vennero catturati alcuni parenti e famigliari del re che vi dimoravano). Concepì allora il piano di restituire queste personalità al re, senza rivelarlo agli alleati: ufficialmente si sarebbe trattato di un tentativo di fuga riuscito. Allacciò contatti tramite Gongilo di Eretria, cui affidò la città di Bisanzio e i prigionieri. Aggiunse una lettera che Gongilo avrebbe recapitato al re. Vi stavano scritte queste parole, come si appurò in seguito: "Pausania, generale di Sparta, desiderando farti cosa gradita, ti rimanda costoro, presi con la forza e le armi. Ho in animo, se la proposta è anche a te gradita, di prendere tua figlia in moglie e consegnarti in soggezione Sparta e il resto della Grecia. Mi stimo adatto e pronto all'impresa, che dirigerò secondo i tuoi consigli. Se la prospettiva sollecita il tuo interesse, manda alla costa del mare un uomo fidato, che fungerà da intermediario per la nostra corrispondenza futura."
129. Era questo il contenuto della lettera, di cui Serse si compiacque molto. Dispone subito infatti l'invio di Artabazo, figlio di Farnace, verso la costa con l'ordine di prelevare la satrapia Dascilitide, da cui aveva rimosso il precedente governatore Megabate. Ordina ad Artabazzo di raggiungere Pausania a Bisanzio e di consegnargli una missiva di risposta, al più presto, mostrandogli il sigillo reale. Se Pausania gli avesse affidato qualche incarico o mansione pertinenti gli interessi del Re, li eseguisse al meglio e con la più scrupolosa discrezione. Artabazo eseguì gli ordini con accuratezza e trasmise la lettera. Vi era stilata la seguente risposta: "Così dice Serse il Re a Pausania: per le persone che mi hai inviate incolumi da oltre mare, da Bisanzio, durerà perenne, iscritta nella nostra casa, la gratitudine che ti è dovuta. Approvo le tue proposte. Né la notte né il giorno t'ostacolino nell'esecuzione di quanto mi prometti: nessuna spesa d'oro o d'argento deve bloccarti, o la necessità di un esercito forte, in qualunque luogo debba comparire. Utilizza Artabazo, uomo che t'ho inviato; è di grandi capacità. Coltiva i tuoi e i miei interessi con la massima energia, in modo che producano a entrambi i più splendidi e preziosi frutti."
130. Pausania era anche prima una figura di prestigioso rilievo tra i Greci, per come aveva diretto e vinto la battaglia di Platea. Ma quelle righe, ricevute dal Re, esaltarono la sua superbia, sicché gli era diventato impossibile vivere da persona normale, secondo il costume tradizionale. Usciva da Bisanzio panneggiato in abiti persiani e in viaggio per la Tracia ammetteva la sola scorta di dorifori persiani ed egizi. Di gusto persiano erano anche le sue vivande a tavola. Non sapeva celare le inclinazioni della sua mente, le sue simpatie: perfino dai suoi atti esteriori, anche da quelli particolari e irrilevanti, traspariva e baluginava quali più orgogliosi disegni architettasse per le sue attività future. Era divenuto inaccessibile: tanto altezzoso e tirannico nel trattar con tutti senza distinzione, che nessuno lo poteva accostare. Per il profondo disgusto nato dalla sua condotta, molti alleati furono lieti di passare agli Ateniesi.
131. La notizia pervenne anche a Sparta, che prese un primo provvedimento d'immediato richiamo. Ma quello con la nave di Ermione prese subito il mare una seconda volta, senza avere ricevuto l'ordine dal governo, e insistette chiaramente con il suo consueto comportamento. Quando le forze ateniesi lo ridussero a fuggire da Bisanzio espugnata invece di rientrare a Sparta, si stabilì a Colono nella Troade. Laggiù, secondo le voci che ne trapelavano a Sparta, intratteneva relazioni poco chiare con la Persia: era evidente che il suo soggiorno era dovuto a scopi politici nient'affatto onesti. Gli efori decisero di far cessare lo scandalo: inviarono un araldo a consegnargli la scitala e a ingiungergli di seguirlo. In caso diverso, Sparta lo dichiarava nemico. Pausania, intendendo dissipare i sospetti addensatisi sulla sua condotta e convinto di poter dissolvere le accuse con offerte di denaro, rimpatriava per la seconda volta. In un primo momento gli efori lo incarcerarono (è lecito agli efori operare un arresto anche del re) ma con l'intrigo ottenne in seguito la libertà, ponendosi a disposizione di chi avesse desiderio di intentargli un processo sulla base di accuse concrete e precise.
132. Ma gli Spartani, sia gli avversari di Pausania sia in generale, la cittadinanza, non potevano contare su indizi sicuri e decisivi: eppure era indispensabile congegnare un'accusa su prove inoppugnabili, per poter punire un personaggio di famiglia reale e che ancora rivestiva la carica di re (era tutore infatti, in qualità di cugino, di Plistarco il vero re, figlio di Leonide, in età ancora minorile). Ma il suo disprezzo della legalità e l'eccessiva simpatia per lo stato straniero costituivano occasioni di pesante sospetto che non volesse contenersi nei limiti dell'ordine vigente. Sottoposero a indagine il precedente corso della sua esistenza, per scoprire se avesse già commesso qualche infrazione al sistema di vita allora in uso. Trovarono che sul tripode, dedicato qualche anno prima dai Greci a Delfi, come primizia del bottino persiano, aveva voluto, di sua personale iniziativa, che fosse inciso il seguente distico: "Annientò l'armata persiana, il capo dei Greci Pausania e a Febo questo consacrò a ricordo". Gli Spartani, fin da quell'epoca avevano già fatto cancellare quel distico dal tripode, e vi avevano inciso il nome delle città che, avendo collaborato alla disgregazione della potenza persiana, avevano dedicato il tripode stesso. Anche a quell'epoca, per il vero, il gesto di Pausania sembrò una palese irregolarità: l'ispirazione di quell'atto, analizzata e interpretata alla luce dei gravi sospetti che si erano andati, consolidando intorno alla sua figura, denunciò subito la sua analogia con l'atteggiamento spirituale mostrato da Pausania in più recenti circostanze. Serpeggiava l'indiscrezione, provata poi pienamente esatta, che organizzasse complotti con gli Iloti: aveva loro promesso libertà e diritti politici, se si fossero sollevati a un suo comando, e se gli avessero prestato l'appoggio necessario. Fu sporta qualche denuncia da parte degli Iloti: anche in questo caso, pur con la sensazione che quelle accuse erano fondate, gli Spartani decisero per il momento di non prendere misure straordinarie contro di lui. Aderivano all'uso, ormai invalso presso di loro, di non lasciarsi trasportare dalla fretta, di non deliberare qualche provvedimento irrimediabile su un personaggio spartiate, senza aver in mano prove effettivamente inconfutabili. Ma da ultimo, come si dice, l'uomo incaricato di consegnare ad Artabazo l'ultima lettera per il re, un tale Argilio, intimo di Pausania e fedelissimo, fa pervenire agli efori la sua denuncia. L'aveva stimolato una paurosa sensazione, nata dal considerare che nessuno dei messi precedenti aveva fatto ritorno. Decide di contraffare il sigillo per cautela, nel caso che la sua diffidente impressione sia vana, o che Pausania gli chieda la lettera per aggiungervi qualche riga. Apre dunque la missiva, e a confermare i sospetti, vi legge, in fondo, un'istruzione supplementare: la propria condanna a morte.
133. La lettera, scritta personalmente da Pausania, rappresentava per gli efori una prova consistente; pure, per averne una definitiva, vollero ascoltare con le proprie orecchie qualche frase pronunciata da Pausania in persona, che lo compromettesse apertamente. A questo scopo, di concerto con gli efori, l'uomo si recò sul Tenaro come supplice, eresse una capanna e con una parete divisoria ne ricavò due ambienti, in uno dei quali fece appostare alcuni degli efori. Udirono chiara ogni parola, in quell'incontro tra Pausania e il suo uomo. Pausania esordì chiedendo il motivo di quella supplica ed ebbe in risposta le rimostranze del suo interlocutore, per quegli ordini contenuti nella lettera, che lo riguardavano. Elencava distintamente ogni altro particolare, facendo notare che nei suoi uffici d'intermediario presso il re non lo aveva mai esposto. Eppure gli si riservava il bel privilegio d'esser messo a morte, come gli altri che lo avevano preceduto in quel compìto. Le frasi di Pausania, che riconosceva in pieno i suoi torti e conveniva su ogni punto, che pregava l'altro di non lasciarsi fuorviare dall'irritazione di quel momento, giunsero alle orecchie degli uditori. Come le sue assicurazioni di incolumità, se quello usciva dal santuario, e l'istanza di mettersi quanto prima in viaggio, senza pregiudicare le trattative in corso.
134. L'ascolto diretto degli efori questa volta fugò ogni dubbio: ormai incrollabilmente certi della sua colpa, predisposero la cattura di Pausania in città. Si dice che un attimo prima dell'arresto per via, Pausania intuisse dall'espressione dipinta sul viso di uno degli efori, mentre gli si accostava, lo scopo di quell'incontro. Un altro eforo gli avrebbe fatto un cenno impercettibile con il capo, per fargli intendere le loro intenzioni, spinto da un senso d'amicizia. Pausania comunque scattò di corsa verso il santuario di Atena Calcieca e riuscì a rifugiarvisi in tempo: poiché il recinto sacro era vicino. Sorgeva adiacente un edificio non ampio, in cui si precipitò, per avere almeno un riparo alle intemperie. Non si mosse più. Gli inseguitori non lo raggiunsero subito: fecero smantellare il tetto della costruzione e certi che si trovasse all'interno, ve lo rinchiusero murando le porte. Circondarono l'edificio e aspettarono di prenderlo per fame. Quando si accorsero che così incarcerato in quella stanza, era vicino a spirare lo trascinano all'esterno del recinto sacro. Respira ancora ma cade subito morto, appena fuori il santuario. Avevano già stabilito di precipitarlo nel Ceada, come usava con i malfattori: prevale però l'idea di dargli sepoltura più vicino. Ma il Dio, attraverso l'oracolo di Delfi, intimò agli Spartani di traslarne la salma nel punto stesso della morte (ancor oggi riposa infatti all'ingresso del santuario, come provano le iscrizioni di alcune stele). Ingiunse anche di espiare l'atto commesso, un sacrilegio grave, dedicando ad Atena Calcieca due corpi in cambio di uno solo. Furono così fatte erigere e consacrare alla dea due statue di bronzo, quasi a compenso di Pausania.
135. Gli Ateniesi, rilevando che anche il dio aveva giudicato il loro gesto un sacrilegio, imposero a loro volta a Sparta di espellerne i responsabili con le loro famiglie. Ambasciatori spartani giunti appositamente ad Atene, implicarono anche Temistocle nell'accusa di complotto con la Persia che aveva perduto Pausania. Risultava dall'analisi dei capi d'accusa raccolti contro Pausania: onde la loro ferma richiesta che Temistocle fosse egualmente punito. Gli Ateniesi si lasciarono persuadere (poiché egli aveva già subito l'ostracismo e abitava ad Argo in quel tempo, quando non si recava, di tanto in tanto, in altre località del Peloponneso). Mobilitarono un gruppo d'uomini, cui si diede istruzione di scovarlo, in qualunque luogo si trovasse, e ricondurlo ad Atene, con l'aiuto dei messi spartani che si dichiararono disposti a collaborare nella ricerca.
136. Una voce preavverte in tempo Temistocle, che lascia in tutta fretta il Peloponneso per passare a Corcira, contando sul debito di riconoscenza che aveva contratto con quel paese. Ma i Corciresi gli confessano che temono forte le rappresaglie spartane e ateniesi, se gli danno ricovero. Abbandona anche quel rifugio e si fa sbarcare sulla terra che si estende davanti a Corcira. L'incalzare sistematico degli inseguitori, informati via via di ogni spostamento, lo costringe, in una circostanza di particolare smarrimento a fermarsi presso Admeto, re dei Molossi, che gli è ostile. Costui però, temporaneamente, si trova fuori casa. Rivolge allora la sua richiesta d'ospitalità alla moglie del re: ne riceve il consiglio di prendere in braccio il loro figlioletto e di assidersi supplice presso il focolare. Ad Admeto, che non tarda molto a rientrare, Temistocle rivela la sua identità e l'implora, anche se ha avversato ad Atene le richieste che un tempo il re vi aveva avanzato, di non vendicarsi ora su di lui, profugo e inseguito. In quelle condizioni, anche un uomo assai meno potente di Admeto avrebbe agio di rovinarlo: è proprio invece di uno spirito generoso cercare la vendetta quando gli avversari sono in una situazione di parità. Inoltre gli s'era opposto in questioni concernenti interessi particolari, non la salvezza stessa della vita; Admeto invece, se lo avesse consegnato (svelò chi e con quale scopo lo perseguitava) lo avrebbe privato dell'esistenza.
137. A queste parole, il re lo fa levare, mentre ancora tiene in braccio il figlioletto, nell'atteggiamento stesso con cui se ne stava prima seduto e che rappresenta il più solenne modo d'implorare protezione. Quando si presentano, solleciti, Ateniesi e Spartani, Admeto non ha riguardo per le loro insistenti proteste e non consegna l'ospite. Soddisfa anzi il suo desiderio di raggiungere il re, facendolo scortare per via di terra fino all'opposto mare alla corte di Alessandro a Pidna. Trova qui una nave da carico, in procinto di salpare per la Ionia, e vi s'imbarca. Ma un fortunale li trascina proprio davanti a un campo di Ateniesi intenti all'assedio di Nasso. Temistocle si lascia prendere dal panico e rivela al comandante della nave (a bordo infatti la sua identità era ignota) chi sia in realtà e le ragioni della sua fuga. Se non lo condurrà in salvo, minaccia che sosterrà la tesi d'averlo corrotto e comprato con il denaro il passaggio sulla sua nave. Il provvedimento più sicuro è che nessuno scenda a terra, mentre non si può riprendere la navigazione. Se si mostra d'accordo, la sua gratitudine sarà adeguata e sostanziosa. Il comandante accetta le condizioni di Temistocle e dopo aver tenuto ormeggiata la nave un giorno e una notte al largo del campo ateniese, salpa per Efeso. Temistocle gli compensa il favore con l'oro (gli erano state fatte pervenire da Atene e da Argo, per opera di amici, tutte le sue sostanze), e direttosi all'interno, accompagnato da un Persiano della costa, manda una lettera al re Artaserse figlio di Serse, asceso da poco alla dignità del trono. Era questo il tenore di quella missiva: "Giungo ora presso di te, io che tra i Greci sono il principale autore delle disfatte più rovinose che si sono abbattute sulla tua famiglia: nel tempo in cui mi vidi obbligato a contenere l'aggressione del padre tuo. Ma più importanti risultano i miei meriti, dal momento che la sua ritirata avvenne in condizioni per me di sicurezza assoluta, per lui di estremo pericolo. Mi è dovuta quindi riconoscenza (seguiva nella lettera l'accenno al consiglio dato al padre, subito dopo Salamina, di ritirarsi subito, e il divieto, che Temistocle falsamente si attribuiva, di, tagliare i ponti in quell'occasione) ma, anche ora mi presento fornito di cospicue possibilità di esserti utile, inseguito dai Greci a causa dell'amicizia che nutro per te. Desidero soggiornare nel tuo paese per un anno, prima di comparire al tuo cospetto per svelarti il mio disegno".
138. Il re, secondo le voci che circolano, ammirò il suo piano e lo esortò a porlo in pratica. Temistocle impiegò il tempo del suo soggiorno a impratichirsi della lingua persiana e dei costumi di quel popolo, quanto poté. Al termine stabilito di un anno si presentò al re e conquistò presso di lui un'influenza superiore a quella di qualunque altro greco, parte per la stima di cui godeva anche precedentemente, parte per la speranza suscitata nel re di offrirgli soggetta la Grecia, ma principalmente per le molte occasioni in cui aveva fatto rifulgere la propria intelligenza. Era meritevole infatti Temistocle della più ammirata meraviglia, particolarmente per la straordinaria sicurezza con cui aveva imposto in molte occasioni il suo temperamento geniale. Doveva all'agilità innata del suo intelletto, libera da ogni preparazione di studio o riflessione scaturita dall'esperienza, la perspicacia potente con cui, dopo un fulmineo esame interpretava frangenti improvvisi e l'infallibile sagacia per cui ne individuava, nel futuro, anche le conseguenze più remote. Sapeva con precisione e chiarezza esplicare ogni aspetto delle azioni cui prendeva parte personalmente: su quelle di cui non possedeva diretta esperienza, era ben lontano dal non poter formulare un giudizio criticamente valido. Eccelleva nel presagire con notevole anticipo le proficue o negative conseguenze di un fatto, quando si celavano ancora per chiunque altro indistinte. Per concludere, in una parola, quest'uomo dal genio possente, dalla concentrazione istantanea fu ineguagliato nell'improvvisare in brevi attimi la soluzione per qualunque ostacolo. Morì di malattia: alcuni soggiungono che si sia dato la morte con il veleno, vedendosi nell'impossibilità di compiere le promesse formulate al re. Rimane di lui un monumento funebre nella piazza di Magnesia d'Asia. Era governatore di questa regione. Il re gli aveva donato Magnesia come "pane" (gli fruttava infatti cinquanta talenti l'anno), Lampsaco come "vino" (le sue campagne infatti godevano fama d'esser le più fertili di viti), Miunte come "companatico". Dicono i suoi parenti che le ossa furono traslate in patria, come aveva desiderato e che siano sepolte in Attica, di nascosto da Atene: sepoltura illegale, poiché egli era esule imputato di tradimento. Furono questi i casi estremi di Pausania spartano e di Temistocle ateniese, gli uomini di più fulgido prestigio, tra quelli della loro epoca, in Grecia.
139. Gli Spartani dunque, nella prima ambasceria diedero e ricevettero queste istruzioni relative alla cacciata dei sacrileghi. Poi con una serie di richieste, ingiungevano ad Atene di levare l'assedio a Potidea e restituire l'indipendenza ad Egina. Ma insistevano, nelle loro relazioni, a chiarire un punto: la guerra non sarebbe stata dichiarata se avessero abrogato la disposizione presa ai danni di Megara, vale a dire il divieto di usufruire dei porti del dominio ateniese e d'intrattenere scambi commerciali con l'Attica. Gli Ateniesi come non prestavano ascolto alle altre richieste, così non cancellavano quel decreto: accusavano anzi i Megaresi di coltivare il suolo sacro, dove i confini non erano determinati, e di offrire ricetto ai loro schiavi ribelli. Infine, giunse da Sparta un'altra ambasceria composta da Ramfia, Melesippo, Agesandro, i quali non si soffermarono sui temi consueti ma espressero solo queste parole: "Gli Spartani hanno volontà di pace; la pace può affermarsi a condizione che voi lasciate ai Greci l'indipendenza". Gli Ateniesi convocarono l'assemblea, e aprirono il dibattito decisi ad esprimere, dopo responsabile e completa riflessione, una risposta definitiva. Si presentarono numerosi oratori a sostenere opposte ragioni. Dichiaravano gli uni che la guerra era inevitabile, gli altri che il decreto su Megara non doveva costituire un ostacolo alla pace, e ne caldeggiavano l'abrogazione. Comparve a parlare anche Pericle, figlio di Santippo, il primo ateniese di quel tempo, valentissimo nella parola e nella pratica politica, e consigliò in questo senso:
140. "La mia convinzione, Ateniesi, rimane sempre invariata: non cedere di un palmo ai Peloponnesi. Eppure sono consapevole che gli uomini stentano a profondere nella realizzazione pratica della guerra quello stesso ardore che li ispira al dichiararla, poiché adattano i loro sentimenti al variare delle contingenze. Vedo che anche nella attuale occasione è mio dovere impartirvi consigli sostanzialmente identici e pretendo che quanti di voi condividono il mio sentire appoggino in futuro la deliberazione qui presa in comune anche se dovessimo incappare in qualche disfatta o in caso contrario, nell'eventualità cioè di un successo, non usurpino il vanto della sagacia politica. Poiché si può tranquillamente ammettere che il corso degli avvenimenti pieghi con scarti non meno imprevedibili che le intenzioni umane: perciò è nostra abitudine imputare alla fortuna quanto sfugge al controllo delle nostre facoltà logiche. La politica di Sparta ci è sempre stata nettamente ostile: ora più di prima. Il trattato contempla due punti qualificanti: le singole città si accordano sull'arbitrato, come strumento per dirimere le reciproche vertenze; entrambe le parti mantengono i territori attualmente in loro possesso. Ora, a dispetto della nostra offerta, Sparta non accetta l'arbitrato e preferisce cercare nella guerra una soluzione alle controversie, scartando il dibattito. Hanno perfino sostituito le loro consuete lagnanze con dei comandi. Tre ordini per la precisione: levare l'assedio da Potidea, concedere l'autonomia ad Egina, cancellare il decreto su Megara. Con quest'ultima missione ci ingiungono di lasciare l'indipendenza agli altri Greci. Fra voi nessuno pensi che si scenda in guerra per una motivazione futile, nel caso si decida di non abrogare la disposizione su Megara. Insistono continuamente proprio con questo tema: l'abrogazione scongiurerebbe la guerra. Badate a non lasciar sorgere in futuro ed attecchire nel vostro intimo un senso di colpa, come se aveste preso le armi per una causa di lieve importanza. Questo movente così futile impegna in realtà la vostra coerenza politica ad ogni livello, costituendone una prova sicura e definitiva. Cedete, anche di poco, a Sparta: si abbatterà su di voi, senza dubbio, un'imposizione più gravosa, perché si convinceranno laggiù che siete scesi a trattare piegati dalla paura; con un atto di fermezza, avrete posto decisamente in chiaro che con voi i rapporti si istituiscono da pari a pari.
141. "Deliberate subito: o accondiscendere, prima di subire qualche colpo, o prendere le armi. Risoluzione che a me pare la più proficua, senza cedere per nessun motivo, grave o futile che sia, e dominando, sciolti da ogni timore, i territori che ora occupiamo. Una rivendicazione di diritto, su qualsiasi oggetto, gravissimo o irrilevante, che sia imposta da un paese fornito di pari potenza e facoltà a un proprio vicino, eludendo la procedura regolare, provoca sempre, inevitabilmente, un medesimo stato d'asservimento. In materia di preparazione militare e di mezzi difensivi a disposizione delle due potenze in causa, state certi, seguendo punto per punto il mio ragionamento, che non ci troveremo inferiori. I Peloponnesi fanno i campagnoli: non possono contare su risorse finanziarie private o pubbliche. Non hanno esperienza di conflitti lunghi o sostenuti al di là del mare. Sono troppo poveri per resistere ad altro che a guerricciole di confine, subito sedate. Simile gente come può essere in grado di armare e equipaggiare navi? Nemmeno campagne terrestri, a breve intervallo di tempo l'una dall'altra, si possono permettere. I contadini non disertano facilmente il loro podere e tanto meno son disposti a pagar le armi di tasca propria. Aggiungete che si vedranno precluse le vie del mare. Le riserve di denaro sono il più fermo sostegno della guerra, non le contribuzioni coatte. Le masse contadine espongono più volentieri la vita in guerra, che il loro denaro: convinti di poter anche scampar vivi dallemischie, ma per niente sicuri che i loro risparmi non sfumino del tutto prima della pace, specialmente se la guerra si trascina, come per il solito, oltre ogni previsione. In un singolo scontro, Peloponnesi e alleati fronteggerebbero gli altri Greci in blocco: ma non dispongono dei mezzi per condurre una vera guerra, contro un nemico che disciplina la sua potenza bellica con metodi radicalmente diversi. Poiché non sono diretti da una decisione e un comando unitari; di conseguenza, difetta loro la rapidità di esecuzione. Inoltre dispongono tutti di parità nel voto, ma appartengono a stirpi diverse, con interessi quindi divergenti, che ognuno caldeggia: condizione in cui generalmente non si conclude mai nulla. Questi premono, per punire un loro privato nemico; quelli recalcitrano, per non patir danni in casa propria. Nelle loro rare assemblee sbrigano in fretta gli affari comuni; la maggior parte del tempo se ne va nel discutere questioni particolari. Ciascun membro del patto non si rende conto del danno che produce con la sua indifferenza: è convinto che qualche altro provvederà in vece sua. Questo rovinoso pregiudizio, generalmente diffuso, non consente loro di accorgersi che l'interesse comune della coalizione langue e decade.
142. "Sarà per lo più la scarsità di capitali a bloccarli, quando perderanno tempo per procurarseli: in guerra invece, le occasioni opportune non consentono indugi. Le loro piazzeforti erette entro i nostri confini e la forza sul mare non preoccupano: quanto alle prime, sarebbe già impresa ardua in tempo di pace armare una città in modo che ci resista, immaginate dunque in terra nemica, tenuto anche conto del fatto che noi disponiamo di fortezze non meno potenti piazzate nel loro territorio. Potranno dislocare una guarnigione: guasterebbero una parte delle nostre campagne, con razzie e incentivi alla diserzione, ma non basterà a impedirci di gettare teste di ponte fortificate sulle loro coste, e di devastarle per rappresaglia con la flotta, la nostra arma più micidiale. Dalla pratica del mare abbiamo accumulato più esperienza noi di guerra terrestre, che loro di tattica navale dai combattimenti di terra. Non sarà facile per loro dominare anche l'arte di battersi con le navi. Perfino voi, che vi allenate ad essa dal tempo delle lotte persiane, non la possedete ancora perfettamente. Come potrebbero distinguersi, in quest'arte difficile, uomini dei campi, non di mare, cui neppure è concesso di esercitarvisi con metodo, sistematicamente bloccati dalle vostre navi numerose? Contro una flotta esigua potrebbero anche arrischiare una offensiva, supplendo alla carenza tecnica con la spavalderia ispirata dalla superiorità di numero; ma contro una squadra potente che li costringa a restare ancorati, dovranno restare inoperosi e la mancanza d'esercizio li ridurrà ancor più maldestri e, di conseguenza, meno pronti ad osare. La marineria è un'arte, più di qualunque altra: non ammette d'esser coltivata per passatempo, quando capita. Esclude piuttosto ogni diversa pratica, che le si voglia svolgere a fianco.
143. "Se poi attingono ai tesori di Olimpia e di Delfi nel tentativo di sottrarci le ciurme forestiere, attratte da paghe più consistenti, sarebbe grave che non riuscissimo a contrastarli con successo imbarcandoci noi stessi, con il rinforzo dei meteci, sulle navi da guerra. In realtà un'operazione di questo tipo è alla nostra portata e, elemento ancor più decisivo, disponiamo, tra i nostri concittadini, di piloti e altri membri d'equipaggio più numerosi e preparati che tutto il resto della Grecia. Quando il pericolo sarà imminente, nessuno dei nostri mercenari sceglierà di sua spontanea volontà il rischio di vivere esule dalla propria terra, per schierarsi (sorretto da una speranza di vittoria senza dubbio più fievole) a fianco del nemico con il miraggio di pochi giorni di paga più lauta. Mi pare questa, in sostanza, la situazione del Peloponneso. La nostra invece, immune dalle deficienze che ho additato in quelli, può contare su altri e superiori punti.di vantaggio. Se invadono l'Attica con le forze di terra, salperemo contro il loro paese. Risulterà allora ben differente il peso strategico delle nostre azioni, che devasteranno una parte del Peloponneso, e le loro contro l'Attica intera. Poiché il nemico non potrà pacificamente annettersi altro territorio in compenso. Il nostro dominio è sconfinato: si estende sulle isole e sul continente: l'egemonia sul mare è vantaggio incalcolabile. Riflettete infatti: se fossimo isolani, quale popolo sarebbe più invincibile? E anche ora è indispensabile che la nostra condotta di guerra si uniformi il più possibile a questo assunto: abbandoniamo le campagne e le loro case, puntiamo alla difesa della città e al dominio sul mare. Il dolore per la desolazione dei campi non ci induca ad accettare lo scontro aperto con le truppe dei Peloponnesi, più agguerrite. (In caso di vittoria lotteremmo sempre contro un nemico non meno numeroso e una disfatta causerebbe l'abbandono da parte degli alleati, che sono la nostra forza: non si asterranno dalla rivolta, se non potremo marciare contro di loro). Non dovremo aver rimpianto per la rovina della terra e delle case, ma delle vite umane: quei beni non danno vita agli uomini, ma sono gli uomini che creano quei beni. Se ritenessi di potervi convincere, v'ordinerei d'uscir voi stessi a distruggere raccolti e case, per dimostrare al nemico che non vi piegherete mai, per salvare quei possessi.
144. "Sono in grado di sostenere la speranza della futura vittoria con molti altri argomenti; a patto che siate disposti a non ampliare il vostro dominio, mentre siete in lotta, e a non affrontare rischi superflui. Mi incute più preoccupazione la possibilità di un nostro passo falso, che l'accortezza strategica del nemico. Ma rimando la spiegazione di questi punti a un altro discorso, quando saremo in piena guerra. Licenziamo ora gli ambasciatori con questa risposta: riapriremo a Megara il mercato e i porti, a patto che anche Sparta non applichi più né ai danni nostri né degli alleati, le norme di legge relative al bando degli stranieri. Poiché nessuno articolo del trattato impedisce espressamente questo o quello. Concederemo l'indipendenza alle città della lega che la possedevano già quando fu stipulato il trattato, ma solo nel caso che anche gli Spartani rendano alle loro genti la facoltà di governarsi con costituzioni politiche che rispecchino le loro libere scelte non che si modellino sulle loro pressioni e a vantaggio di Sparta. Secondo le clausole del trattato, siamo disposti ad affrontare un arbitrato. Non attaccheremo, ma, attaccati, respingeremo il nemico. Questa è l'unica risposta corretta e dignitosa che la città di Atene intende fornire. Bisogna rendersi conto che la lotta è inevitabile. Tanto più veemente sarà il nostro slancio all'inizio tanto meno fieri avversari avremo contro. Dai rischi più gravi rifulge alla città e all'individuo l'onore più splendido. I nostri padri contrastarono i Persiani fino alla vittoria finale: eppure non disponevano di così imponenti risorse. Anzi, si videro obbligati ad abbandonare le loro esigue fortune: ma respinsero lo straniero, fidando più nell'intelligenza che nel caso, nell'indomabile coraggio che nel vigore delle armi E hanno elevato la potenza d'Atene a tali vette! Non dobbiamo mostrarci inferiori, ma respingere l'attacco nemico con ogni forza e cercare di lasciare ai nostri figli l'eredità di un dominio e d'un prestigio intatti."
145. Fu questa la sostanza del discorso di Pericle. Gli Ateniesi, persuasi che le sue direttive fossero le più brillanti per la contingenza politica che attraversavano, le ratificarono con il loro voto. Aderirono al Suo consiglio, modellando la risposta ufficiale agli Spartani sullo spirito complessivo del suo intervento e sulle singole considerazioni che aveva espresse e giustificate. Che cioè non avrebbero dato corso a nessuna delle intimazioni spartane e che erano invece pronti a cercare un accordo secondo il senso dei trattati, su una base di assoluta parità riguardo alle accuse che gravavano su di loro. L'ambasceria fece ritorno in patria: da quel momento non comparvero più in Atene ambasciatori di Sparta.
146. Furono questi i motivi di recriminazione e dissenso che vennero alla luce nei rapporti tra le due potenze, prima che si instaurasse lo stato di guerra. La tensione che lo precedette era la conseguenza diretta dei fatti di Epidamno e di Corcira. Le relazioni, però, non si interruppero del tutto in questo periodo: i rapporti erano anzi frequenti e non si ricorreva alla funzione mediatrice degli araldi. Ma la diffidenza tra loro era acuta: poiché quegli eventi significavano l'infrazione dei patti e fornivano motivo per lo scoppio di una guerra.
- Site Admin
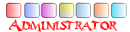
Grazie mille! :D
- nuovo iscritto

puoi indicare il passo che coincide con la tua versione? 
- Utente GOLD

Copyright © 2007-2025 SkuolaSprint.it di Anna Maria Di Leo P.I.11973461004 | Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione, anche parziale
web-site powered by many open source software and original software by Jan Janikowski 2010-2025 ©.
All trademarks, components, sourcecode and copyrights are owned by their respective owners.
